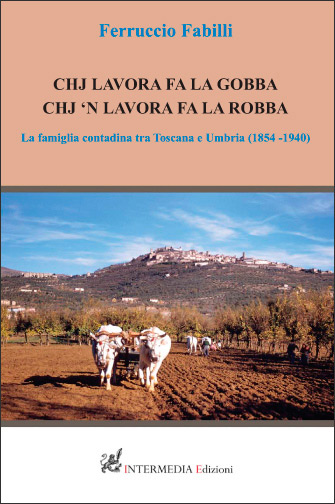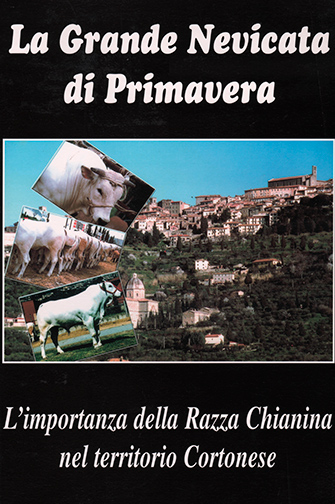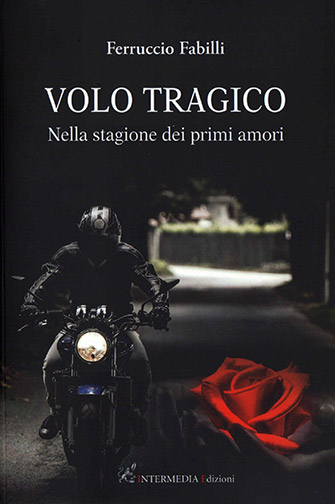Messaggio più recente
Priamo Bigiandi, minatore e deputato, storia irripetibile del Novecento, di Giorgio Sacchetti
Per i curiosi di storia aretina – nel breve spazio di tempo l’uno dall’altro, nella sala provinciale dei Grandi concessa dal presidente Roberto Vasai – sono stati presentati due libri sul disciolto PCI tra loro collegati: l’autobiografia politica di Tito Barbini, e Vite di Partito – Traiettorie esistenziali nel PCI togliattiano – Primo Bigiandi (1900-1961) di Giorgio Sacchetti, Edizioni Scientifiche Italiane. A prescindere dalla volontà degli autori, sono molti i legami tra i due libri, pure scritti con finalità e in tempi diversi. Innanzi tutto nella sequenza temporale. Quest’ultimo saggio, scritto da uno storico estraneo alla vita di quel partito, racconta le vicende del minatore-deputato Priamo Bigiandi dagli anni Venti al PCI togliattiano, mentre l’autobiografia di Barbini chiude il cerchio sui comunisti aretini nel periodo berlingueriano. Inoltre, le storie, collocate in periodi diversi, rivelano una serie di continuità ideali insieme ai criteri selettivi per i dirigenti politici e per gli eletti a cariche pubbliche.
Priamo Bigiandi entra nell’agone politico da giovane minatore, partecipando a lotte sindacali in difesa dei lavoratori e a vicende antifasciste negli anni Venti, a Cavriglia. (Centro minerario valdarnese, riferimento dell’antifascismo aretino insieme a Renzino, per gli scontri violenti fisici e ideali di cui furono teatro, e i conseguenti riflessi sull’immaginario collettivo associato ai due paesi). In un crescendo di esperienze, compreso il carcere, Bigiandi diviene leader nel centro minerario di lotte sindacali e nella resistenza al regime; finita la guerra, si prodiga nella ricostruzione democratica degli enti locali (da sindaco di Cavriglia e amministratore provinciale) fino a giungere al parlamento. Parlamentare formatosi “all’università” della miniera, del carcere e dell’attivismo sindacale e politico. Un “sovversivo” che con le sue idee e le sue battaglie raggiunge apici istituzionali.
Nell’enunciare i capitoli del libro, Sacchetti scandisce le tappe di una vita per alcuni versi singolare, ma, per altri, comune a generazioni di militanti politici del tempo. La sovversione sociale come scuola di vita; Per Stalin e per la democrazia: la ricostruzione dal basso; Nel nome della classe operaia: dalla parte dei minatori; Deputati di Togliatti: il partito-apparato nella guerra fredda; Ideologia del progresso e questione mineraria; Federazioni di provincia: un partito-sagrestia.
Il taglio storico – nel ricostruire fatti e personaggi – inserisce la vicenda provinciale nel più vasto contesto nazionale. Senza trascurare i caratteri emotivi propri di un Priamo combattivo fino alla fine dei suoi giorni, che ritenne la ragione di partito insopportabile ingiusta e irrispettosa verso la sua persona. Come ha testimoniato la figlia Alba – durante la presentazione del libro -: il babbo non soffrì tanto lo sgarbo di non essere rieletto deputato, quanto la freddezza e l’indifferenza personale e collettiva degli uomini di partito nel non ricandidarlo. Come si sa, la scelta o meno di ricandidare al parlamento non era sancita da regole certe, se non che per alcuni non c’erano impedimenti a rinnovarne la candidatura più e più volte, mentre per altri vigeva il limite dei due mandati. Evidentemente, valutazioni di merito o demerito erano piuttosto aleatorie. Cosicché le carriere erano la risultante di ambizioni personali, capacità di stare nell’agone politico e di aggregare consensi, partendo dalla più sperduta sezione fino ai massimi vertici di partito. Un’alchimia persino difficile da raccontare, ma, grosso modo, era questa.
Come spettatore – alla presentazione dei libri di Barbini e Sacchetti – ho notato il diverso spirito nei partecipanti. Nel caso di Barbini, gran parte dell’uditorio condivideva ansiosamente lo stesso spaesamento politico seguito alla trasformazione del PCI in altri soggetti politici. Fino a giungere alla radicale diluizione dei principi basilari di quel “vecchio” partito. Se non addirittura al disconoscimento di ogni eredità politica ascrivibile all’area comunista – pur confluita in massa nel nuovo soggetto partitico – all’interno del PD. Partito erede anche del PCI, almeno in linea evolutiva e nell’immaginario collettivo, in quanto il PD è l’esito della “fusione a freddo” tra componenti politiche diverse.
Ma tornando ai sentimenti scaturiti alla presentazione e l’interesse suscitato all’uscita del libro hanno sorpreso l’autore stesso, Tito Barbini, che l’aveva stimato più che altro espressione d’un bisogno intimo di fare il punto su esperienze vissute, sottovalutandone l’impatto pubblico. Anche se conclude il libro con un interrogativo non solo suo: quanto e cosa si potrebbe/dovrebbe preservare della esperienza politica sua, e di quanti l’avevano preceduto in battaglie simili di emancipazione popolare e di giustizia sociale? Quesito presente nella coscienza di milioni di italiani di “sinistra”, che stentano a ritrovarsi non solo in una classe politica squalificata ma anche nella generalizzata tendenza all’ammucchiarsi al centro politico.
Mentre alla presentazione del libro di Sacchetti – anch’esso impregnato di conflitti a favore di quelle che un tempo si definivano classi subalterne in nome di principi perenni: egualitari e libertari – l’interesse del pubblico si è incentrato sulla presa d’atto di vicende storiche concluse insieme alla condivisione, tra autore e presenti, del resoconto su dinamiche interne al PCI nei rapporti personali e sui metodi organizzativi invalsi, ivi compresa la progressione o l’interruzione delle “carriere”. (Aspetti ricostruiti da Sacchetti in modo convincente, per l’approccio da storico estraneo, non certo indifferente, alle vicende narrate). Stesse fredde e imponderabili dinamiche selettive nelle loro molteplici varianti, applicate, credo, nella maggior parte dei partiti di massa italiani nel periodo post-bellico. E, sempre a mio avviso, criteri perduranti fino alle più recenti relazioni intrapartitiche – caratterizzate da vincoli di subalternità degli eletti ai leaders – dovute al fenomeno dei nominati, frutto di leggi elettorali ritenute illegittime dalla stessa Corte costituzionale.
www.ferrucciofabilli.it
Ada Negri e Ettore Patrizi, una storia d’amore intrecciata con pagine di storia italiana
 Il libro “Ettore Patrizi. Da Montecastrilli a San Francisco” di Giacomo Pellicanò, Intermedia Edizioni, racconta un Ulisse contemporaneo – nel libro denso di testo, note, fotografie, documenti, esito d’una ricerca accurata in Italia e negli Stati Uniti.
Il libro “Ettore Patrizi. Da Montecastrilli a San Francisco” di Giacomo Pellicanò, Intermedia Edizioni, racconta un Ulisse contemporaneo – nel libro denso di testo, note, fotografie, documenti, esito d’una ricerca accurata in Italia e negli Stati Uniti.
Quell’Ulisse, senza legami matrimoniali in Italia, tornerà occasionalmente nella sua Itaca, avendo spostato altrove il baricentro della propria vita.
Intellettuale curioso, attratto dalle novità prodigate dal suo tempo, vi si getta con passione. Eravamo in piena esplosione dell’epoca contemporanea, dal dinamismo globale mai visto prima. Per un giovane portato alla politica, al giornalismo, amante della bella musica, a fine Ottocento, quale meta migliore di Milano? Città guida, nel bene e nel male, del progresso economico, politico e culturale italiano.
Nella formazione del giovane Ettore Patrizi, laureando in ingegneria, furono essenziali le eccezionali opportunità d’incontri eminenti con politici, giornalisti, musicisti, artisti, letterati e, non ultimo per importanza, l’incontro con Ada Negri grande amore della sua vita. (Non sta a noi dire se per lui fu il più grande amore, per lei lo fu quasi per certo). Quel tenero legame sentimentale, capace nei giovani in molti casi di sviarli da aspirazioni avventurose, non riuscì a distogliere Ettore dallo spingersi da solo fino alle frontiere più remote del Nuovo Mondo, nell’estremo west di San Francisco. Senza, però, tagliare il cordone ombelicale con la madre patria, sempre presente nel suo attivismo giornalistico e di operatore culturale. Infatti, pur saltuariamente, fece la spola tra America e Italia per tutta la vita (morto ottantenne) per coltivare interessi, passioni, legami familiari e sentimentali, descritti nel libro di Pellicanò con meticolosa abbondanza di particolari.
Nato in una famiglia istruita e benestante, già a Montecastrilli, Ettore s’appassiona alle sofferenze dei più deboli, ed è protagonista della nascita d’una Società Operaia (1883). A Milano, grazie all’attivismo politico e all’esperienza giornalistica presso importanti testate cittadine, intreccia relazioni con personaggi famosi vicini ai suoi ideali democratici radicali, socialisti e repubblicani. Ettore era un idealista vero. Basti considerare gli svantaggi conseguenti a essere repubblicano in epoca monarchica, per di più radicale e socialista, cioè coinvolto negli ideali sociali e istituzionali più “rivoluzionari” del tempo: a fianco delle classi subalterne, a favore di una prospettiva laica e repubblicana dello Stato, indipendente dall’influenza della Chiesa cattolica.
Zelante collaboratore di Ernesto Moneta – unico Nobel italiano per la pace -, quale segretario dell’Associazione Lombarda per la Pace, per Ettore quell’esperienza fu altrettanto “sovversiva”, rivelatrice dei suoi radicali sentimenti filantropici – a fine Ottocento -, in piena espansione imperialistica dei maggiori stati europei, e nella sorda incubazione di nazionalismi che di lì a poco avrebbe portato l’Europa alla micidiale carneficina, mai vista prima d’allora, della Grande guerra.
Durante lo svolgimento di lavori ingegneristici – prima ancora della laurea – incontrò Ada Negri, una “nuova Fata uscita dalle boscaglie del Ticino, dalle quali trabocca tanta passione d’amore e di bontà per l’umanità intera, per i miseri tutti e per i militi e le vittime del lavoro in modo particolare”, scrisse, Ettore, raccontando il primo incontro con la poetessa. Nella quale trovò subito una comune sensibilità umanitaria, che, aggiunta a “due occhi grandi, neri, incantevoli e pieni di pensiero”, fece scattare quella scintilla d’amore capace di legare due persone per la vita intera. Anche se un’altra passione irresistibile fremeva in animo a Ettore: visitare gli Stati Uniti; che poi, quella visita, si trasformò in scelta definitiva. Ada capì la forza attrattiva esercitata da quel lontano Stato nel giovane democratico, per le sue istituzioni repubblicane e per l’anelito di libertà che si era radicato nel nostro paese, invitandolo lei stessa ad “arrischiarsi”. “Gli dico sempre: il mondo è di chi lo piglia. Ci vuol coraggio e slancio per dominare l’avvenire”. Coraggio e slancio non mancarono a Ettore, che partì (nel 1893) lasciando la fidanzata implorante di portarla con sé, “ma con dolcezza, le feci capire che sarei ritornato presto. Andavo a vedere paesi nuovi e meravigliosi, di cui si esaltavano la libertà, la civiltà, le imprese virili e gigantesche ed i progressi parabolici e fantastici”. Gli innamorati mantennero un’affettuosa corrispondenza, sebbene Ada già presagisse quel distacco definitivo; a cui lei, almeno nelle intenzioni, non avrebbe voluto rinunciare: “sempre, dovunque, fra grandezze ed onte,/ anche lungi da me, tu resterai mio”, scriveva nella lirica inedita Mio.
Giacomo Pellicanò – riportando in questo libro brani di quella corrispondenza e delle liriche di Ada Negri, alcune appena abbozzate nell’impeto sentimentale -, fa capire di avere attinto a fonti riservate e inedite, delle quali forse più avanti ne farà una più estesa presentazione in un altro libro. Il materiale che già offre, però, è sufficiente a stimare il grado di coinvolgimento amoroso tra Ettore e Ada, le cui vite, infine, si separarono. Salvo brevi parentesi di nuovi incontri favoriti da situazioni fortuite, che riaccesero una fiamma diversa da quella giovanile, ma che non si spegnerà più, con pieghe emotive più partecipate e dolenti in Ada, perlomeno stando agli scritti.
Ettore, nel Nuovo Mondo, dirigendo “L’Italia – La voce del Popolo” realizza con successo le sue aspirazioni. Giornalista, fonde l’amor patrio con la difesa dei diritti e della dignità degli emigrati italiani. Di una Nazione che gli occhi del mondo vedono piccola, mentre per lui è grande per cultura e valori del suo popolo. Temi sui quali spende colonne infinite di piombo, riscattando gli emigranti spesso discriminati, mentre lui ne dimostra operosità, ingegno e onestà nel lavoro. Battaglie di lunga durata che mai lo scoraggiarono, sospinto nelle sue convinzioni sociali e patriottiche anche da eventi che lo colpirono particolarmente: l’Italia vittoriosa nella prima guerra mondiale, e l’avvento del fascismo. Che gli parve il provvidenziale elemento propulsore d’una Italia turbolenta e incerta nel destino. D’altronde simpatie fasciste, negli Stati Uniti, furono condivise anche dai vertici governativi: ricordiamo l’accoglienza trionfale dei trasvolatori italiani guidati da Balbo, accolti con ogni onore per le strade americane; ma, durante la seconda guerra mondiale, le stesse simpatie costarono a Ettore l’allontanamento da San Francisco e dal giornale, in seguito a maldicenze messe in giro artatamente da certi nemici personali. Per quanto, nel 1943, avesse ottenuto la riabilitazione, quell’allontanamento con infamia non giovò certo alla salute e al morale di Ettore, oramai quasi ottantenne.
Oltre la passione politica e giornalistica, lui s’era portato dall’Italia l’amore per la musica lirica; dispiegato anche in America da cronista e promotore infaticabile di eventi musicali. Ospitò nell’adottiva città di San Francisco, musici, cantanti, direttori di orchestra, sconosciuti e famosi. Tra i numerosi ospiti ebbe Mascagni e Caruso.
Colto, idealista, impegnato, generoso e onesto coi collaboratori come coi musicisti che accolse e favorì loro stagioni di successi e guadagni insperati. Sempre nel sottofondo patriottico e democratico, dedicato ai connazionali esuli che trovavano nel suo giornale il fulcro del riscatto e del rispetto. Egli stesso, in difficoltà finanziarie, colse, nel miglior modo, le opportunità offerte dal paese adottivo, dove, dopo grandi cadute, ai singoli e alla collettività, veniva dato modo di risorgere dalle macerie. (Ricordiamo il terremoto che devastò San Francisco e il crollo di Wall Street del ’29).
La vita di Ettore, non scevra da delusioni e dolori personali e familiari, fu caratterizzata dallo stesso ottimismo del giovane partito da Montecastrilli, attratto dal dinamismo economico e delle idee, dapprima in una Milano faro culturale politico e imprenditoriale di un’Italietta che ambiva star al pari dei grandi, e, infine, a San Francisco, la più occidentale delle città statunitensi, altrettanto dinamica in imprese culturali e ricca di un’economia derivante da generose risorse naturali e ambientali. Dov’egli fu capace di fondersi con passione nello spirito dei compatrioti emigrati, occupati nei lavori più disparati, eccellendo in attività come l’agricoltura e l’edilizia.
Più tormentata, almeno spiritualmente, fu la vita di Ada Negri, che dalle sofferenze – e la rottura del legame con Ettore fu senz’altro tra le più dolorose – trasse ispirazione poetica, rendendo dignità letteraria a visioni e sentimenti al femminile che finalmente s’imposero prepotenti nell’arte, nella cultura, nella politica. Visioni e sentimenti per lo più immutati nel tempo, ma repressi e di rado emersi in forme artistiche, per quanto intensamente vissuti dalle donne, come loro son capaci di esprimere e perseguire. Perciò, trasportati nelle avvincenti pagine di storia recente, un’idea esce rafforzata dal libro di Giacomo Pellicanò: i nuovi interpreti (giornalisti, letterati, artisti,…), che irrompono nella storia civile recente, portano pure una loro peculiarità di genere. Così, mentre in Ada Negri prevale la sfera affettiva in Ettore Patrizi l’azione e, può darsi anche, che tale diversità spieghi la loro duratura relazione.
www.ferrucciofabilli.it
UMBERTO MORRA aristocratico gentile dalla vita “ribelle”
 Il conte Umberto Morra di Lavriano e della Montà si rese popolare a Cortona per due gesti clamorosi: quando, nel plebiscito del 1934, deposta nell’urna la scheda contraria al regime, apostrofato dal segretario del fascio: “Conte, ha sbagliato scheda!” rispose deciso: “E’ lei a sbagliare!…” scampando olio di ricino e manganello, perché ritenuto vicino alla casa reale: al battesimo ebbe padrini re Umberto I e regina Margherita. L’altro fatto, non meno singolare per generosità, fu alla morte, allorché lasciò ogni avere in dono: ai domestici la villa di Metelliano e i poderi ai contadini che ci vivevano. Anziano, in condizioni finanziarie ristrette, non si disfece di quei beni – che gli avrebbe consentito miglior agio – quale segno estremo d’altruismo.
Il conte Umberto Morra di Lavriano e della Montà si rese popolare a Cortona per due gesti clamorosi: quando, nel plebiscito del 1934, deposta nell’urna la scheda contraria al regime, apostrofato dal segretario del fascio: “Conte, ha sbagliato scheda!” rispose deciso: “E’ lei a sbagliare!…” scampando olio di ricino e manganello, perché ritenuto vicino alla casa reale: al battesimo ebbe padrini re Umberto I e regina Margherita. L’altro fatto, non meno singolare per generosità, fu alla morte, allorché lasciò ogni avere in dono: ai domestici la villa di Metelliano e i poderi ai contadini che ci vivevano. Anziano, in condizioni finanziarie ristrette, non si disfece di quei beni – che gli avrebbe consentito miglior agio – quale segno estremo d’altruismo.
Riservato, generoso, gentile, cultura vasta in un’intelligenza sopraffina, poliglotta,… visse intensamente (pur affetto da fastidiosa zoppia causata da tubercolosi ossea) e viaggiò molto: in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, seguendo le sue passioni. Trovar fondi per alleviare la miseria delle popolazioni vittime della guerra; assistere militari feriti e badare al rispetto delle condizioni dei prigionieri di guerra; coltivare la sete di conoscenza intrattenendo infinite amicizie con persone di cultura, artisti, politici,… aiutandoli se in difficoltà e condividendone insaziabili aneliti libertari e avversione alle ingiustizie, senza distinzioni tra cattolici, liberali, socialisti, marxisti, anarchici,… E’ opinione comune che Umberto Morra acquisì quel suo stile particolare di vita grazie all’amicizia fraterna con Piero Gobetti.
Cattolico (tutta la vita), allo scoppio della prima guerra mondiale – vicino ai nazionalisti de La Voce – vi partecipò volontario nonostante la zoppia; assegnato alla Casa del soldato come assistente ai feriti, si rese conto dell’immane offesa al genere umano causata dalla guerra; e da quell’esperienza uscì disgustato dalla politica, in toto, disilluso anche dal colpo di stato fascista, ideologia che gli era parsa espressione d’un rinnovato liberalismo, fino alla Marcia su Roma. Collaboratore della rivista “La Rivoluzione Liberale”, l’incontro con Gobetti fu decisivo nel fargli assumere come proprie categorie ideali – mai più abbandonate – trasmesse da Piero: “una concezione volontaristica della vita che accettasse il proprio tempo abbandonando pessimismo e nostalgia reazionaria; che si impegnasse anche in condizioni avverse e senza certezza di vittoria con un progetto mirato a un esito rivoluzionario; che concepisse la rivoluzione liberale come rivoluzione essenzialmente morale interiore, e il liberalismo come metodo, processo e aspirazione piuttosto che come teoria e sistema” (in Dizionario biografico degli italiani, Enciclopedia Treccani). In tal liberalismo non sistematico, Morra fece convivere liberalismo e cattolicesimo con simpatie azioniste, socialiste, comuniste, anarchiche, … sviluppate nel tempo su aspetti utili a risolvere problemi contingenti. Distanza abissale da opportunismi politici, non avendo, lui, perseguito mai tornaconti personali. Anzi, sostenne materialmente persone in difficoltà, ospitandole o nascondendole in villa a Metelliano; buen retiro e porto franco a cui attinsero tanti senza distinzione di credo, che, ricordarli tutti, sarebbe un ampio viaggio nella cultura italiana del ‘900.
Pubblicista e conferenziere a sostegno dei diritti umani e dell’equità sociale, scrittore raffinato (pubblicò un bel libro di viaggi, Inghilterra, e i non meno famosi Colloqui con Barenson – eccellente esperto d’arte, riservato, che l’elesse a suo memorialista – iniziò, senza concluderla, una Biografia di Piero Gobetti pubblicata postuma,…); per breve periodo fu capo gabinetto del ministro Cianca, azionista; nell’immediato secondo dopoguerra, a Cortona, svolse attività politica d’intesa con Pietro Pancrazi, sostenendo tra l’altro la marcia della pace Camucia-Cortona promossa dall’amico Aldo Capitini, contro la minaccia della guerra atomica… Parrebbe incredibile tanto dinamismo col suo handicap. Così come, vivendo in agiate condizioni economiche, avrebbe potuto optare per ozi tranquilli e dedicarsi ai piaceri. Mentre invece, nell’apparente mitezza, visse “La vita da ribelle”, com’indica il titolo del libro dedicatogli da G. Benzoni. Spirito ribelle in netto contrasto con la vita del padre, fedele e intransigente servitore dello Regno: il generale Roberto Morra – brutale e spietato – represse nel sangue, con centinaia di morti e prigionieri, i moti dei Fasci siciliani, finendo ambasciatore d’Italia a San Pietroburgo, dove il piccolo Umberto contrasse la tubercolosi ossea. A fine anni Settanta, fu conferita a Umberto Morra la cittadinanza onoraria di Cortona, nato a Firenze (1897) ma vissuto a lungo a Cortona.
Lo conobbi di persona l’anno prima della sua morte (1981): affabile e intelligenza straordinaria. Ricordo il mio imbarazzo al primo incontro. A Follonica. Con Alfredo Gnerucci, lì per iniziare la collaborazione, a tutt’oggi duratura, con la Fondazione Feltrinelli che in quella città organizzava un convegno internazionale di studi su Trotskij. Vicini alla sede del convegno incontrammo Umberto Morra, sorretto da stampelle, nella stessa direzione. Pronti, gli offrimmo un passaggio in macchina…ma forse era meglio non averlo disturbato per quel breve tratto, vedendone le difficoltà con cui salì e scese dall’auto… Con Giustino Gabrielli fui ospite a pranzo del “Conte” o “Professore”, come rispettosamente lo chiamavano. E lo ricordo presente nella sala del Consiglio Comunale, a salutare un amico di lunga data: il prof. Alessandro Passerin d’Entrèves, filosofo e storico del diritto tra i più noti. In altra occasione, Morra ci favorì l’incontro col filosofo Norberto Bobbio e lo storico Massimo L. Salvatori. (L’amicizia tra Bobbio e Morra è fissata nel disegno – anni Trenta – del giovane Renato Guttuso, ospite a Metelliano con Guido Calogero e Aldo Capitini, antifascisti del movimento Giustizia e Libertà).
Assillati da vortici oscuri (guerre, crisi economiche, disoccupazione, immigrazione, …) orfani di spiriti liberi e “ribelli” alla Umberto Morra, scorgiamo con maggiore difficoltà cosa oggi corrisponda davvero agli universali valori di giustizia e libertà.
www.ferrucciofabilli.it
Il dialetto di Tuoro sul Trasimeno entra nel Vocabolario di Giuseppe Zucchini
L’impiego per tanti anni in uffici pubblici a Machiavelli ispirò Il Principe, classico della scienza politica, a Dante Alighieri la Divina Commedia, così come sarebbe lunga la lista di autori che, approfittando di quel particolare osservatorio, han raccontato la propria gente e il proprio territorio nelle espressioni e nei modi del tempo. Sebbene nel trasformare l’esperienza in narrazione compiuta e significante – e non chiacchiere dozzinali – è necessario talento, dimostrato da Giuseppe Zucchini (quasi quarant’anni impiegato nel Comune di nascita) scrivendo il Vocabolario del dialetto di Tuoro sul Trasimeno, Lombardi Editori. Che si aggiunge al migliaio di certosini lavori simili svolti nel nostro stivale, nell’intento meritevole di fissare su carta forme lessicali tipiche d’un luogo e d’un tempo storico, prima che scompaiano o evolvano (oggi in fretta) in altri linguaggi omologanti grazie ai computer, smartfone e televisione. Del migliaio di autori benemeriti ricordiamo don Sante Felici per il Vocabolario cortonese (1985) probabile spunto per Giuseppe Zucchini.
Diversamente dai dizionari della lingua nazionale, consultabili a scopo istruttivo e/o per l’uso corretto delle parole in un testo o discorso, il vocabolario dialettale è l’esplorazione nella vita, nelle relazioni umane, nella storia e tradizioni d’una porzione di territorio in cui le persone hanno un loro tipico modo di esprimersi, usando parole, gesti e mimica. Modi espressivi dei quali però possiamo trascrivere solo le parole. Delle quali sappiamo la forza: le parole sono più taglienti d’una spada! Pronunciate anche nel lessico dialettale, anzi, capita frequente attingere al dialetto quando si vuol metter enfasi su certi sentimenti: scherzosi, affettuosi, spregiativi…
Nel libro di Zucchini diverte scorrere, anche a casaccio, le centinaia di lemmi codificati ed esemplificati, trasformati in un’infinita narrazione in vernacolo di vissuto quotidiano. Prendiamo ad esempio: “Badarellàsse,- v. rifless: divertirsi, trastullarsi; movete, n te badarellè ‘muoviti, non ti trastullare’” sembra quasi che l’amico Beppe mi stia spiando, vedendomi preso dal suo spassoso e intelligente lavoro, e cerchi di darmi una pénta per completare questa recensione. “Pénta – peténza (arcaico) s.f.: spinta; con na pénta l ha fatto scollè ‘con una spinta lo ha fatto cadere’ m ha dèto na peténza ‘mi ha dato uno spintone’”. Tante voci del Vocabolario di Zucchini a un cortonese non sono estranee. Anzi, in gran parte sono le stesse usate in territorio cortonese che condivide con Tuoro un lungo confine geografico permeabile a scambi e condivisioni – insieme ai lemmi – di amicizie, affari, e legami parentali. La spiegazione dei processi culturali sottesi al dialetto sono approfonditi nel libro in testi aggiunti a corredo da Antonio Batinti, Ermanno Gambini, Antonello Lamanna, in veste di collaboratori con l’Autore, che qualificano il libro rendendolo strumento scientifico e divulgativo al tempo stesso. Opera aperta a futuri sviluppi, perché – come scrivono – sul linguaggio (di per sé in perpetua mutazione) si fanno continue scoperte che si aggiungono a quanto già si sa, grazie anche a contributi multidisciplinari che arricchiscono gli studi linguistici su quest’area. “Questa zona umbro-toscana ha svolto, durante i diversi periodi storici, un ruolo importante nell’attraversamento bidirezionale da nord a sud e da ovest ad est della penisola, e, come punto di incontro di influenze diverse, ha avuto vicende linguistiche, condizionate da quelle politiche, assai complesse”, scrive Antonio Batinti (docente di Fonetica e Fonologia e di Dialettologia italiana) nel saggio introduttivo. Zona in cui si sono incrociati linguisticamente il perugino, il cortonese, l’aretino, l’alto val tiberino. Così scopro da Batinti che lo “scempiamento pretonico” (non si tratta di azione cruenta su preti grassi) accomuna il toreggiano al cortonese quando le consonanti si scempiano prima dell’accento di parola: acattone per accattone, arosto per arrosto, capèllo per cappèllo,.. e scopro tante altre comuni espressioni dialettali che rendono popolare l’interesse per il Vocabolario del dialetto di Tuoro sul Trasimeno, in quanto travalica l’area geografica indicata nel titolo e ben s’integra col Vocabolario Cortonese di don Sante Felici.
Altre somiglianze, tra cortonese e toreggiano, riguardano la stratificazione sociale, i mestieri praticati e la presenza di cognomi ai primi dell’Ottocento (di cui tratta Ermanno Gambini) per le loro caratteristiche: perduranti a lungo negli stessi luoghi, in cui le persone si conoscevano più per soprannome che per cognome e nome. Zucchini dedica un capitolo all’inventario dei soprannomi (definendolo in corso d’opera) espressioni d’ironia popolare fino al cinismo (“La miglior filosofia consiste nel giudicare il mondo conciliando un gaio sarcasmo con un disprezzo indulgente” – scriveva N. de Chamfort). Zucchini non fa sconti neppure a sé stesso – al quale è stato appioppato il nomignolo di Zeppone – mettendosi in ordine alfabetico con altre decine di paesani che rispondono ai soprannomi di: Bàcama, Bàcara, Bacco, Bachiòrre, Bacìllino, Badièle, Baffìno, Baràcca, Batòcchio, Bélvo, Beppélla, Beppone, Bòmber, Bomba, Bombo, Bringuellone, Brunchìno, Bubi, Buccìno,…
Studi recenti sul lessico linguistico (Alinei, Benozzo, Galloni), nella sua millenaria continuità e variazione, tendono a spostare le origini della lingua a 2 milioni e mezzo fa (epoca dell’Australopiteco) anziché ai 50 mila dell’epoca in cui l’Homo sapiens sapiens colonizzò l’attuale Eurasia, confermandosi fin dal paleolitico, la parola, formidabile strumento fondante della civiltà umana. Parola della cui vitalità Giuseppe Zucchini ne ha fatto rappresentazione puntuale e preziosa, nell’epoca e nel paese in cui è vissuto, codificando e anatomizzando il proprio dialetto a imperitura memoria. Suscitando curiosità nei suoi compaesani intervenuti in massa alla presentazione del Vocabolario riempiendo all’inverosimile il Teatro dell’Accademia, sabato 13 agosto.
www.ferrucciofabilli.it
Il libro “Eravamo un paese per giovani – Un selfie per il Risorgimento italiano” è come un romanzo di storie giovanili di “eroi” ed “eroine” risorgimentali

Anche il miglior saggio storico stenterebbe a invitare alla lettura giovani liceali o universitari, al di fuori dei libri curricolari. Inutile sdegnarsi, è la realtà. Per quanto i preliminari Risorgimentali furono intriganti: dagli iniziali generosi tentativi nei vari staterelli italiani di ottenere Statuti liberali, ai moti carbonari, agli esordi di battaglie nazionaliste indipendentiste coniugate o meno con le prime lotte sociali. Molti protagonisti finirono tragicamente: uccisi, prigionieri, in miseria anche se d’elevata estrazione sociale. Rimasti impressi nelle nostre memorie adolescenziali – Silvio Pellico, Fedele Confalonieri, Ciro Menotti, Carlo Pisacane, i martiri di Belfiore, i fratelli Bandiera,…- come “eroi”, lontani nel tempo, ma capaci di suscitare simpatie.
La premessa piuttosto sconsolante sul versante lettori non ha intimorito due Autori intenzionati a rinverdire memorie scolastiche nel libro “Eravamo un paese per giovani – Un selfie per il Risorgimento italiano”(Intermedia Edizioni). Determinati a cogliere particolarmente l’attenzione giovanile, hanno escogitato una formula narrativa singolare: unendo, a mo’ di selfie, miniautobiografie in punta di penna di giovani patrioti della prima metà dell’Ottocento – come dice il sottotitolo – raccolte e commentate ciascuna nientemeno che da Alexandre Dumas, celebre autore dei Tre moschettieri e L’isola di Montecristo. Altro artificio letterario – usato dagli autori, i giornalisti Valeria Iacovino e Marcello Giannotti – non azzardato: Dumas seguì la spedizione dei Mille nella Battaglia di Calatafimi e raccolse nel libro I Garibaldini ricordi del periodo trascorso a fianco dell’Eroe dei due mondi fino all’entrata da dittatore in Napoli. Di più. Pur senza seguire canoni accademici, il libro fornisce strumenti da saggio storico: schede biografiche riassuntive sui personaggi, cenni bibliografici e documenti allegati, pochi ma significativi, come il Testamento del socialista e patriota Carlo Pisacane che concludeva così: “se il nostro sacrificio non porterà alcun vantaggio all’Italia, sarà per essa almeno una gloria l’aver generato figli, che volenterosi s’immolarono pel suo avvenire”.
Impegno non da poco: far parlare in prima persona i/le protagonisti/e, anche dei loro stati d’animo, relazioni, azioni, affetti, … attingendo, nella ricostruzione, a materiali eterogenei: carte processuali e poliziesche, corrispondenze personali, libri e giornali d’epoca,… Protagonisti che condivisero situazioni comuni: giovani uomini e donne, e – salvo un ragazzino trovatello – in condizioni economiche agiate se non nobiliari, animati da sentimenti libertari, nazionalisti indipendentisti, anticonformisti, coinvolti in conflitti familiari o con autorità statali e religiose; cresciuti e vissuti in diverse regioni italiane, alcuni furono pure viaggiatori per necessità in Francia e Inghilterra (ospitali coi fuoriusciti politici) e persino in Turchia.
Il ventaglio dei protagonisti non è ampio ma significativo.
“Il primo eroe” che racconta sé stesso è Michele Morelli, giustiziato a ventiquattro anni. Militare, sedicenne iniziò la carriera nell’esercito di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. Tornati i Borboni, seguitò nel loro esercito la carriera militare covando idee rivoltose. Fino a farsi capo d’un’insurrezione ch’ebbe successo per un anno e, infine, fu sconfitta dalle truppe della Santa Alleanza (Austriache); molti antiborbonici furono giustiziati insieme a Michele Morelli.
Accennavo al ragazzino trovatello, eroe cult nella sua città di Roma, a cui sono dedicate indicazioni stradali, ritratti bronzei e persino l’associazione Gli amici di Righetto, di cui è incerto pure il nome. Nella sua mente infantile affascinato dal nobile patriota Federico Torre, Righetto fu tra le vittime della repressione francese invocata in soccorso da papa Pio IX, provvisoriamente messo in scacco dalla Repubblica Romana. Il protettore Federico Torre, dopo varie peregrinazioni perché perseguitato dal Papa, sopravvisse addolorato alla morte di Righetto (squarciato da una bomba), divenendo fine letterato e ricollocato da Cavour nell’impiego militare.
C’è “il Moro in camicia rossa” (Andrea Aguyar), anch’egli d’origini incerte (schiavo?), giunto dal sud America con Garibaldi, che seguì nelle battaglie fino a perdere la vita. L’uomo di colore in camicia rossa non passava inosservato, però forse sarebbe finito nel dimenticatoio senza il ritratto proposto in questo libro. Altrettanto esemplare è la storia del prete Enrico Tazzoli, tra i martiri di Belfiore, religioso costretto allo stato laicale per i sentimenti antiaustriaci e per aver associato nella predicazione la passione indipendentista alla questione sociale, rappresentata dalle insopportabili diseguaglianze tra ricchi e poveri. Pari simpatia raccoglie il selfie di Ciro Menotti, indimenticabile eroe dei nostri studi giovanili, capace di sacrificare sentimenti amorosi verso moglie e figli sull’altare della lotta alla tirannide antiliberale dell’ambiguo duca di Modena, “costretto” dall’Austria a rinnegare lo Statuto (emanato e ritrattato) e condannare a morte i cittadini ribelli come Ciro.
Altrettanto avvincenti sono le pagine dedicate a eroine risorgimentali, divenute tali non tanto e non sempre per la volontà d’esserlo, bensì per fedeltà agli ideali e agli uomini di cui erano innamorate. Travolgenti amori che esposero quelle donne a vite travagliate, prigionie, separazioni dolorose dai figli, esili, dissipazioni di beni familiari,… Bianca Milesi Mojon, Maria Gambarana, Metilda Viscontini (Le tre giardiniere di Milano), Rosa Testi Rangoni (Mamma Rosa), Cristina Trivulzio Barbiana di Belgiojoso (La Principessa), Enrichetta di Lorenzo (Frammenti di un amore scandaloso), Jessie Jane Meriton White (La giornalista inglese), sono le protagoniste di capitoli a loro dedicati – sotto i titoli messi da me tra parentesi.
Vien da chiedersi se gli Autori raggiungeranno l’obiettivo prefissato: “far scoprire e riscoprire ai nativi digitali di oggi il coraggio e l’orgoglio della loro età” giovanile. Glielo auguriamo. Riconoscendone l’impegno compiuto nel raccogliere in un libro snello, essenziale, di facile lettura, esemplari storie risorgimentali in cui fatti, idee, vittorie, sconfitte, amori, tradimenti,… son chiamati col loro nome senza retorica – depositata in certi libri scolastici – nel trattare quel periodo, denso di fermenti ideali che riverberarono nelle coscienze e nella storia italiana dei decenni successivi.
www.ferrucciofabilli.it
Le buche sull’asfalto, l’erba sulle banchine e la Riforma costituzionale
Fino a uno due anni fa, viaggiando, la differenza tra una strada comunale e una provinciale era subito evidente: le provinciali avevano ottimi fondi stradali; banchine rasate; paracarri, colonnini, segnaletica verticale e orizzontale in ordine; mentre le comunali somigliavano all’inferno italiano delle barzellette: dove c’erano buche sull’asfalto, dove mancavano paracarri o colonnini o segnaletica a terra o verticale, dove le strade, non più degne di questo nome, s’erano trasformate in tratturi. Insomma, le vie comunali avevano (ed hanno) quasi sempre qualche stigma a contraddistirle dalle sorelle provinciali, quasi sempre in ordine.
Da un par d’anni la situazione è lentamente evoluta, al basso! anche nelle provinciali non c’è più la solita tempestività nel riparare buche o ragnatele sugli asfalti e l’erba cresce indisturbata nelle banchine e nei fossi. Sarà l’effetto temporaneo di assestamento nel passaggio di competenze tra le soppresse Provincie alle Regioni? Il timore è che sia un effetto irreversibile. Ho condiviso queste considerazioni con ex colleghi ancora in servizio in Comune e in Provincia, i quali, invece di giustificare come temporaneo il disservizio (o disastro), per risposta m’hanno travolto di altri ulteriori disservizi per gli utenti nei loro uffici: commercio, turismo, scuole, ecc. dichiarando la frustrazione di dipendenti pubblici a fronte d’un inarrestabile decadimento d’efficienza a svantaggio dei cittadini. Senza sapere a quale santo rivolgere le loro perplessità: dirigenti o assessori regionali? A trovarli! Navigano (male) a vista.
La soppressione delle Provincie era la riforma pilota tra i tagli nella spesa pubblica. Però, a conti fatti, quel che s’è tagliato è stata la l’efficienza, senza risparmi apprezzabili. Certo tagli ne hanno subiti nei trasferimenti finanziari ma nella stessa misura che sta gambizzando l’efficienza e l’autonomia dei Comuni. Arrivati anch’essi ai minimi termini di funzionalità. Un amico sindaco d’un Comune vicino – incontrato a donare sangue – mi raccontava il paradosso in cui si trova: “Ogni cinque dipendenti pensionati ne posso sostituire uno, è impossibile utilizzare personale volontario pur avendolo disponibile, le scarse risorse finanziarie sono insufficienti a mantenere un esteso patrimonio pubblico, senza dire dei servizi scolastici…mi capita sempre più spesso che qualche cittadino dopo avermi esposto il problema si da la risposta da solo: ma lo so che mancano soldi!…” Anche i più digiuni di Pubblica Amministrazione l’han capito: seguitando di questo passo i Sindaci finiranno per sentirsi impotenti se non inutili. Se, infatti, un Sindaco non è più in grado di aprire un asilo nido, fornire mense e trasporti scolastici, sostenere gli indigenti, tenere in ordine parchi, vie, piazze, beni comunali,… a che servirebbe?
Il governo ha posto a cardine della sua azione in direzione d’uno Stato più efficiente e meno costoso la propria Riforma costituzionale. Chiave di volta del sistema Italia. Da mesi è aperta la campagna elettorale sulla Riforma costituzionale e ne avremo ancora fino a novembre, tra chi che tenta di spiegare le ragioni del Si e del No usando argomenti attinenti la materia (i più corretti), insieme a un bailamme di pronunciamenti sgangherati che tramutano la commedia in farsa. Fino alla ridicola discussione sulla vignetta delle cosce cicciottelle della Boschi, tramutata da certi tromboni politici in offesa antifemminista, o la promessa di Renzi d’un risparmio di 500 milioni che destinerebbe ai poveri. Solo che organi contabili dello Stato han valutato il risparmio dalla trasformazione del Senato, se andasse bene, solo in 50 milioni! Ma non mi interessa ripetere le già abbondanti argomentazioni a favore dei Si e dei No alla suddetta riforma, che abbondano nei social e nei mass media… oddio stando ai mass media quasi all’unisono la miglior decisione per i cittadini sarebbe senz’altro il Si. Strano ma vero questo unisono… Io sono per il NO. Posso argomentarlo in breve: sui risparmi da questa riforma si è già detto. E la sbandierata semplificazione legislativa? Confrontando il testo Costituzionale originale con quello riformato all’art. 70, sulla produzione legislativa, nell’ordinamento “vecchio” è prevista il classico doppio passaggio tra le due Camere del medesimo testo. S’è detto macchinoso, ma per approvare leggi che stavano a cuore al potere in certe circostanze sono bastate 24/48 ore! (ricordiamo il decreto sulle banche). Il “nuovo” ordinamento, invece, prevede 10/12 procedure diverse con cui il Senato (non di eletti, ma nominati) approverebbe le leggi. E, in caso discorde tra le due Camere, il tutto è rinviato alla Corte costituzionale. Alla faccia della semplificazione! Ma mi fermo qui, rispettando l’intelligenza dell’elettore che cercherà dovunque vorrà le risposte a lui più gradite.
Vorrei però condividere alcune considerazioni del cardinale Bagnasco, sul Corriere della Sera, che mi paiono, se pur da laico, una risposta appropriata a quanti motivano il Si alla Riforma costituzionale perché ce la chiede l’Unione Europea. “Se guardiamo i risultati dobbiamo concludere che si è partiti con buone intenzioni ma con decisioni sbagliate. La volontà prepotente di omologare, di voler condizionare le visioni profonde della vita e del comportamento, il sistematico azzeramento delle identità culturali, assomigliano non ad un cammino rispettoso verso un’Ue armonica e solidale, certamente necessaria, ma piuttosto verso una dannosa rifondazione che i popoli sentono pesante e arrogante”. Inoltre, ha aggiunto Bagnasco, “ la storia attesta che quando i potenti si concentrano sulla propria sopravvivenza per ambizioni personali e rinunciano alla res publica, è l’ora della decadenza”. Chiarissimo.
Le premesse condivise dai partiti sulla Riforma costituzionale erano: taglio netto dei Deputati e Senatori, riduzione dei relativi privilegi e indennità, semplificazione dei processi normativi. A quali obiettivi risponderebbe la Riforma Boschi-Verdini?
www.ferrucciofabilli.it
TITO BARBINI,nell’autobiografia da comunista a post, auspica nuove strade per sé e il suo partito, il PD
Nelle trecento avvincenti pagine autobiografiche di “Quell’idea che ci era sembrata così bella”, Tito argomenta l’orgoglio di appartenere a una generazione tanto impegnata d’aver esordito definendosi (se pure nell’improntitudine giovanile): “rivoluzionario di professione!”. La sua storia, a uno sguardo superficiale, potrebbe dirsi condivisa da strette elites dirigenziali del PCI, di cui è stato parte – frequentando scuole di partito e coprendo ruoli politici e amministrativi apicali: provinciali, regionali, nazionali – invece – da indagatore innanzi tutto di sé stesso sulla girandola di incarichi ricoperti, e sugli eventi che hanno caratterizzato il lungo periodo trascorso – ricostruisce un’avventura in cui migliaia di (ex) comunisti italiani potrebbero in larga parte riconoscersi. (Quanto avviene durante le numerose presentazioni del libro: occasioni di autoanalisi collettiva). Disilluso dall’ideologia comunista, soprattutto nell’attuazione pratica, alla ricerca di nuovi percorsi politici, Tito rifiuta l’abiura, rifacendosi anche allo scritto di Lucio Magri: “Il sarto di Ulm”, che ricorda la storia d’un tizio che nel ‘500 volle dimostrare d’esser capace di volare, schiantandosi a terra. Ma, a distanza di tempo, l’uomo vola facilmente… come potrebbe accadere di tornare utili a rinnovate idee comuniste.
La solida “fede” politica, impressagli dal padre e dal norcino Spinaldo, tradotta in adesione prima all’organizzazione giovanile, poi al PCI – raccontata nelle prime righe del libro – fecero di lui un politico professionale simile a una locomotiva. Nel senso che Tito contava su “ ‘una strada segnata’, su un futuro ragionevolmente sicuro”; finché non s’è tramutato nel bufalo che scarta di lato – come nella canzone “Buffalo Bill” di Francesco De Gregori. Strada segnata, ma interrotta volontariamente per gravi divergenze, nel 2003, con la dirigenza cittadina del partito, ad Arezzo. (Ricordiamo le metamorfosi del suo partito: da PCI a PDS, DS, PD). Dopo lo scarto di lato, ha continuato a viaggiare, leggere, interrogarsi su quanto era capitato a lui e al partito, pur smesse le vesti dirigenziali, avendo più tempo disponibile senza ansie performative. Fin’allora la “locomotiva” Tito aveva corso senza risparmio di energie; ambizioso, dinamico, intelligente in ogni ruolo ricoperto: dirigente giovanile, segretario cittadino e provinciale del PCI, sindaco di Cortona, presidente della Provincia e della USL, assessore regionale…Già durante la corsa s’era posto interrogativi sul comunismo realizzato, e sulla compatibilità tra ideologia e sistema democratico pluralista, e su come continuare l’infinita battaglia, intrapresa fin da ragazzo, per una giustizia sociale coniugata alla libertà … Interrogativi ingigantiti dalla caduta del Muro di Berlino. A cui dedicò un libro di viaggi e riflessioni: “Caduti dal Muro” che, già nel titolo tragicomico, tradisce i tormenti dello scrittore, fino a sentirsi in colpa per non aver compreso prima i risvolti drammatici del “socialismo reale” nei paesi dell’Est europeo – pur avendoli frequentai – e finanche in Cina e Cambogia. Tanto che sovrapponendo la lettura dei due libri citati, notiamo il ripetersi ossessivo degli stessi interrogativi: in cui si rimprovera avvedutezza tardiva, aggiungendo altri dilemmi politici che lo tormentano… Mosso da tanto auto accanimento, provo a consolarlo: anche fosse stato più tempestivo nell’acquisire consapevolezza, cosa avrebbe potuto fare? Gran parte della storia è fuori dalla portata individuale. E poi, forse che avresti negato al giovane Tito incontri amorosi con splendide ragazze dell’Est?!… Cose che non si scrivono in autobiografie politiche, ma tali pensieri umani potrebbero esser stati loro a distoglierlo dalla realtà, passando il checkpoint Charlie… mi permetto questa facezia per la nostra lunga amicizia da porcospini (quelli di Carlo Verdone: né troppo vicini né troppo lontani, per non pungersi). Mentre ricorda con nostalgia l’esperienza formativa e gratificante da sindaco di Cortona, carica in cui ebbi il piacere di subentrargli come in una staffetta.
Ricordo la basilare riunione da lui indetta: tra Giunta comunale uscente e quella entrante da me diretta. Bastò poco tempo per trasmetterci idee e illustrarci i progetti utili al futuro di Cortona. Tito lasciò anche un bel debito – di cui si ricorda nel libro – frutto d’una svolta nella politica comunale: mense e trasporti scolatici gratuiti, welfare che seguitammo, ripianando i debiti ed avendo la fortuna di tramutare i suoi e i nostri progetti da libro dei sogni in realtà. In cinque anni, da successori di Tito, realizzammo progetti e ottenemmo finanziamenti in tal quantità e qualità mai più ripetute. (Edilizia popolare pure in Cortona, allestimento del PIP al Vallone, potenziamento dell’acquedotto comunale, metanizzazione, piscina coperta, ponte sull’Esse, centro convegni S. Agostino, nuove aree di espansione edilizia in molte frazioni, PIP d’iniziativa privata a Terontola, depuratore, nuovi impianti sportivi … per ora , basta). Tanto che qualche compagno cortonese ha rimproverato Tito, politico di rilievo provinciale, di non aver spinto la successiva dirigenza cortonese, ambiziosa ma di scarso costrutto.
Anche Tito era ambizioso, ego evoluto in forte passione, consentendogli una carriera politica rilevante, all’altezza degli incarichi ricoperti, con frutti riconosciuti validi nel tempo, menzionati nel libro. Quell’amor proprio – gli ho detto scherzando -, rispettoso di regole pubbliche e di partito, gli ha consentito di navigare a lungo senza incappare in vizi aborriti: corruzione e opacità del potere, che, coniugati alla scarsa partecipazione alla gestione della cosa pubblica, han portato i cittadini al distacco dalla politica; senza più “quell’idea che ci era sembrata bella” s’è pure ingigantita nel tempo la questione morale denunciata da Enrico Berlinguer e Sandro Pertini, principio a cui siamo ancorati, insieme a Tito. Che chiude il libro a Cortona, dove, a mo di metafora politica, si domanda: cosa o chi potrebbe essere il Godot da attendere? insoddisfatto della direzione e delle condizioni in cui versa il suo partito, il PD. Il quale, trascurando “idee di sinistra”, di cui son portatori individui alla Barbini, sta scavando un fosso tra i problemi reali del paese e le “riforme” di cui si vanta: sul lavoro, sulla Costituzione, sulle regole della democrazia… ma questo è un altro discorso, che trova spazio nel libro d’un Tito amareggiato e poco ottimista.
www.ferrucciofabilli.it
IVAN ACCORDI con “l’antipastissimo” del Ritorante Tonino creò il mito di Cortona nella ristorazione
Cortona, già conosciuta per la buona cucina nelle trattorie e nei ristoranti, fece un balzo prodigioso in avanti in notorietà, quando fu costruito negli anni Settanta, in piazza Carbonaia, l’immobile che ospita il Ristorante Tonino, e l’Hotel san Luca. Protagonista fu Ivan Accordi, che dedicò la nuova impresa gastronomica al padre e maestro Tonino (Antonio), già sapiente gestore del ristorante Il Cacciatore e capace di metter giudizio al giovane figlio scavezzacollo.
I nuovi ampi spazi consentirono l’avvio della più importante impresa ristoratrice cortonese. In cucina la moglie Adriana – con cuochi capaci, tra cui Santino e Pietro – si sbizzarriva in creazioni, curando in particolare la specialità della casa: “l’antipastissimo”; serie infinita e fantasiosa di assaggini caldi e freddi, da soli in grado di saziare gli stomaci più esigenti e ingordi.
Ivan s’incaricava dell’accoglienza. Signorile e allegro, assieme ai veterani Benito e Mauro, dirigeva un notevole stuolo di camerieri, tra fissi e avventizi. In città, quanto a occupazione, dopo il Comune i giovani cercavano lavoro da “Tonino”. Non si diceva più neanche “Ristorante Tonino”. Bastava il nome. (Ivan, da alcuni confuso pure per Tonino, aveva realizzato il più bel “monumento” alla memoria del padre).
Per festeggiare ricorrenze o solo per una pappata tra amici o coi familiari, invalse la moda di andare da “Tonino”, quello dell’ “antipastissimo”, da un giro di persone sempre più vasto e proveniente dai luoghi più disparati… Era il frutto delle curiose e allettanti specialità culinarie, e d’un’intensa attività di catering svolta in tutta Italia. “Tonino” aveva raggiunto tale capacità operativa ch’era in grado di offrire banchetti a domicilio a distanza di decine o centinaia di kilometri, senza scapito per la qualità. S’era creato il mito di “Tonino” e dell’ “antipastissimo”, di cui gente della mia età ne serba ancora il ricordo, in giro per l’Italia.
La figlia Antonella e il genero Paolo furono anch’essi inseriti nell’impegnativa trama organizzativa. A Ivan piacevano occasionali rimpatriate, nel suo regno gastronomico, con altri familiari: suo fratello e sua sorella; lei residente a Montalcino e coniugata col simpatico carabiniere in pensione, chiamato con affetto, “Zio Brunello”. Per il luogo di residenza, oltre ché campione di tolleranza alcolica… in proposito, divagherò un attimo ricordando le gesta di “Zio Brunello” in gita collettiva, negli anni Ottanta, ospite dell’Università di Athens, in Georgia, che ogni anno inviava (e invia) a Cortona un nutrito gruppo di studenti e professori per corsi stagionali. (Allora ospitati nella struttura alberghiera gestita da Ivan stesso, l’Albergo Athens).
La delegazione, accolta negli USA con ogni premura, era composta da Ivan e Adriana, Antonella e Paolo, mia moglie Carla e il sottoscritto, la sorella di Ivan e il marito “Zio Brunello”, il quale fu memorabile protagonista d’una sfida alcolica all’ultimo bicchiere coi professori di Athens. Tra costoro, forti bevitori vollero cimentarsi con “Zio Brunello” pensando di stenderlo facile. Invece, uno alla volta, professori barcollanti dovettero arrendersi, scostandosi mesti dal tavolo dove imperava lo “Zio”!… finché non intervenne Ivan a sospendere la gara, temendo un incidente diplomatico in casa altrui.
Concentrato e puntiglioso nel lavoro, tant’era gioviale e socievole, Ivan, smesse le vesti da boss. Non a caso gli è stato dedicato un campo di calcio a Camucia, per i buoni ricordi lasciati da presidente della società sportiva Cortona-Camucia. Immagino, pure, per avervi impegnato bei denari.
Com’era prodigo di attenzioni verso ospiti speciali – n’ebbe numerosi tra politici, militari, poliziotti, finanzieri, alti prelati, imprenditori, ecc. -, altrettanto lo era con gli amici. Suggerendo il menù più appropriato ai gusti dell’ospite, e spesso aggregandosi al loro tavolo degli amici per far due chiacchiere… In quel turbine di assaggi usciti dalla cucina, la sua pietanza preferita era la pappa col pomodoro! Cotta a modo suo.
Seguiva con passione le vicende della Città. Per quanto di idee politiche diverse dagli amministratori locali del tempo, le sue critiche o proposte erano ritenute preziose. Mosso dalla responsabilità di dirigere una grande azienda, le cui fortune erano legate al buon andamento dello sviluppo turistico, e dal sentirsi parte della più estesa famiglia cittadina, società che condivide un cammino.
Senza indugiarvi troppo, a Ivan piaceva sedurre… cherchez la femme! D’altronde era un bell’uomo, distinto, elegante nel vestire e nel conversare. E la posizione sociale e professionale gli offriva svariate occasioni di incontri galanti… a cui non si sottraeva. Finchè il potere seduttivo non s’era trasformato, con l’età, in ricordo dei bei tempi andati, suggerendogli comprensione e complicità verso le tresche amorose giovanili della sua numerosa ciurma di collaboratori e dei tantissimi giovani che si davano appuntamento sulla “terrazza di Tonino”, da cui si gode una splendida veduta della Valdichiana e del Trasimeno… quale luogo migliore per intrecciare storie d’amore sorseggiando una bevanda o addentando uno stuzzichino?
Oltre al ricordo affettuoso di Ivan Accordi – imprenditore dinamico con la passione per la società di calcio, innamorato di Cortona quanto del genere femminile – gli sopravvive l’eccellente eredità professionale nella somministrazione di alimenti e bevande. Suoi ex dipendenti, anche in proprio, gestiscono brillantemente bar e ristoranti, contribuendo alla diversificazione dell’offerta gastronomica: dalla cucina tradizionale a quella più inventiva al semplice piatto caldo, come richiede il mercato e come s’insegnava alla scuola del “Ristorante Tonino”. Lo stesso è capitato alla figlia Antonella che gestisce un agriturismo, e al figlio Antonio che, negli stessi locali e con la stessa denominazione, continua l’attività del padre Ivan.
www.ferrucciofabilli.it
San Pietroburgo straordinaria finestra sulla Russia (note di viaggio)
Le notti bianche, al loro apice intorno al 21 di giugno, sono un’attrazione intrigante per il noto fenomeno del giorno che non si fa mai notte.  Dinanzi al Palazzo d’Inverno è allestita una macchina mastodontica per spettacoli musicali e giochi di luce fantastici, dando luogo in queste “notti” a interminabili feste nella piazza stracolma di gente. Sempre in questi giorni clou delle notti bianche, coincidendo con la fine dell’anno scolastico, viene allestito uno spettacolo poderoso sulla Neva, illuminata a giorno, dedicato ai giovani maturandi. Un veliero entra nella Neva a vele rosse spiegate. Si tratta di una specie di rito d’iniziazione per i giovani, derivato da una storia popolare, secondo la quale un giovane per convincere una ragazza ad amarlo dovette procurarsi un veliero armato con vele rosse. Difficili da procurarsi, in quanto le vele in passato erano tutte chiare. Ma l’innamorato vinse la sfida riuscendo a trovare quel che gli era stato chiesto. Perciò, alla rievocazione, oltre gli effetti spettacolari che richiamano ogni anno frotte di curiosi in riva al fiume, viene attribuita una morale: i giovani di fronte ad ogni difficile impresa fino all’inverosimile non devono mollare mai; con l’impegno, alla fine, la soluzione può arrivare.
Dinanzi al Palazzo d’Inverno è allestita una macchina mastodontica per spettacoli musicali e giochi di luce fantastici, dando luogo in queste “notti” a interminabili feste nella piazza stracolma di gente. Sempre in questi giorni clou delle notti bianche, coincidendo con la fine dell’anno scolastico, viene allestito uno spettacolo poderoso sulla Neva, illuminata a giorno, dedicato ai giovani maturandi. Un veliero entra nella Neva a vele rosse spiegate. Si tratta di una specie di rito d’iniziazione per i giovani, derivato da una storia popolare, secondo la quale un giovane per convincere una ragazza ad amarlo dovette procurarsi un veliero armato con vele rosse. Difficili da procurarsi, in quanto le vele in passato erano tutte chiare. Ma l’innamorato vinse la sfida riuscendo a trovare quel che gli era stato chiesto. Perciò, alla rievocazione, oltre gli effetti spettacolari che richiamano ogni anno frotte di curiosi in riva al fiume, viene attribuita una morale: i giovani di fronte ad ogni difficile impresa fino all’inverosimile non devono mollare mai; con l’impegno, alla fine, la soluzione può arrivare.
Bene. Quest’anno siamo arrivati giusto in tempo per assistere a questi intriganti festeggiamenti. Però, con mia figlia, non abbiamo partecipato né allo spettacolo musicale, né all’arrivo della nave. La nostra guida locale, vedendo la fragilità del gruppo di due, ci ha dissuasi. Memore della sua esperienza. La folla in certi momenti si sposta con tale intensità che è in grado di travolgere la persona distratta o incapace di sostenere urti decisi. E così abbiamo privilegiato sfruttare le lunghe giornate per visitare la città in lungo e in largo. Durante la notte, invece, abbiamo approfittato della luce scendendo dall’albergo nell’adiacente piccolo parco a fumare, dopo aver assistito alle partite dell’Europeo di calcio…
Cosa m’ha spinto a San Pietroburgo?
Una sommatoria di curiosità cresciute nel tempo: visitare l’Ermitage ; respirare le atmosfere letterarie di due tra gli scrittori che più amo, Alexander Puskin e Fëdor Dostoevskij (molti altri autori russi sono entrati in contatto con la città); passeggiare nel prodigio urbanistico ideato da Pietro Romanov sulla taiga, in isolette acquitrinose sul delta della Neva; partecipare allo spettacolo naturale – e a quelli inventati dall’uomo – in occasione delle notti bianche estive;…e, perché no? rivolgere uno sguardo riflessivo sulle tracce residue della rivoluzione Leniniana, nel luogo dell’insurrezione; coincidente col luogo natio di Putin, protagonista contemporaneo del riscatto russo. Temuto, nonché osteggiato dalle potenze atlantiche, fino a tensioni tali da spingere persone autorevoli a paventare un possibile conflitto nucleare…
; respirare le atmosfere letterarie di due tra gli scrittori che più amo, Alexander Puskin e Fëdor Dostoevskij (molti altri autori russi sono entrati in contatto con la città); passeggiare nel prodigio urbanistico ideato da Pietro Romanov sulla taiga, in isolette acquitrinose sul delta della Neva; partecipare allo spettacolo naturale – e a quelli inventati dall’uomo – in occasione delle notti bianche estive;…e, perché no? rivolgere uno sguardo riflessivo sulle tracce residue della rivoluzione Leniniana, nel luogo dell’insurrezione; coincidente col luogo natio di Putin, protagonista contemporaneo del riscatto russo. Temuto, nonché osteggiato dalle potenze atlantiche, fino a tensioni tali da spingere persone autorevoli a paventare un possibile conflitto nucleare…
Insomma, avevo uno zibaldone di curiosità nell’angolo dei desideri, finché sono entrato in comunione di intenti con Brunella, mia figlia, con la quale ogni anno ci regaliamo una gita in una città europea.
Avevo visitato Mosca l’odierna capitale, in anni successivi alla perestrojka, e m’ero fatto una idea sulla Russia, arricchita molto visitando San Pietroburgo, capitale della Russia dei Romanov. Città cresciuta a dismisura in soli tre secoli di vita, ma basterebbero le costruzioni dei primi due secoli per farne comunque una tra le città più affascinanti al mondo. Mutando, in questo breve – storicamente – lasso di tempo, ben tre denominazioni: sorta dal nulla ai primi del ‘700 come San Pietroburgo, rimase tale per due secoli; poi, agli inizi del XX secolo, divenne Pietrogrado in ossequio alla maniera tedesca di denominare le città, ma per pochi anni, a causa della guerra contro i tedeschi, nella prima guerra mondiale, e a causa della rivoluzione bolscevica del 1917, morto Lenin nel ’24, fu denominata Leningrado per circa un settantennio; finché, a fine ‘900, a seguito di referendum, fu ripristinato San Pietroburgo.
Così, in soli tre secoli di vita, ha vissuto una storia straordinaria a partire dal suo stesso nome. Basti solo ricordare il famoso libro I dieci giorni che sconvolsero il mondo di John Reed, ambientato sullo sfondo dell’allora Pietrogrado. Senza dimenticare le epiche imprese della marineria russa (col vessillo della croce di Sant’Andrea) fondata e con base a San Pietroburgo, capitale sfavillante della Russia zarista. Furono i bolscevichi a trasportare la capitale a Mosca. Con la conseguente marginalizzazione e decadenza di Leningrado.
Il primo contributo allo splendore della capitale baltica è giustamente attribuito al Romanov più famoso, Pietro I il Grande (per i risultati ottenuti da imperatore e per il suo gigantesco fisico). Pietro I scelse il nome del luogo – in cui fece costruire una cittadella fortificata sull’estuario del fiume Neva – dal suo protettore omonimo San Pietro (che, nella chiesa a lui dedicata nella piazzaforte, è associato a San Paolo).
Lo zar partendo da quest’isola strappata agli Svedesi – detta “delle lepri” uniche precedenti abitatrici – ne previde subito il futuro assetto urbanistico, disegnandone una trama urbana straordinaria per quei tempi, in cui le città europee erano caratterizzate da strette strade medievali. Organizzandola in perfette geometrie con ampi viali e riempita in pochi decenni di spettacolari architetture, nell’intento riuscito di realizzare un “paradiso” estetico, soprannominato anche la “Roma del Nord”.
Pietro il Grande riuscì ad eguagliare, e superare, il modello di città scelta, l’olandese Anversa. Disegno completato dai successori che si avvalsero di valenti architetti provenienti da tutta Europa, in un insieme armonioso di stili, principalmente il neoclassico e il barocco, in parte minore il liberty e il più recente stile bolscevico…
Piazze ed edifici per qualità, quantità, dimensioni, concentrazione in un’unica città, e i rapidi tempi di realizzazione, rappresentano un insieme fuori dal comune, già tra il Sette e l’Ottocento. Per avere una idea di ciò, basta passeggiare nella lunga prospettiva Nevskij che taglia in due una delle isole maggiori; visitare il Palazzo d’Inverno; l’Accademia della marina – edificio lungo oltre quattrocento metri – ; teatri; università; palazzi nobiliari; ricche chiese per materiali e fogge; cittadelle religiose comprensive di cimiteri, come il complesso Alexandra Nevkogo – a un’estremità della prospettiva Nevskij – dove riposano i più noti artisti e scienziati dell’800 pietroburghese; i numerosi ponti mobili che, illuminati e rialzati di notte, sono uno spettacolo raro a vedersi; …
; teatri; università; palazzi nobiliari; ricche chiese per materiali e fogge; cittadelle religiose comprensive di cimiteri, come il complesso Alexandra Nevkogo – a un’estremità della prospettiva Nevskij – dove riposano i più noti artisti e scienziati dell’800 pietroburghese; i numerosi ponti mobili che, illuminati e rialzati di notte, sono uno spettacolo raro a vedersi; …
Un recente viaggiatore, Sergio Romano, sul Corriere della Sera ha apprezzato il rispetto della storia praticato in questa città: avendo mantenuto tutti i monumenti del passato. Nonostante le turbolenze politiche che ne hanno contraddistinto i tre secoli di storia: dalle lotte intestine per il potere; alla mancata invasione napoleonica fermata, dopo Borodino, dal “generale inverno”; alla rivolta decabrista; alla rivoluzione bolscevica; al lungo assedio tedesco nella seconda guerra mondiale; … la città conserva integra la sua architettura: edifici, piazze, monumenti,…. rispettati pure in epoca bolscevica – sopraggiunta anche come reazione agli eccessivi sfarzi cittadini a fronte delle misere condizioni del popolo – salvo la distruzione della cattedrale – come avvenne pure a Mosca, mentre lì è stata ricostruita, qui no, forse perché di chiese cattedrali grandi e belle ve ne sono una discreta quantità. Del periodo bolscevico sono rimaste al loro posto costruzioni tipiche: come il palazzo dei soviet (oggi destinato al governo della regione) carico di retorici rimandi, un’enorme statua di Lenin, e il monumento alla resistenza antinazista, collocati nel quartiere dove s’era sviluppata la Leningrado comunista – intorno alla stazione ferroviaria Moskovskaia – dalla architettura squadrata e “funzionale”. In quel periodo storico, le chiese furono mantenute e pure restaurate a partire dal secondo dopoguerra, salvo modificarne l’uso: in magazzini o musei antireligiosi… tornate oggi agli originari splendori, meta di attrazione turistica e luoghi di culto.
La religione cristiana ortodossa e i suoi santuari
Né l’illuminismo – giunto in Russia particolarmente pervasivo dopo il contatto con l’esercito napoleonico – né il comunismo sono riusciti a distruggere l’influenza della chiesa cristiana ortodossa nella coscienza popolare e nella vita pubblica. Tra Stato e Religione, ancor oggi, v’è un legame stretto, come agli albori di San Pietroburgo. D’altronde il primo Romanov al potere nel Seicento, nipote di Ivan il Terribile, era figlio del patriarca di Mosca Filarete… La Chiesa, tutt’uno col potere politico, n’ha tratto vantaggi leggibili visitando i numerosi monumenti religiosi: dal pregevole disegno architettonico in stile neoclassico o barocco, carichi di ori e preziosi arredi, con marmi a profusione provenienti dalle cave più pregiate d’Europa e d’Asia… nella stessa vistosa esibizione del lusso presente nei palazzi nobiliari. Saliti al potere i bolscevichi, la Chiesa ha subìto il tentativo di ridimensionamento se non di cancellazione.
Tuttavia, a partire dal secondo dopoguerra, il ruolo della chiesa ortodossa riprese campo – ho letto da qualche parte la reazione scandalizzata d’un viaggiatore in una chiesa di Mosca, avendo visto ancor oggi affisso un ritratto di Stalin tra le icone prossime all’altare! Lo stesso Stato comunista, come accennato, aveva già avviato ripristino e conservazione strutturale dell’edilizia religiosa. I cui modelli, a San Pietroburgo, sono in parte tipici della tradizione Russa, e in parte di ispirazione o imitazione di chiese europee, rappresentando, oggi, luoghi di maggiore attrazione turistica. Di fronte ai quali, un laico è combattuto tra il godimento estetico e l’interrogativo che ci si pone davanti ad ogni sfarzo esagerato: quanto di questa ricchezza abbia sottratto benessere ai poveri cristi che hanno versato i loro oboli, pur essendo in miseria? e quanti sacrifici umani – anche in termini di vite perse – sono costate? Dico ciò senza pregiudizio, avendo sentito il racconto dei “costi” dalla voce della guida locale, in visita alla cattedrale di Sant’Isacco, costruzione davvero faraonica.
Diversa è la sensazione visitando la chiesa eretta nel luogo in cui la zarina fu informata della vittoria Russa sui Turchia a Chesmea. Sito all’epoca sperduto nella taiga, oggi circondato dall’espansione urbana d’epoca bolscevica. Semplice costruzione a righe verticali bianche e rosate che, nello slancio verso l’alto, somiglia a un dolce di pan di zucchero. Un miraggio circondato da palazzi residenziali popolari novecenteschi. E, mi son pure detto, che stesse cercando la zarina in quel luogo sperduto? Forse era a caccia?…
A poca distanza l’una dall’altra – lungo il canale Griboedov che interseca la prospettiva Nevskij – troviamo altre due chiese in cui si riversano frotte di turisti: la cattedrale della Madonna di Kazan (costruita per conservare un’icona mariana ritenuta miracolosa e per celebrare la vittoria su Napoleone con le statue bronzee di due generali), volutamente, appare come miniatura della chiesa vaticana di San Pietro; mentre la chiesa della “Salvazione sul Sangue versato” è la tipica costruzione barocca Russa coi sui cipolloni multiformi e colorati, simili al San Basilio nella Piazza Rossa di Mosca
volutamente, appare come miniatura della chiesa vaticana di San Pietro; mentre la chiesa della “Salvazione sul Sangue versato” è la tipica costruzione barocca Russa coi sui cipolloni multiformi e colorati, simili al San Basilio nella Piazza Rossa di Mosca . La chiesa, nel nome stesso, ricorda il luogo in cui fu assassinato lo zar Alessandro II nel marzo del 1881, per mano di un terrorista appartenente alla organizzazione “Volontà del popolo”. D’altronde la storia degli zar, nel periodo sanpietroburghese, è costellata da morti cruente, anche per mani sovversive, o avvelenamenti a causa di congiure di palazzo. La cui narrazione s’inserisce perfettamente non solo nella logica del potere d’ogni tempo e d’ogni luogo, ma si carica di specifica drammaticità nella città del Dostoevskij di “Delitto e castigo”. Così come, parlando di edilizia nobiliare, la storia dell’Ermitage rimanda alla passione della corte imperiale per i piaceri dell’arte e della lussuria, in questo caso d’una zarina, che volle costruirsi un romitorio dove intessere le sue numerose passioni carnali lontana dagli sguardi del popolo – da qui il nome Ermitage, sembra avesse una trentina di giovani amanti! – e passioni artistiche, avendo acquisito una ricca collezione d’arte da un mercante che la cedette allo Stato in sconto tributi. E’ evidente, qui, il racconto d’una città invasa da mercanti e avventurieri, persone anche colte, vittime di costose passioni, come il gioco o il corteggiamento femminile in grado di determinare la rovina d’un uomo…
. La chiesa, nel nome stesso, ricorda il luogo in cui fu assassinato lo zar Alessandro II nel marzo del 1881, per mano di un terrorista appartenente alla organizzazione “Volontà del popolo”. D’altronde la storia degli zar, nel periodo sanpietroburghese, è costellata da morti cruente, anche per mani sovversive, o avvelenamenti a causa di congiure di palazzo. La cui narrazione s’inserisce perfettamente non solo nella logica del potere d’ogni tempo e d’ogni luogo, ma si carica di specifica drammaticità nella città del Dostoevskij di “Delitto e castigo”. Così come, parlando di edilizia nobiliare, la storia dell’Ermitage rimanda alla passione della corte imperiale per i piaceri dell’arte e della lussuria, in questo caso d’una zarina, che volle costruirsi un romitorio dove intessere le sue numerose passioni carnali lontana dagli sguardi del popolo – da qui il nome Ermitage, sembra avesse una trentina di giovani amanti! – e passioni artistiche, avendo acquisito una ricca collezione d’arte da un mercante che la cedette allo Stato in sconto tributi. E’ evidente, qui, il racconto d’una città invasa da mercanti e avventurieri, persone anche colte, vittime di costose passioni, come il gioco o il corteggiamento femminile in grado di determinare la rovina d’un uomo…
Tornando alle due chiese, sul canale Griboedov, tra di esse, incontriamo un’insolita costruzione in vetro e metallo stile liberty, il palazzo Singer. Fatto costruire dall’industriale americano produttore delle omonime macchine da cucire Singer, appunto. Oggi sede della più importante libreria cittadina. Sta a significare come la città racconti la sua storia attraverso gli edifici: in mezzo alle due chiese che rappresentano lo splendore e le tragedie della famiglia imperiale, troviamo anch’essa nella mole imponente – culminante in una specie di enorme ditale metallico rovesciato – il nuovo che avanzava, il capitalismo, basato sull’espansione di produzioni seriali di beni d’uso e consumo.
Fatto costruire dall’industriale americano produttore delle omonime macchine da cucire Singer, appunto. Oggi sede della più importante libreria cittadina. Sta a significare come la città racconti la sua storia attraverso gli edifici: in mezzo alle due chiese che rappresentano lo splendore e le tragedie della famiglia imperiale, troviamo anch’essa nella mole imponente – culminante in una specie di enorme ditale metallico rovesciato – il nuovo che avanzava, il capitalismo, basato sull’espansione di produzioni seriali di beni d’uso e consumo.
L’identità culturale e politica russa è anche europea?
Certamente sì. Oggetto ricorrente di discussione nella stessa Russia, fin dall’Ottocento, protagonisti intellettuali e uomini politici.
In un libro recente, Vladimir Sorokin allude a La tormenta – Bompiani editore – come “allegoria di una Russia davvero eterna, dove lo spazio è incommensurabile, tale da annullare la volontà degli umani; e in cui i rapporti tra le persone sono improntati alla relazione servo-padrone; anche quando il padrone è un illuminato idealista che vorrebbe salvare l’umanità. Sorokin stesso è un avversario di Putin, un uomo cresciuto nell’ambiente del dissenso degli anni Ottanta” (scrive Wlodek Goldkorn, ne La Repubblica). L’allegoria della tormenta – condivisibile o meno – focalizza un tema centrale riferito a quell’immenso paese. Volutamente ho citato lo scrittore contemporaneo, tra i più pessimisti sul rapporto tra l’uomo russo e il potere, tanto duro – sempre citando il critico letterario Goldkorn ch’ha recensito La tormenta – che “oltrepassa il sociale e approda a una visione apocalittica, senza possibilità di redenzione, dove il Male prevale sempre”, come condizione costante nel tempo, tantoché il cammino raccontato nel libro è verso la catastrofe, lasciando incerta l’ambientazione temporale tra elementi dell’Ottocento e la visione di un futuro di regressione tecnologica.
Ripeto, non sto sposando questa tesi, ma è uno spunto per chi volesse capir meglio l’intreccio russo tra popolo, politici e intellettuali; che a Sorokin, da duecento anni a questa parte, pare immutato: “L’intelligenza russa contemporanea imita quella dell’Ottocento, con la sua fede nell’istruzione del popolo e in un futuro luminoso, anche se nella Russia post sovietica non esiste più il popolo, ma solo una popolazione. E per quanto riguarda l’avvenire luminoso, abbiamo problemi grandissimi” arrivando alla sua conclusione: “Credo nella democrazia in generale, ma, ahimè, non credo in una democrazia russa”.
Affermazione che echeggia la stampa occidentale e in particolare i pregiudizi anglosassoni: “La Russia aggressiva, l’assolutismo di una ‘democrazia controllata’, il riarmo poderoso, un leader che viene dal Kgb, il ritorno all’espansionismo imperiale” così riassunti da Gennaro Sangiuliano in un articolo su Il Sole 24 Ore, recensendo il saggio Russofobia. Mille anni di diffidenza – Teti editore – del giornalista e storico svizzero Guy Mettan.
A questo autore, secondo me, va il merito d’aver indagato sul perché oggi la Russia sia ritenuta un “mix pericoloso”, dei “semieuropei che per un verso o per l’altro appartengono al mondo dell’alterità rispetto all’Europa”, come scrive Cardini nella prefazione al libro. Eppure, un sicuro statista come De Gaulle diceva: “L’Europa va dall’Atlantico agli Urali”. Non dimentichiamo che quella russa è la cultura che ha generato una delle più straordinarie letterature al mondo, capace delle profondità di pensiero di Dostoevskij, Cechov, Tolstoj, Gogol, una cultura fertile in ambito scientifico con grandi fisici e matematici, e grandi sensibilità musicali.
Non solo, lo stesso Alexandr Solzenicyn, ringraziò l’America per avergli offerto asilo e protezione, ma chiarì che la Russia che usciva dalle macerie del comunismo non sarebbe mai potuta diventare una democrazia di tipo occidentale, ma che le soluzioni del dopo Urss andavano trovate nel solco della tradizione del suo grande paese, a partire dal millenario spirito religioso ortodosso. “Infatti – chiosa ancora l’articolista Sangiuliano -, l’esperimento della stagione eltsiniana di trasformare la Russia in una sorta di nuova America finì nel disastro sociale e soprattutto nel saccheggio mafioso delle risorse energetiche”.
“La società occidentale quando la si mette sotto accusa”, scrive ancora Solzenicyn, “essa è univocamente improntata a un rigido sistema di idee convenzionali”. Più che un buffetto mi pare uno schiaffo alla sicumera di tanti mass media che presuppongono la superiorità del sistema democratico occidentale su altre forme di organizzazione politica. Stessa parzialità la troviamo in Occidente a proposito dei giudizi dati sull’intervento russo in Cecenia, ora chi i Ceceni si sono dimostrati i più feroci tagliagole operanti in Siria e in Iraq, in molti oggi riconoscono che Putin ha evitato l’insorgere d’un pericoloso califfato nel Caucaso. Allo stesso modo, va riconsiderata la posizione di Putin che, nel 2003, non volle aderire all’operazione per spodestare Saddam Hussein, giudicandola avventata. Così abbiamo urlato per la distruzione di Palmira, ma poi è toccato ai russi liberarla, come già fecero con il grande tributo di sangue nella lotta al nazismo. Son sempre considerazioni di Gennaro Sangiuliano a proposito del libro dello svizzero Guy Mettan. Il quale, sul referendum in Crimea, scrive: “il fatto che il 95% degli abitanti si sia pronunciato a favore dell’Unione con la Russia non ha avuto alcuna importanza”. I politici occidentali, insomma, stentano a capire che la vecchia dicotomia Est Ovest non esiste più, mentre la vera sfida per la libertà non viene da Est ma forse da Sud.
Il mondo anglosassone è convinto che il perfezionamento dell’umanità debba coincidere con la sua nozione di società, che negli ultimi decenni presenta criticità enormi, con uno svuotamento di valori e l’esaltazione degli eccessi finanziari a danno della produzione dei beni. La Russia ha peculiarità storiche che si perdono nei secoli, a cominciare dalle sue dimensioni, e da ciò bisogna far partire ogni discorso, cercando di capire.
Tornando alla gita a San Pietroburgo, voglio accennare a due personaggi la cui memoria ho incontrato sulle sue strade: Puskin scrittore tra i miei preferiti e Kropotkin del cui pensiero anarchico m’ero innamorato in letture giovanili, oltre che della sua frase famosa a proposito di come deve essere consumato il caffè: “caldo come l’inferno e dolce come l’amore”.
Dostoevskij, in un discorso del 1880, cita Puskin nell’analisi del rapporto tra élite oligarchica e popolo, con quest’ultimo che identifica quello che chiama ceto dell’intelligencjia, che “crede di stare di gran lunga al di sopra del popolo”, responsabile di aver alimentato una “società sradicata, senza terreno” e ne censura il comportamento “svincolato dalla terra del nostro popolo”, affermazioni che, oltre ad essere di stringente attualità, nella difesa di alcuni valori, fa della Russia, con la sua cultura, non solo parte integrante dell’Europa, ma ne rappresenta meglio le radici. Scrive l’autore di Russofobia: “Senza Bisanzio non ci sarebbe stato nessun rinascimento italiano; ma senza Bisanzio e senza la Russia non ci sarebbero state né l’Europa cristiana né la civiltà europea”.
A proposito di Kropotkin, ciabattando per San Pietroburgo, mi sono meravigliato d’aver trovato una via dedicata all’illustre filosofo anarchico, considerando le divergenze tra il suo pensiero e quello marxista che ha caratterizzato la politica russa del Novecento, divergenze sfociate non di rado in veri e propri scontri fisici tra comunisti ed anarchici. Evidentemente, in questa città, si è guardato al contributo politico e filosofico d’un figlio della madre Russia. Sul quale non voglio dilungarmi, tradendo le mie simpatie, ma invito i più curiosi a ricercarne la profondità di pensiero anche solo cliccando il suo nome su internet.
Mi aggiungo alla schiera degli ammiratori di San Pietroburgo
Sia attraverso le sommarie immagini postate su Facebook sia di ritorno a casa, ho incontrato tanti amici anch’essi visitatori entusiasti di questa città. M’è venuto da pensare che il visitatore italiano di San Pietroburgo si lasci andare più volentieri nel raccontare la sua esperienza di viaggio con chi c’è già stato, come fosse una sorta di segreto da conservare con pudore, o, forse, come scappatoia da eventuali discussioni con gente inesperta di questa città, onde evitare la fatica di riferire le impressioni ricevute (non certo semplici da sintetizzare), oppure non volendo perdersi in giustificazioni sul perché e percome uno abbia scelto questa meta.
Superato il primo impatto di mia figlia con questa città, pessimista di trascorrervi una bella vacanza se non altro per le indicazioni stradali scritte in cirillico, il soggiorno, invece, oltre che piacevole s’è rivelato facile.
Come nella metropolitana anche nelle targhette stradali, sotto i nomi in cirillico c’è la versione scritta in caratteri latini, perciò ogni itinerario è fattibile dal centro alla periferia, in ogni ora del giorno, agevolata da una fitta rete di trasporti, oltretutto poco costosa. Come non mancano servizi al turista d’ogni tipo, dalle guide parlanti italiano, ai bancomat, al cibo somministrato nelle versioni culinarie più diverse, da quella locale, alla cucina internazionale, alle etniche… Con qualche titubanza a farlo, per le frequenti delusioni incontrate girando il mondo, se non nella qualità del cibo spesso nei prezzi esosi, ho frequentato il ristorante Mama Roma di gestione italiana, con grande piacere. Di buon gusto sia nell’arredamento, nell’allestimento dei tavoli e con il menù ben eseguito adatto a un pubblico eterogeneo. Anche in questo San Pietroburgo si rivela una città internazionale. In grado di soddisfare infinite curiosità, specialmente nel periodo delle notti bianche, in cui allo spettacolo naturale si aggiungono eventi che si adattano ad ogni gusto…e il clima non è male, come sarebbe da temere a quelle latitudini nordiche. Penso che, nel tempo, questa città guadagnerà sempre più ammiratori che la troveranno accogliente, bella e duratura, non a caso la pietra su cui poggia è il granito.
Gli isolotti su cui è nata San Pietroburgo, detta anche “Venezia del nord”,  avevano la stessa fragile consistenza della più famosa città lagunare. Perciò si rese necessario, specie nei perimetri spondali, usare le stesse tecniche di infissione dei pali alle fondamenta degli edifici, dal momento che la loro struttura era quasi sempre poderosa. Ma ben presto ci si rese conto che era necessario rafforzarne anche i margini, e, quand’era necessario, pure rialzali col granito per impedire l’esondazione del corso della Neva e delle sue diramazioni. Il granito, tra le pietre più resistenti all’erosione del tempo e degli agenti atmosferici, è usato anche nei colonnati, nei monumenti, compresi quelli funebri,… insieme ad altre pregiate pietre dure disseminate nei palazzi nelle chiese e negli spazi urbani, che la impreziosiscono e, al tempo stesso, la rendono stabile.
avevano la stessa fragile consistenza della più famosa città lagunare. Perciò si rese necessario, specie nei perimetri spondali, usare le stesse tecniche di infissione dei pali alle fondamenta degli edifici, dal momento che la loro struttura era quasi sempre poderosa. Ma ben presto ci si rese conto che era necessario rafforzarne anche i margini, e, quand’era necessario, pure rialzali col granito per impedire l’esondazione del corso della Neva e delle sue diramazioni. Il granito, tra le pietre più resistenti all’erosione del tempo e degli agenti atmosferici, è usato anche nei colonnati, nei monumenti, compresi quelli funebri,… insieme ad altre pregiate pietre dure disseminate nei palazzi nelle chiese e negli spazi urbani, che la impreziosiscono e, al tempo stesso, la rendono stabile.
Giuseppe Franciolini, vescovo di Cortona
La Chiesa offre variegate figure di sacerdoti, vescovi e cardinali. Papa Bergoglio – preferendoli di moralità specchiata, usi al contatto con la gente comune – fronteggia curiali resistenti alla sua visione evangelica pauperista, presi da privilegi e mondanità, se non lussuriosi malversatori di beni destinati al culto e alla carità.
Franciolini, ultimo vescovo cortonese residente nella diocesi, apparteneva ai prelati dal pensiero aristocratico, in graduale riduzione con la fine della monarchia in Italia, e la rinuncia al triregno da parte dei Papi.
Se pure le sue mani robuste rivelassero che, forse, da giovane le usò in lavori faticosi regalandogli una robusta fibra fisica, con cui superò novant’anni con pochi acciacchi.
Dagli anni Trenta agli Ottanta del secolo passato, resse la diocesi distinguendosi per moralità, senso civico, cultura raffinata, vita sobria, destinando propri averi all’incremento del patrimonio artistico cittadino. Il più prestigioso, commissionato a Gino Severini, fu il mosaico sulla facciata a valle della chiesa di san Marco, dedicato all’evangelista – dal leone simbolico, simile a quello dello stemma cittadino -, e le edicole musive della Via crucis che, da via delle Santucce, finiscono nel piazzale di Santa Margherita. Santa a cui fu molto devoto. Raffigurata sullo sfondo del ritratto giovanile di Franciolini. Vescovo arrivato a Cortona da Nocera Umbra, dov’era stato Rettore del seminario. Altro lavoro artistico finanziato dallo stesso è il portale bronzeo sul pavimento della Cattedrale: copertura della cripta dov’è sepolto.
Indole aristocratica – si sosteneva nutrisse simpatie monarchiche – non si distaccò dagli eventi contemporanei: il passaggio del fronte di guerra e il Concilio Vaticano secondo, a cui partecipò in qualità assistente al soglio pontificio.
Al passaggio del fronte, aveva invitato i curati a tenere il diario degli eventi nelle loro parrocchie, e molte di quelle vicende confluirono nella raccolta intitolata Piccola Patria, curata da Pietro Pancrazi. E, da dietro le quinte, autorizzò il giovane don Giovanni Materazzi a partecipare al locale Comitato di Liberazione, in quota Democristiana, e a impegnarsi con altri partiti al riassetto del Comune disastrato.
Franciolini, consapevole della frattura che divise il popolo cristiano per la scomunica dei comunisti (componente massiccia tra i fedeli), dopo rigidità iniziali, negando loro i sacramenti, ammorbidì la linea, consentendo nuovamente l’accesso in chiesa a tutti, comprese le giovani coppie di sposi. (Anche se i fedeli non torneranno in chiesa nella consistenza ante scomunica). Così come introdusse innovazioni suggerite dal Concilio: gli altari rivolti al popolo e la liturgia, canti compresi, in lingua italiana. Invitò alcuni vescovi conciliari a Cortona, favorendo il confronto su quella vicenda storica in corso, come fu col vescovo Pollio, ex missionario in Cina, al quale, durante la prigionia, si disse ch’era stata mozzata la lingua, perciò parlava stentatamente.
Sul pronunciato naso rosso (couperose?) di Franciolini, si mormorava indulgesse in alcoliche libagioni; ma la diceria gli portò bene: visse molto più a lungo di tanti astemi. Altra caratteristica era il suo lento incedere (camminando e parlando) che si tramutava in riti dalla lunghezza esasperante. I fedeli dovettero farsene rassegnata ragione. Specie d’inverno, senza riscaldamento in Duomo, al freddo fino alla fine di cerimonie interminabili. Tempi dilatati negli spostamenti da passi lenti e complessi protocolli, indossando vesti pesanti e preziose che gli donavano un’aura maestosa e surreale. Il suo incedere era complicato dalla vista difettosa. Operato alle cataratte, fu costretto a indossare occhiali dalle spesse lenti che gli ingigantivano i bulbi oculari, sbrigliando fantasie giovanili sul personaggio regale, quanto buffo a vedersi.
Al rigore del Vescovo nel seguire pontificali tradizionali, corrispondeva altrettanto scrupolo nell’interpretazione dottrinale. Ne fui testimone in Cattedrale, genuflesso in fila con altri in attesa della cresima: segno della croce con olio sulla fronte, fasciato da un laccetto bianco, e un buffetto dato nella guancia al neosoldatino della fede. Franciolini stava negando la cresima a un bambino il cui nome non appariva nel martirologio cattolico. Mi pare che il vicino si chiamasse Renzo, privo di santo corrispettivo. Gli assistenti si affannavano a far considerare Renzo diminutivo di Lorenzo, ma il Vescovo insisteva: quel ragazzo era da ribattezzare… Non ricordo l’esito della disputa, preoccupato per quel che mi stava capitando. Gli adulti s’erano divertiti a intimorirmi con la storia della fascia in fronte, che avrebbe coperto la ferita inflitta dal Vescovo con un chiodo! Ne dubitavo… però avevo la strizza.
Anche in cerimonie laiche, si temeva la lunghezza della chiacchiera del Vescovo, che, però, non era banale né fuori tema, ricca di spunti culturali ed esperienza. Mecenate, umanista, spiccata sensibilità artistica e poetica, espressa pure nella sua “Ghirlandetta Cortonese”: elegia d’un mondo religioso giocondo, d’una innocenza quasi infantile.
L’ultimo incontro con Franciolini a pranzo, in occasione dei suoi novant’anni. Finito il desinare, chiesi il permesso d’accendere il sigaro. Che il buon Vescovo accordò, verseggiando: “Io non fumo, ma volentieri sumo l’altrui fumo!” Gli piacevano giochi di parole. Come quella mattina – in visita alle aule scolastiche del seminario – udito un “Bischero!” urlato tra ragazzi, lemme lemme, s’avvicinò loro dicendo: “Bischero è una parola che, derivando dal latino, possiamo scomporre in bis carus due volte caro. Di per sé affettuosa. Però con quel tono v’invito a non usarla!”. Il monito pedagogico, mite e raffinato, cadde presto nel dimenticatoio, anche se i discoli non scordarono quella ed altre lezioni di calembour, impartite dal vescovo e dagli insegnati preti. Saranno state pure arguzie pretesche, ma c’è un detto: dalla scuola dei preti non escono bischeri! Appunto.
www.ferrucciofabilli.it