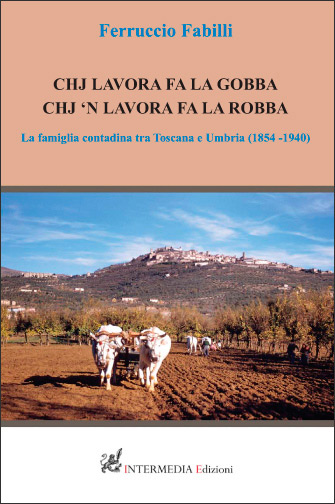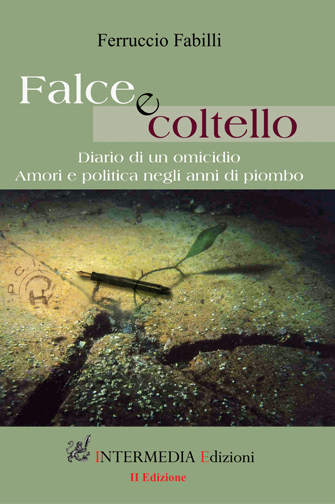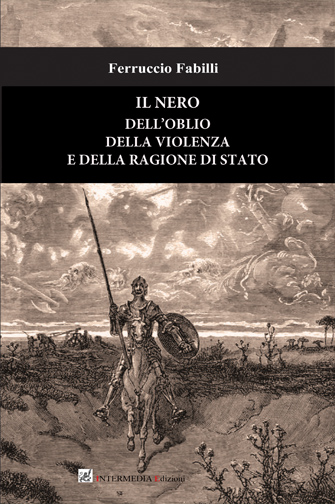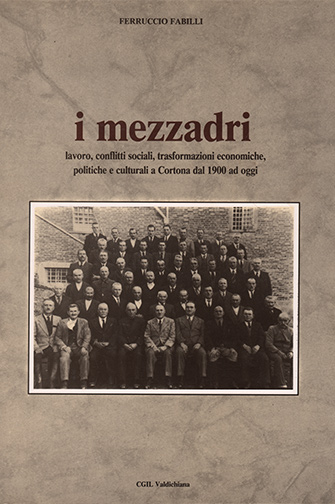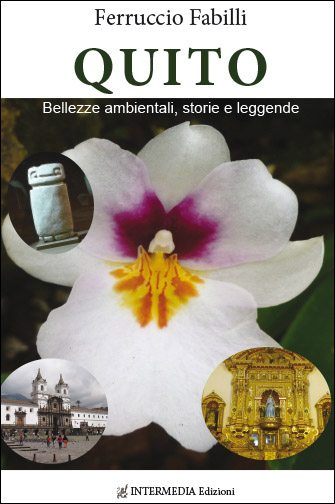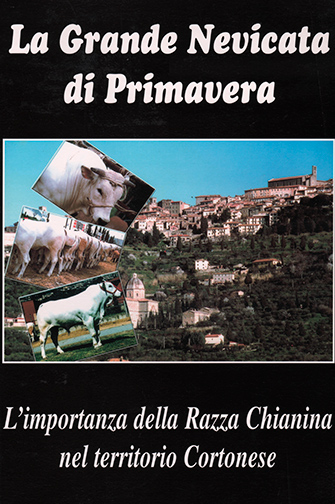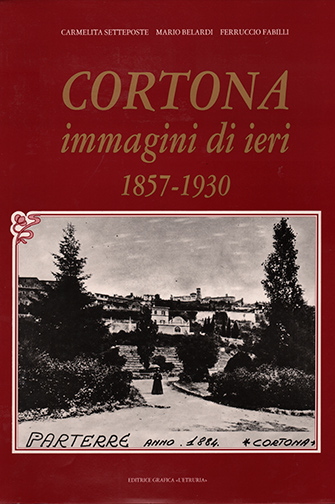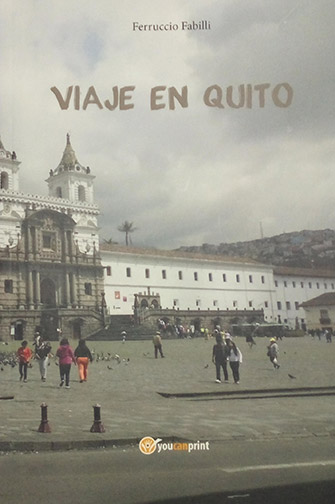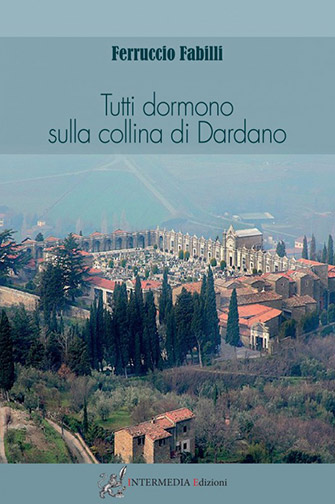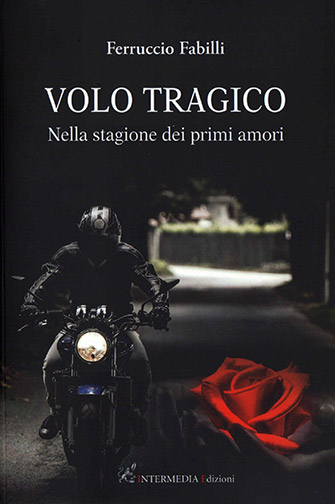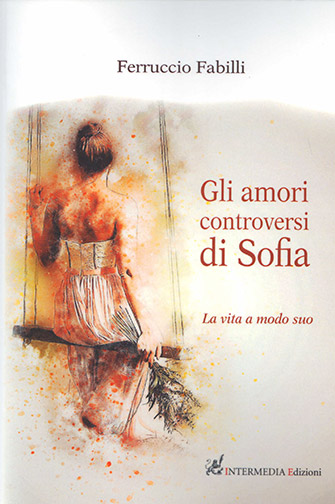Messaggio più recente
GUIDO CALOSCI una vita immersa nell’odore dell’inchiostro
Operaio tipografo negli anni ’30 del Novecento, deciso a mettersi in proprio, beneficiò indirettamente della Lotteria di Tripoli: allorché l’amico Alfredo Cariaggi – il cortonese vincitore sommerso da una montagna di quattrini – firmò a Guido le cambiali necessarie all’acquisto della locale “Tipografia Commerciale” messa in vendita dal Francini. Si trattava di una pioggia di soldi, ma a metà. Infatti, un altro cortonese riuscì a bloccare in tribunale la metà della vincita, pretendendone la divisione. Alla fine, Cariaggi la spuntò ricevendo anche l’altra metà del malloppo, ma quando il valore della lira era molto svalutato.
I locali della tipografia del nuovo proprietario Guido Calosci – classe 1892 – in via Passerini 4, al primo piano, si rivelarono inadeguati, anzi, pericolosi: incapaci a sostenere il peso delle attrezzature: una mattina, il pesante tagliacarte era precipitato nel piano sottostante! (Più o meno a quell’epoca, per la stessa causa – solai fatiscenti – durante una veglia funebre alcune persone precipitarono col morto al pian terreno).
Essendo costoso far impresa, Guido risparmiò anche sull’acquisto dei caratteri: scelse gli eleganti Elzeviro in quantità appena sufficiente a stampare, al massimo, ottanta pagine (cinque sedicesimi) d’un normale libro. Ricordiamo la pazienza certosina e la precisione richiesta, allora, per stampare una pagina: dovendo assemblare uno ad uno i singoli caratteri di piombo dentro una cornice di legno, detta “vantaggio”, nel formato dell’oggetto da realizzare: locandina, manifesto, rivista, o pagina di libro. Nel caso dei libri, una volta compilate e stampate le prime ottanta pagine, Guido doveva scomporle per riadoperare gli stessi caratteri nell’assemblaggio delle pagine successive; un cuci e scuci insistito fino all’ultima pagina. Non a caso, l’ho definita: “pazienza certosina”. Fino all’avvento delle linotype, paragonare il tipografo al monaco amanuense non è azzardato. E solo metodici alla Guido potevano dedicarsi a quel mestiere. Il quale si fece clienti sparsi in tutta Italia.
A partire da Cortona: il Comune, l’Ospedale, l’Accademia Etrusca, la Banca locale, poi vennero le Università di Palermo, Torino, Roma, Firenze, ecc. specializzandosi in testi di Diritto Romano e di Economia Politica. Volumi da comporre in greco ed anche con complicate formule algebriche. L’apertura del filone produttivo scientifico scaturì dalla pubblicazione d’una tesi di Laurea, premio universitario a uno studente laureato con Lode. Così presero contatti con la tipografia noti docenti: Bonfante, Scialoja, Riccobono, La Pira, Segré, Sensini, Chiazzesi, ecc., che poi incaricavano importanti case editrici per la distribuzione e la vendita.
Problemi a Guido non mancarono. Come quando, ultimata la stampa d’un volume ordinato e pagato dall’“ebreo” torinese prof. Gino Segré, a mezzanotte si presentò il maresciallo dei carabinieri per il sequestro di tutti i volumi – già predisposti nelle casse per la spedizione -, in forza delle leggi razziali che proibivano pubblicazioni d’autori ebrei. Delle casse pronte, il maresciallo suggerì a Guido di nasconderne una per spedirla all’autore-committente una volta passata la “nottata”. E così fu. Caduto il Regime, la cassa dei libri raggiunse Gino Segré.
Non erano segrete le idee “sovversive” di Guido il quale, di famiglia socialista, durante un soggiorno di lavoro a Roma, abbracciò idee comuniste conservandole sempre, convinto dalla scandalosa disparità sociale tra i signoroni che viaggiavano in carrozze trainate da quattro/sei/otto cavalli e i morti di fame che languivano nelle strade della capitale. La categoria dei tipografi rappresentò antifascisti risoluti, fino allo sciopero. Anche a Cortona, gli artigiani – a fianco di operai e contadini – divennero antifascisti strenui e organizzati. Come raccontò Pietro Pancrazi, nella “Piccola Patria”, a proposito delle tipografie cortonesi che, nello stampare volantini o manifesti clandestini, si scambiarono i caratteri per confondere la censura. Pietro Pancrazi fu cliente assiduo di Guido, come il fratello Luigi, di cui si ricorda la battuta scambiata col commediografo Corrado Pavolini, incontrandosi in tipografia: “Anche tu hai questo vizio?!” Accomunati dallo stesso piacere di pubblicare scritti, simboli di vitalità culturale e di libertà.
Pubblicamente Guido dovette adeguarsi, indossando la camicia nera. Minacciato dal Podestà di cancellarlo dai fornitori degli Enti Pubblici, come padre ritenne prioritario far crescere i quattro figli: Enzo, laureato in Fisica alla Normale di Pisa, Adele, Giuseppe – continuatore dell’azienda, cambiandone la ragione sociale, da “Tipografia Commerciale” a “Grafiche Calosci”- e Sonia, che il prete non avrebbe voluto battezzare per quel nome esotico sospetto di filo-bolscevismo. Sebbene fosse il segreto di Pulcinella: Guido seguitava a condividere idee comuniste. Tantoché un dì, in una strada di Cortona, Ceppodomo (produttore di pastasciutta), vedendo Guido in camicia nera, commentò: “Tu sei come i fichi di Sant’Antonio: nero di fuori e rosso dentro!” Anche per i camerati era un rosso di cui, però, non disdegnavano la compagnia. Come quel giorno, nel ristorante al Torreone, riuniti a bisboccia, nel finale del convivio un fascista, fintosi ubriaco, tirò fuori la pistola urlando: “Dobbiamo farla finita con questi sovversivi!” e, premuto il grilletto, sparò a Guido. Il quale, sbiancando, cominciò a tastarsi e, con un filo di voce, pappagellò: “Dove so’ morto?!…” ma lo sparo fu a salve. Oltretutto Guido aveva trascorsi patriottici importanti: combattente nella prima guerra mondiale, e ben tre dei suoi fratelli v’erano rimasti uccisi. Mentre lui era tornato dal fronte sotto un’altra minaccia per la sua vita: la febbre spagnola. Quando nel vagone s’avvidero di lui febbricitante, in men che non si dica, scapparono tutti! Nel locale ospedale-lazzeretto, la malattia decorse benigna, non senza postumi: transitoriamente, Guido era svampito. Il medico, vedendo che ce l’avrebbe fatta, lo prese a cuore e una sera lo portò al Teatro Signorelli, dov’era in scena: “Il cardinale Lambertini”. Nella quale, il cardinale, in confessione, conobbe il vero assassino d’una persona della cui morte, invece, era stato incolpato suo fratello. Al fine di scagionare il congiunto, il cardinale si finse pazzo. A quel punto della commedia, si verificò un siparietto divertente: Guido, pensando che l’attore/cardinale pazzo stesse parlando con lui, iniziò a rispondere, finché l’amico medico fu costretto a portarlo fuori dal teatro.
AGOSTINO dalla Legione Straniera a venditore di “materazzi”
Ai lati, nel rettilineo tra Ossaia e Camucia, son collocati cartelloni con messaggi pubblicitari di aziende di cui conosciamo questo o quel familiare, ma d’una m’era rimasto il mistero: Materassi Hawaiy flex. Per quanto intrigante, l’allusione al tepore tropicale, rovistando tra conoscenti, non trovavo cortonesi dediti a produrre il conforto del sonno – caso mai lo commerciavano. Notando quella pubblicità, negli anni Ottanta, pensai a un’impresa difficile, forse di breve durata. Condizionato dai discorsi insistiti in Consiglio Comunale, specie di Alarico Pazzaglia – un amico, residente non lontano dalla sede del PIP – il quale sosteneva che non vi si producesse granché… prevalendo il commercio sulla produzione (ma, dico io: non si produce per vendere?). Per fortuna, a distanza di anni – durante una crisi economica terribile – ci sono ancora commercianti nel PIP, insieme a produttori pure di alta gamma – con marchi propri o per conto terzi -, compreso il materassaio, che finalmente ho conosciuto. Ed è stata un’esperienza da raccontare.
In un fondo della sua azienda, m’ha ricevuto Agostino Raffaelli, il titolare, seduto ad un grande tavolo cosparso di oggetti vari, compresa una damigianetta – penso di vino – e una filza di telefonini ogni tanto trillanti. Lieto di svelare la sua storia intrigante.
Nato a Roma – gennaio 1933 – nel quartiere popolare di san Lorenzo, fin da piccolo si manifestò, a dir suo, un “ribelle”. Tra il discolo e l’ipercinetico: insofferente dei banchi di scuola già in terza elementare, e, sempre a quell’età, tentò le prime fughette da casa. Un giorno, il babbo trovandolo al girello in ore scolastiche a giocare a “tappi”, l’indomani, decise d’accompagnarlo in classe per sincerarsi sui giorni d’assenza. Il maestro supplente, interrogato, disse: “Son qui da un paio di mesi, ma suo figlio non l’ho mai visto!” Quando la madre dava ad Agostino qualche soldo per spese domestiche, era facile che non rientrasse a casa per giorni, finché non aveva speso tutto in cibo e bevande. A dormire s’arrangiava: negli androni o in soffitte, compresa quella di casa; dov’ebbe pure la compagnia sgradita d’un grosso sorcio di cui, impaurito, si liberò a calci, mandandolo in bocca al gatto acquattato sulle scale.
Il luglio ’43 fu terribile per il quartiere di san Lorenzo. Bombardato dai futuri alleati, suo padre rimase sotto le macerie, Agostino, con mamma e sorella, si rifugiò a Borgo Velino, nel reatino. Ma anche lì, il “ribelle”, in agosto, scappò di casa. Girovagando, giunse al campo d’aviazione a Rieti, incontrando l’ospitalità degli avieri. Ma durò poco. L’8 settembre, i militari fuggirono mentre sopraggiunsero altri armati: fascisti e tedeschi. Rimasto solo, gli fu chiesto dai nuovi arrivati: “E tu, che fai qui?” raccontò che, in aeroporto, prestandosi a lievi incombenze si era trattenuto coi soldati (non c’era da meravigliarsi, in pieno conflitto, d’un ragazzino disperso dalla famiglia). Aveva dieci anni. Rimasto simpatico anche ai nuovi arrivati, fu aggregato come mascotte della Legione Tagliamento. Vestito di tutto punto in divisa da camicia nera, compreso il distintivo della M rossa, e dotato di un moschetto. Fanatizzato dalla divisa, incosciente, stette in mezzo ai pericoli bellici dal ’43 al ’45. La legione Tagliamento, operativa a Vercelli, affrontò partigiani e compì rappresaglie. Orrori che gli furono risparmiati, essendo ancora un bambino.
Negli anni successivi alla guerra, fino a settembre ‘53, adolescente, s’ingegnò in mille mestieri, fin quando un amico gli suggerì: “Agosti’, perché non andiamo nella Legione Straniera? Si guadagna bene, e qui non c’è molto da fare!…” L’amico più grande, era del ’30, convinse Agostino a racimolare un po’ di soldi necessari per l’espatrio avventuroso, fino a Marsiglia, dove arruolavano nella Légion Étranger.
Gli fu dato un nuovo nome: Raphael Rossi. L’impatto fu duro, col rigore militare dei Legionari e con l’addestramento in zone selvagge Algerine: tra Sidi-Bel-Abbes a Bossouet, fino all’aprile del ’54. Se facevi il letto non avevi tempo per la colazione e viceversa, ma saltando la colazione non eri punito, mentre non facendo perfettamente il letto, invece della libera uscita venivi consegnato… questi erano gli avvii delle giornate! prima di lunghe marce spossanti. A sera, Agostino aveva i suoi momenti di fortuna sfacciata al gioco delle carte: vinceva sempre! E senza trucchi.
Gli capitò di vincere soldi a un mafioso siciliano (Sidone) a cui aveva fatto prestiti, ma al momento dell’incasso della vincita il siciliano mostrò le sue intenzioni cattive: invitandolo a battersi, tirando fuori una lama smisurata! Davanti alla quale Agostino s’arrese senza battersi, facendosi amico il siculo tremendo, confermandosi ancora una volta “ribelle” all’acqua di rose: gli piaceva trasgredire e ribaldeggiare, ma gli mancava la stoffa dell’avventuriero duro che sfida impavido persone e pericoli. Anzi, in pericolo, cercava sempre vie di fuga.
Nell’aprile del ’54, imbarcato nella nave Pasteur raggiunse Haiphong, e, da lì, Hanoi. Il primo incarico fu facile: a dirigere il traffico cittadino. Ma, un brutto giorno, stipato con altri cento nei camion raggiunse la zona di combattimento, dove scoprì la tragedia della guerra. Appena scese dal camion in una zona paludosa, con pochi villaggi sparsi, fu accolto da crepiti d’arma da fuoco ed esplosioni di bombe provenienti da tutte le parti. Agostino, scoppiò in lacrime, proseguendo in quell’inferno domandandosi disperato: “Ma che so’ venuto a fa?!…”.
Dormiva sulla paglia di riso, ma una volta scovatoci un serpente preferì riposare all’aperto… recandosi a prelevar acqua potabile, s’imbatté in un cobra…dopo una notte intera trascorsa in agguato, immerso nell’acqua d’una risaia, s’avvide coperto di sanguisughe in tutto il corpo… Trascorsi 4-5 mesi di questa vita orribile, con altri quattro commilitoni s’intesero: “Perché non ce la squagliamo? Qui ci lasciamo la pelle! Fuggiamo verso il confine Cinese!…” non lontano. Avevano pure la mappa.
Per due giorni marciavano la notte e riposavano il giorno, ma furono scoperti catturati e disarmati dai Vietcong. Agostino s’arrese subito, col presentimento tragico: “Qui facciamo una brutta fine!”
Chiariti i motivi della loro presenza in quella zona, non furono uccisi, bensì usati dai Vietcong come testimonial – esibiti qua e là – nella propaganda antifrancese: “Sono disertori, simpatizzanti comunisti!…” la gente curiosa li osservava e li toccava nelle parti irsute del corpo dove gli orientali sono glabri o scarsamente pelosi.
Cinque mesi di prigionia in mano ai Vietnamiti: senza catene, potevano circolare liberamente…nella foresta. Era impossibile fuggire, disarmati com’erano avrebbero fatto una brutta fine: ripresi dai Viet o incontrando le tigri.
Scarsamente nutrito con un po’ riso e carne di serpente, cane, maiale,…Agostino deperì: “Non ce la faccio più!” era giunto al lumicino. Quando ai prigionieri comunicarono uno scambio di disertori con i francesi. Erano trascorsi 5 o 6 mesi d’inutile e rischioso vagabondaggio per tornare da dov’erano scappati. Prospettiva per nulla allettante.
Ricoverato in ospedale, Agostino fu rimesso in sesto, ma l’attesero le cure del Deuxième bureau: i servizi segreti. Interrogato, il prigioniero-disertore sostenne che l’unica intenzione era tornare a casa per scampare da quell’inferno, però i carcerieri, non convinti o incavolati da quella giustificazione, lo caricarono di botte!
Nel frattempo, riuscì a informare la mamma che l’attendeva un processo per diserzione. La donna premurosa e accorta, interpellando la Croce Rossa Internazionale, riuscì a procurargli l’intervento al processo, come avvocato, di uno dell’ambasciata italiana. La diserzione in zona di guerra era punibile con la fucilazione, Agostino se la cavò con 10 anni di galera da scontare alla Santé.
Trascorso un mese di carcere a Saigon, fu imbarcato nei bassifondi d’una nave passeggeri scandinava, diretta in Francia, insieme a una novantina di galeotti della peggior specie, che sottoposero Agostino a sopraffazioni e violenze brutali. Ricordiamo, lui era un ribaldo ma incapace di prepotenze o violenze. Anzi, temendo e ripugnandogli la violenza, diveniva facile preda di gentaglia senza scrupoli.
A Singapore, alcuni tentarono la fuga dalla nave, ma catturati dagli inglesi furono riconsegnati ai carcerieri. In caso d’evasione, funzionava l’intesa reciproca tra le due potenze coloniali inglese e francese: i fuggiaschi venivano catturati e riconsegnati al legittimo detentore senza scampo e nel minor tempo possibile. Tuttavia la piccola scorta di carcerieri francesi era troppo invitante affinché i galeotti non tramassero altre fughe. Un’altra fu programmata al porto di Suez. Anche se per cautela la nave stazionò lontano dalla terra ferma, i galeotti attuarono una clamorosa ribellione in un gran parapiglia – con otto morti – disarmati i carcerieri alcuni galeotti si gettarono a nuoto. Finché non intervennero le guardie egiziane che sequestrarono le armi dei carceri francesi, giustificandosi: “Qui siete nel nostro territorio e armati siamo solo noi! Vi ridaremo le armi, passato il canale di Suez!” Agostino, troppo distante dalla terraferma, preferì non gettarsi in acqua, conscio delle sue scarse capacità natatorie. Tuttavia rifletté sull’importante novità: le guardie francesi erano disarmate. Perciò sarebbe stato impossibile ricevere una scarica di pallottole in caso di fuga durante la traversata del canale, in cui le bracciate per giungere a riva erano alla sua portata. Agostino, rotto l’oblò, si gettò in acqua arrabattandosi alla bene meglio a nuoto, fino a giungere a riva lordo di petrolio e delle acque di scarico delle navi in transito. Incamminatosi lungo l’argine, sul versante israeliano, il più pericoloso perché ancora minato, fu sorpreso da una motovedetta inglese che gli intimò di fermarsi: in inglese, francese, arabo, italiano… ma lui faceva finta di non capire. Finché gli gracchiarono dall’altoparlante: “Fermati o ti spariamo!” Caricato sulla motovedetta, fu portato a un centro di accoglienza e identificazione, per 10-15 giorni. In luogo confortevole: una tranquilla villetta con pochi ospiti, retta da un pacioso ras dal fez in testa. Un clima giusto anche per scattare foto-ricordo. Nel frattempo si risolse la diatriba tra ambasciatori, francese e italiano, che si contesero l’autorità su Agostino.
Rispedito finalmente in Italia, finì in carcere militare per renitenza alla leva… ovvio a quella italiana. Meglio, comunque, dei dieci anni in carcere alla Santé.
Tornato libero cittadino, riprese a praticare mille mestieri. Compreso il venditore ambulante. Vedendo un amico, ambulante come lui, che vendeva materassi caricati sul portabagagli, volle informarsi bene se fosse un commercio interessante. “Ci guadagno 3-4 mila lire al giorno”, era l’anno 1966, quel guadagno non era poco.
Agostino ottenne dalla mamma il prestito di 124 mila lire – anche lei venditrice ambulante, proprietaria d’un furgone 138 Fiat. A Napoli, da un grossista, riempì il furgone di 120 mila lire di materassi, dei quali non sapeva né il costo, né conosceva la tecnica per venderli. Cominciò andando in giro, coi materassi caricati sul portabagagli di una Fiat 1100, insieme al venditore napoletano Scapicciobello, che strillava nel megafono: “Accattatevi o materazzo, o pagliaraccio!…” ma non funzionava. Scelse la compagnia nuova d’un amico stracciarolo, Coccoricò, uno che sapeva vendere: conosceva persone, borgate, …con lui piazzarono numerosi materassi. Allargando sempre più il giro di vendite, giunse a Centoia – dove organizzò un magazzino di stoccaggio – quando già aveva una decina di “vagabondi” avviati da Agostino al commercio di materassi. Complice Giocondo, conobbe sua moglie, la signora Mariotti, d’origini contadine, umbra che prese Agostino anche per la gola… durante la nostra chiacchierata, profumi antichi d’arrosto alla contadina ci stavano raggiungendo dalla cucina.
Così, tra quegli invidiabili aromi casarecci, ho raccolto la sintesi della vita d’un imprenditore cortonese che già confida sulla collaborazione dei figli. La ditta ha mantenuto nella capitale un negozio piccolo ma ben messo e frequentato, gestito da sua figlia Nadia con vendita diretta, mentre il figlio Vincenzo è rimasto nella sede di Cortona. I materassi seguitano ad essere un bene continuamente richiesto, anche, se abbandonate le molle, oggi, la gente vuole il Memory. Più confortevole, igienico, non traspira umidità, e non si deforma. Parola di Agostino Raffaelli.
SE 60 MILIARDI [di euro] DI CORRUZIONE SEMBRANO TROPPI…
Nell’ ultimo numero dell’Etruria Giuseppe Calosci mi/si domanda da dove avessi tratto quell’ impressionante dato di 60 miliardi: il costo annuo della corruzione in Italia. Alcune testate giornalistiche, come il Fatto Quotidiano, sono riuscite a ricostruirne la storia dalle origini che risalirebbe a una ricerca della World Bank (Banca Mondiale) del 2004, dove si sosteneva che ogni anno il costo mondiale delle tangenti sarebbe stato di 1000 miliardi dollari – il 3% del PIL Mondiale – avvertendo che la cifra non rappresenterebbe da sola i costi complessivi della corruzione e la situazione varierebbe significativamente da paese a paese. Partendo da quella cifra complessiva e da quella percentuale, applicate al PIL italiano dava i 60 miliardi di cui parliamo. A quella stima sono seguite altre conferme autorevoli: dalla Commissione Europea e dal Consiglio di Stato nel 2013. La clamorosa cifra è stata pure contraddetta come eccessiva da Carlo Giovanardi, mentre è stata ritenuta attendibile da Libera e Gruppo Abele e persino da Corrado Passera ex ministro dello Sviluppo Economico. Se non che sono intervenuti anche studiosi come il prof. Picci – che da anni si occupa di metodi per il calcolo della corruzione – per il quale quella cifra rappresenterebbe la punta dell’iceberg, “visto che non terrebbe conto di tutte le distorsioni che la corruzione produce”.
Ma quali sarebbero le più recenti valutazioni in proposito? Secondo il prof. Alberto Vannucci – docente di Scienza politica a Pisa, tra i massimi esperti in Italia sulla materia – sarebbe una stima sballata, ma al ribasso. Perché, ad esempio, prendendo per buoni i calcoli della Corte dei Conti, secondo cui la corruzione genera il 40% di spesa in più nei contratti per opere, forniture e sevizi pubblici allo Stato, risulta che il costo della corruzione raggiunga la cifra superiore di 100 miliardi di euro l’anno!
L’ultima conferma, che questo dato sarebbe acquisito oramai pacificamente, è venuta ieri sera durante un’inchiesta giornalistica in TV a Presadiretta.
www.ferrucciofabilli.it
ANGIOLO, “Scandaglio”, Alì Babà tra Quaranta Ladroni
Angiolo Salvicchi detto Scandaglio – per capacità impressionanti di recuperare palle, nel gioco della pallavolo, schiacciate nei suoi pressi – basso di statura, aveva un capoccione. Forse, causa della particolare struttura corporea andava ricercata nella fame patita da ragazzo: la capoccia brillante era necessaria per procacciare cibo al corpo minuto. Privazioni che Angiolo – battendo sui fianchi ripetutamente le mani a taglio – ricordava: “La fame ch’ho patitooo!…” a chi si meravigliava della tenuta formidabile del suo stomaco. In certi pranzi compensava in modo pantagruelico le pene di gola passate. E trovarlo di cattivo umore non era facile. Anche se abbattuto, non perdeva l’ironia, citando metafore o episodi tragicomici a mo’ di scacciapensieri. Come quando raccontò – in seguito al grave incidente che lo ridusse in fin di vita – d’essersi visto dall’alto, sdoppiato dal corpo, a incitarsi: “Forza Angiolo! Devi farcela!…” Perciò Angiolo può considerarsi, a buon diritto, tra i massimi filosofi stoico-edonisti Cortonesi. Infanzia stentata, tra orfani in collegio (se ben ricordo) a perfezionare l’arte della sopravvivenza. Assunto all’Ospedale, ne divenne Provveditore Economo per anni. Sbocco naturale per colui che ritenne prioritario conquistare un “posto” in grado di garantirgli la sicurezza alimentare. Per poi mettere a disposizione dei ricoverati la sua tenacia nel provvedere ai tre pasti al giorno. E non mancò al dovere giornaliero di fornire: vitto, medicamenti, coperte, riscaldamento e quant’altro necessario nella complessa organizzazione sanitaria. Cambiavano amministratori e medici, più o meno capaci, e c’era pure da fare i conti, nel secondo dopoguerra, con cicli economici d’un Paese esposto ad alti e bassi anche clamorosi.
Scandaglio se la cavava lo stesso, con pochi o tanti soldi. E se qualcuno, sottovoce o sfrontatamente, insinuava ch’era un profittatore, non si scomponeva. Anzi, rintuzzava il fuoco col racconto spassoso di quando, mescolato a un discreto numero di economi italiani, fece visita a una multinazionale di prodotti per l’igiene – la Henkel. Portavoce del gruppo, dinanzi al direttore generale – tendendogli la mano – si presentò così: “Piacere! Alì Babà e i Quaranta Ladroni!…” indicando i colleghi. Inutile nascondersi: qualcosellina agli economi era impossibile non rimanesse attaccata alle dita… (Il fenomeno in Italia è comune a tanti altri “servitori dello Stato”, non solo Economi, sottraendo all’erario ogni anno oltre 60 miliardi di euro).
Pronto e sagace se la sbrigava in ogni circostanza. Come quando fu annunciata un’ispezione ministeriale. La preoccupazione principale era far corrispondere il patrimonio iscritto nell’inventario con quello realmente posseduto. Alla verifica, mancavano delle coperte. Non che quelle ospedaliere fossero di pregio – allora come ora -, tuttavia, nel continuo via vai tra malati, parenti e personale, più d’uno s’era fottuto il copriletto. Agli addetti del guardaroba, Scandaglio ordinò che un certo numero di coperte fosse diviso in due allo scopo di pareggiare i conti tra l’inventariato e il materiale disponibile. Con quell’espediente furono gabbati gli ispettori ministeriali. Ma anche se ne fossero avveduti, di fronte a tante ruberie viste in giro, avrebbero probabilmente chiuso un occhio su quella misera frode. In molti ospedali italiani, ben più costosi sarebbero stati i danni da denunciare. Come, ad esempio, forniture di apparecchi mai usati giacenti in remoti nascondigli.
Angiolo aveva una personalità risoluta verso chiunque, però, fedele all’azienda, lavava i panni sporchi in casa e non in piazza. Senza risparmiare critiche o prese in giro a chi lo meritasse, con l’aggiunta di arguzie carnevalesche. Quel che capitò a Gino Svetti – tra i più diligenti amministratori con cui ebbe a che fare. Scandaglio, sapendo della sua imminente decadenza – approfittando che ogni giorno Gino passava nel suo ufficio con qualche problema da risolvere – l’accolse burlescamente: “Svetti! ora hai finito di rompere i coglioni!…” facendogli il gesto dell’ombrello. Di lì a poco, Gino venne rinominato amministratore, seguitando tra i due scambi di battute salaci, e l’impegno di Angiolo a risolvere le beghe prospettate dal coriaceo superiore.
Un capitolo lungo meriterebbe Scandaglio organizzatore e animatore di feste e bisbocce. Gli piacevano compagnie allegre e gaudenti. E nessuno del suo giro di amicizie si sarebbe permesso mai di escluderlo da una strippata. Sempre disposto a imbrancarsi. Ricordo un viaggio di cortonesi a Paternopoli, in occasione del terremoto degli anni Ottanta. Riparati dal freddo e dal nevischio sotto una lamiera precaria, dentro un secchio fu preparata una gigantesca spaghettata al peperoncino. I cortonesi avevano sufficienti cibarie per sé e per i terremotati, i quali portarono una damigiana di squisito aglianico che ben presto volatilizzò! Durante la cena i paternesi s’erano lamentati d’aver visto a Battipaglia tanti beni di soccorso dei quali a loro nulla era toccato – a una settimana dal sisma – salvo il materiale di Cortona. Scandaglio, complice l’alcol, impiantò un comizio infervorato: invitandoci a correre a Battipaglia tutti insieme!… A stento, venne neutralizzato quello slancio generoso.
Altro episodio. A Chateau-Chinon. (In occasione del gemellaggio tra Cortona e la città francese, con Angiolo, a lungo, assiduo protagonista). Un assessore cortonese snob, ospite atteso dal capo dei pompieri, invece di raggiungere il Morvan stava spassandosela a Parigi. Gli organizzatori locali suggerirono di rimediare alla scortesia facendo visita al pompiere. Tra i primi volontari, trovai il pompiere talmente affranto che zampillava lacrime come fontanelle – mai visto prima –, inumidendo persino chi gli era di fronte! Felice di vederci e sfogare l’amarezza, cavò dal frigorifero le prime bocce di champagne d’una ricca provvista. Quando barcollanti scendemmo le scale, stava arrivando Scandaglio con altri cortonesi volontari dello sbevazzo. A quel punto fummo sicuri d’aver risolto l’incidente diplomatico, e lo champagne del pompiere non avrebbe preso d’aceto.
LA LOTTERIA DEI TESTS D’INGRESSO ALL’UNIVERSITA’ A CHI GIOVA?
Giannini, Ministra del MIUR, sembrava avesse fatto il verso di abolire i testi di ingresso all’Università, impegno che non ha mantenuto. Così seguitiamo ad assistere al triste peregrinare di migliaia di neodiplomati su e giù per l’Italia, sostenendo le più assurde e inutili spese che un genitore debba sopportare per aiutare i figli: viaggi, soggiorni e una bellissima tassa di partecipazione pagata a ciascuna Università in cui si intenderebbe iscriversi. Basterebbero a dimostrarne l’inutilità – o peggio, l’arbitrio, quindi l’ingiustizia e l’illogicità – le stramberie contenute nei quiz somministrati ai candidati, ai quali dichiarò che non sarebbe stato in grado di rispondere un eminente professore universitario – che ha scritto uno dei manuali più ponderosi e usati di Patologia Medica -, così come non si capisce il perché si chiedano, ad un aspirante Psicologo, nozioni di economia e altre simili scemenze, che più che testare la preparazione di uno studente alla fine non fanno altro che aumentarne frustrazione, senso di inadeguatezza e di ignoranza che, invece, dovrebbero avere chi li scrive e li assembla. Tornando all’esempio del luminare italiano della Medicina di cui sopra, sappiamo che il suo diploma di scuola superiore era di Geometra, essendo quello l’unico istituto superiore presente nel suo territorio negli anni Sessanta. Fortuna volle – per lui e per la scienza medica – che fu liberalizzato l’accesso a qualsivoglia tipo di Diplomato ad ogni tipo di Facoltà. Non solo, neppure era previsto il numero chiuso in alcuna Facoltà. Salvo in scuole di elite, tipo la Scuola Normale di Pisa. Dove aveva ed ha senso, essendo organizzate tipo college, dove studenti e docenti vivono l’intera giornata a stretto contatto formativo. Ma quante altre Università italiane godono di questo privilegio?
Lo erano prima dei test d’ingresso e lo sono rimaste, quasi tutte Università di massa, purtroppo – a paragone di altre nazioni evolute – frequentate poco e con scarso successo finale: siamo infatti alla fine deficitarii di laureati in fondamentali materie scientifiche, indispensabili al nostro sistema produttivo. Senza escludere che tra un po’ mancheranno pure i medici, dei quali in passato se ne è lamentato l’eccesso. Ecco il motivo per cui la nostalgia del passato è attuale, specialmente se aggiungiamo, a quell’apertura “liberista” all’accesso universitario, l’ampia disponibilità di finanziamenti per il diritto allo studio dei giovani meritevoli in disagiate condizioni economiche familiari. Oggi, infatti, lo studio universitario non solo è ostacolato da quelle scemenze di test, ma è diventato dai costi proibitivi per larghe fasce della popolazione. Se alle tasse universitarie – che in virtù dell’autonomia finanziaria sono molto lievitate dappertutto – aggiungiamo costi altrettanto lievitati come quello degli alloggi – poche Università garantiscono case agli studenti a costi calmierati – oltre ai costi del sostentamento e dei trasporti, è indispensabile che alle spalle di ogni studente ci sia una famiglia in ben floride condizioni economiche. Altrimenti ciccia.
Il diritto allo studio sta diventando un flatus vocis. E non si venga a dire che il numero chiuso consente una migliore didattica agli insegnati e la possibilità per gli studenti di usufruire di aule, laboratori, biblioteche, ecc.. Non farò testo, ma io frequentai proprio l’Università di massa aperta a tutti in facoltà mediche – dove sono indispensabili laboratori e spazi didattici attrezzati – ma non ricordo aule insufficienti, né eccessivi affollamento ai laboratori… Certo le università devono migliorare la loro assistenza agli studenti anche in forme tutoriali, ma, in epoca informatica, se funzionano addirittura le Università a distanza, dov’è il problema nell’accettare chiunque voglia scegliere la propria Facoltà preferita?
Ma il raggiungimento di Lauree in totale “anarchia” quali vantaggi porterebbe ai nuovi dottori? Si potrebbe obiettare.
Siccome il problema dell’occupazione dei laureati in Italia non è stato risolto neppure col “numero chiuso”, preferisco di gran lunga che i giovani seguano la propria passione nella scelta delle Facoltà e se avranno da tribolare per trovare un lavoro lo facciano con la piena responsabilità delle loro scelte. Non accetto che lo Stato ti induce a un percorso formativo non gradito, e poi tanto ti abbandona ugualmente al tuo destino.
AMARCORD IN VISITA A CORTONANTIQUARIA
Non essendo un compratore, vado in visita alla annuale Mostra del mobile Antico, ribattezzata di recente Cortonantiquaria, solo per il piacere di vedere cose vecchie, artistiche o artigianali, oggetti che, poco o tanto tempo fa, sono entrati nella vita di famiglie, persone, o luoghi di culto. (Anche quest’anno non mancano arredi, statue, crocifissi e oggetti usati nel culto cattolico, di qualità non eccezionale, ma certuni di buona fattura, come certe statue lignee di dimensioni quasi reali, tra le quali è notevole una statua lignea della Madonna col Bambino che sembra saltar giù dalle ginocchia della madre da un momento all’altro).
Entrando devi spogliarti del punto di vista del visitatore museale – anche se alcuni oggetti, quest’anno non molti, potrebbero farne parte – dovendo ragionare da collezionista immerso nel caotico bric a brac alla ricerca del pezzo desiderato, o con l’aspirazione generica d’essere affascinato da qualcosa di imprevedibile da portar via.
Nel solco della tradizione della Mostra mercato, ci sono – non molti – espositori specialisti di una materia: oreficeria, ventagli, stampe, quadri,…, a prima vista, è mancata dal passato la simpatica collezionista di armi antiche, presente in tante edizioni. Prevalgono esposizioni composite: tavoli, armadi, serviti da tavola o da pompa in argento o ceramici, trumeau più o meno preziosamente intarsiati, seggiole, arredi sacri, statue in prevalenza lignee, quadri,… Molti quadri, come sempre. Alcuni di autori “secondari”, se pure di elevata qualità: pennelli espressivi del buon gusto o di un’epoca, mentre in gran parte sono tele oscurate dal tempo, il cui fascino si limita poco più che alla patina antica. Forse, restaurati all’originaria luminosità, alcuni, potrebbero ancora suscitare emozioni.
Gli spazi espositivi accolgono antiquari provenienti da più parti d’Italia. Ma non ritrovi quella concentrazione di cortonesi, aretini, toscani del passato. Salvo il cortonese Bucaletti che espone oggetti di ottimo gusto e fattura, come usava negli standard degli anni più floridi in cui la concorrenza era tra prodotti eccellenti. Così ospitale che aveva lasciato sul tavolo centrale un pacchetto aperto di Toscani di mio gusto. Tranquillizzo Bucaletti, non ne ho approfittato. In un altro stand ho rivisto la presenza dei fiorentini Velona. Senza più la presenza del patriarca della ditta , tra i più simpatici animatori di questi giorni di Mercato. Così come, perché scomparsi o non più interessati, non si trovano più remoti e fedeli espositori: Stanganini, Billi, Rachini, Borgogni, Marri,.. e il grande patrono della manifestazione, l’aretino Ivan Bruschi, che morendo ha lasciato in dono alla città di Arezzo una collezione antiquaria degna d’essere elevata a Museo. Di lui, come degli altri che non tutti ho mentovato, ho cari ricordi di persone competenti e disponibili a condividere le loro aspettative, questioni private, difficoltà di mercato, suggerimenti per migliorare ogni anno il tasso qualitativo della manifestazione a cui dimostravano grande attaccamento. Per amore di Cortona, si sforzavano ogni anno, anche con cospicui impegni economici, di portare sempre il meglio. Bruschi, di animo nobile, mi rese leggera la non facile incombenza di comunicargli che il Consiglio Comunale si era rifiutato di assegnargli la cittadinanza onoraria. Negli anni Ottanta una certa etica politica aveva sindacato sul suo essere apparso negli elenchi della P2. Penso sinceramente che lui avesse consentito quella iscrizione per semplice atto di cortesia verso qualche suo concittadino (gli aretini nella P2 erano uno stuolo), non certo per aumentare prestigio professionale o profitti economici di cui non aveva certo bisogno. Ebbene, proprio in quell’incontro, lui, certamente dispiaciuto del mancato conferimento di una cittadinanza onoraria strameritata, mi accompagnò con estrema gentilezza a visitare casa sua, quella che poi è diventata la Casa Museo Ivan Bruschi. Senza trascurare di suggerirmi qualche ottimo ristorante a Londra dove sarei andato di lì a poco. Dall’accostamento di due imbarazzi, insomma, si rafforzò l’amicizia.
Come ogni anno Cortonantiquaria presenta una piccola mostra a tema: quest’anno è l’erotismo e la seduzione del corpo femminile. Rappresentati in oli, stampe e disegni di elevata qualità. Tra tutti spiccano una serie di disegni di Picasso, un vero maestro anche su questo argomento. Quasi novantenne, ancora apprezzava non solo artisticamente il fascino femminile, tradotto in una grafica chiara ed estremamente efficace nel trascinare l’osservatore fin nelle pieghe della sua passione.
Volendo riassumere l’esperienza d’una mattina, oltre ai ricordi del tempo passato di personaggi meravigliosi nella loro passione per i “tarli”, girovagando per gli stand di Cortonantiquaria di fronte ad oggetti consunti dal tempo e dall’uso, è stato un esercizio della memoria storica e artistica sull’uomo faber, che dovremmo regalarci di frequente, anche per rammentare che, mentre l’uomo è transeunte, molte cose da lui prodotte seguitano a testimoniarne nel tempo il passaggio. Non senza un velo di nostalgia per quelle amicizie passate che si battevano fieramente nella promozione della cultura antiquaria, oggi – mi è parso – non più tanto in florida salute, stante una crisi economica che colpisce senza pietà, a cominciare dai più poveri, ma pure le classi medie, un tempo tra i migliori acquirenti e cultori delle cose belle. Seguitando di questo passo, insieme al venire meno degli acquirenti italiani di antiquariato, il rischio più che remoto è che gli oggetti migliori del nostro patrimonio artistico finiranno – com’è accaduto – per dispendersi del tutto in mercati lontani.
AVRA’ VITA DIFFICILE IL CORTONESE NEODIRETTORE DELL’ARCHEOLOGICO DI NAPOLI
Le felicitazioni per la nomina di Paolo Giulierini, cortonese alla direzione di uno dei Musei Archeologici italiani più importanti, hanno presto lasciato il posto alle polemiche, soprattutto a livello nazionale sui criteri della nomina. C’è stato chi ha messo in discussione l’intero pacchetto di nomine – grosso modo – con queste due obiezioni: non rappresenterebbero le eccellenze tecno-scientifiche, e perché risultano esclusi eccellenti funzionari delle Soprintendenze? C’è stato pure chi ha mirato a criticare figure specifiche come nel caso di Giulierini: il suo incarico a Conservatore del MAEC non fu frutto di selezione pubblica, ma di cooptazione, le sue pubblicazioni scientifiche sarebbero di modesta caratura,…e via discorrendo, insistendo sulla presunta non idoneità all’alto compito, inoltre si segnalano – a paragone delle sua scelta – esclusi che avrebbero avuto più esperienza e altisonanti produzioni di ricerche scientifiche. Senza escludere che costoro procederanno a ricorsi per vie legali.
Insomma Giulierini, da certi punti di vista, pare in una situazione poco invidiabile.
Resta il fatto che il Ministro Franceschini ha voluto imprimere sulle 20 nomine il proprio marchio: una sostanziale rottamazione dei funzionari delle Soprintendenze e la ricerca di nuove energie in Italia e in Europa per dare maggiore dinamismo alle strutture museali, che, in verità, anche per colpe politiche ministeriali, non hanno dato alle eccellenti raccolte italiane quella visibilità internazionale ottenute da pari strutture straniere. Ricordavo come da solo il Louvre ha le stesse presenze di tutti i musei italiani messi insieme.
Non c’è dubbio che tra i criteri per i nuovi scelti ci siano stati margini di discrezionalità nel valutarne le candidature, consentendo manovre al Ministro Franceschini che se ne è avvalso con una certa spregiudicatezza. In questa alea discrezionale ci si è vista anche qualche mossa di partito, come nel caso di Giulierini. La riprova di eventuali errori di valutazione sui candidati non potrà che venire dai fatti futuri, quando i nuovi direttori si metteranno all’opera. Sul cui buono o meno felice esito, teoricamente, dovrebbe risponderne lo stesso Ministro.
Tuttavia, pur essendo questioni lontane dalla nostra portata, la vicenda pare non avere insegnato molto a livello locale, allorché in tutta fretta è apparsa sulla stampa la conferma di Giulierini a Conservatore anche al MAEC. Cosa che alcuni cortonesi avevano anche caldeggiato, credo, sottovalutando l’impegno. Per quanto piccola, ogni organizzazione Museale ha i suoi impegni quotidiani nel seguire il corretto andamento gestionale, oltre al fatto che se non si vuol sedere sugli allori c’è molto da lavorare in politiche di sviluppo che richiedono altrettanto se non superiore tempo, energie, capacità. Pensiamo, ad esempio, a uno scambio di materiale tra Musei. C’è la ricerca degli interlocutori di un certo livello qualitativo, per cui non basta avvalersi di agenzie, oltre alla stesura di programmi attuativi da sottoporre sia agli interlocutori sia agli organi di gestione e agli eventuali sponsor; e, una volta ottenuti tutti i semafori verdi, seguono le delicate fasi attuative che necessariamente gravano sulla figura del Conservatore, garante per tutti del buon fine del progetto e della incolumità del materiale prestato. Insomma di pronto e fatto non c’è nulla, ogni idea per svilupparsi richiede complesse azioni.
Nulla vieterebbe che si garantisca in futuro la conservazione del posto al Giulierini nell’ambito del MAEC, altro è vederlo protagonista contemporaneamente della direzione del MAEC e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, un impegno insostenibile anche da Nembo Kid.
Oltretutto perché negare, a livello locale, di far fare una esperienza di direzione del MAEC, procedendo a una selezione tra giovani esperti di antichità, nel frattempo che Giulierini ha il suo bel premio (comprese tante gatte da pelare) in quel di Napoli?
COMPLIMENTI A PAOLO GIULIERINI – STESSI CRITERI DI SCELTA PER IL SUO SOSTITUTO AL MAEC
La notizia che uno studioso cortonese, emergendo da una selezione pubblica europea, sia stato scelto a sorpresa responsabile del Museo Archeologico di Napoli riempie tutti di soddisfazione, non solo tra chi l’ha conosciuto e apprezzato.
Senza dubbio le sue qualità professionali da sole non avrebbero raggiunto questo prestigioso traguardo, senza il meraviglioso retroterra costituito dal rinnovato Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona.
Un successo siffatto non si improvvisa. Parte da lontano. Sia con l’impegno e le attitudini di Paolo negli studi e nel lavoro svolto; sia per il contesto in cui ha operato. Frutto di lungimiranza amministrativa e tecnico-scientifica nel realizzare nel Museo la rivoluzione copernicana degli ultimi decenni: collocando vecchie e nuove acquisizioni nell’intera struttura di Palazzo Casali. Scelte tecniche e ricerca delle ingenti risorse ascrivibili all’Accademia Etrusca nel suo insieme e, in particolare, a quanti si impegnarono in prima linea come i professori Edoardo Mirri e Paolo Bruschetti in sintonia con l’Amministrazione Comunale, retta dal sindaco Emanuele Rachini.
Già il ridisegno totale del Museo, della sua nuova organizzazione e gestione nacquero da un’illuminata apertura alle migliori competenze disponibili: locali, regionali e nazionali.
Una volta individuate e reperite le risorse (ingenti) necessarie per gli obiettivi prefissati, i tempi di realizzazione furono abbastanza rapidi.
Raggiunta la nuova veste museale, furono individuate le persone più adatte a gestirlo: esperti, dipendenti pubblici, e una cooperativa di giovani volenterosi e capaci. Ed è qui che si innestarono le attitudini e le competenze di Paolo Giulierini e dello staff direzionale che l’ha circondato nella rinnovata azione promozionale e nell’apertura verso i più prestigiosi musei europei, con scambi culturali e oggetti di valore rilevante.
Perciò, ora che si chiude la parentesi cortonese di Paolo, si dovrà aprire una riflessione tra Accademia Etrusca e Comune sul modo migliore di sostituirlo, evitando scelte che non siano di garanzia certa di continuità nella qualità.
E’ pur vero che Giulierini giunse a Cortona “casualmente” per mobilità da funzionario del Comune di Foiano, coincidendo la sua volontà con quella del sindaco Rachini che n’intravide le qualità potenziali e, contemporaneamente, fu favorito lo scorrimento della graduatoria del concorso a Foiano, in cui il successivo era Andrea Vignini. (Di questa agevolazione – i fatti diranno – Vignini non tenne alcun conto rispetto a Rachini).
Pure in tale casualità di intenti, Giulierini dimostrò ben presto che la scelta era ben fatta per se e nell’interesse del Comune, in particolare, guadagnando la stima degli Enti proprietari del Museo, nel momento in cui si doveva provvedere a costituirne i nuovi organi dirigenti. Fino a conquistare la fiducia – sancita oggi – dello stesso Ministro dei Beni Culturali che lo ritiene idoneo a governare una realtà museale prestigiosa e complessa: l’Archeologico di Napoli.
Possiamo affermare che Giulierini si sta accingendo a ripercorrere gli antichi passi dell’archeologo cortonese Venuti, tra le maggiori autorità scientifiche del suo tempo in territorio napoletano.
L’auspicio odierno è che Accademia Etrusca e Comune di Cortona procedano all’avvicendamento di Giulierini valutando qualità e prestigio di chi dovrà sostituirlo: che sia una persona altrettanto valida. In potenza o già affermata. Sia essa già attiva all’interno del MAEC, o, qualora non ci fosse, necessitando un nuovo innesto, si proceda in assoluta trasparenza ad una selezione pubblica sulla falsariga del Ministro dei Beni Culturali.
EVARISTO BARACCHI POETA E ARTISTA PLASTICO, MI “MANDO’ A SETTEMBRE” A DISEGNO…
E fece bene. Sfogliando la sua “Raccolta postuma” di poesie – curata da Ivo Camerini – intercalata da leggeri, eleganti e sensuali disegni di nudi femminili, mi rendo conto del disgusto che dovette provare di fronte ai miei schizzi agli esami di terza media! La prima prova, a giugno, consisteva nel riprodurre un limone, rimandato a settembre, era l’apparentemente più facile bottiglia di vetro; oggetti che il prof. Evaristo m’avrebbe senz’altro tirato in testa, vedendo la pesantezza grafica delle mie riproduzioni. La colpa sarà stata dei lapis poco appuntiti che lasciarono una traccia simile a una bitumatura stradale?!… Eppure il Prof. ci aveva insegnato come scegliere la rugosità giusta della carta: diversa fra il disegno geometrico e il disegno dal vero, e stessa attenzione avremmo dovuto avere per i lapis: ben appuntiti e appropriati a ciascun tipo di esercizio. Ma no. Non erano state le mie sciatte punte del lapis a sprofondarmi nella sciattezza, mi mancava quel che invece aveva Evaristo: il tocco artistico e una matura sensibilità poetica anche nelle creazioni grafiche.
La produzione poetica di Evaristo – numericamente contenuta – rappresenta tappe importanti della sua vita, evocando mutevoli sentimenti: affettivi, malinconici, ironici, estetici… al variare dell’età, dei luoghi e delle stagioni. Compresa una piccola serie di poesie in romanesco sulla falsariga di Belli e Trilussa: garbate prese in giro, in prevalenza, rivolte a situazioni o personaggi politici. La facile e gradevole consultazione è favorita dalla meticolosa e amorevole ricerca critica di Ivo Camerini, sollecitato dalla vedova Wilma Alari, compagna d’una vita di Evaristo Baracchi, che ha raccolto e messo a disposizione i fogli sciolti delle rime.
Questo piccolo libro, per chi ha conosciuto Baracchi, ne completa il profilo: massiccio, apparentemente severo, studioso di questioni agricole, impegnato nell’insegnamento e nella gestione della Banca Popolare di Cortona da vice-presidente, dotato di sottile ironia da toscanaccio – espressa nelle vignette pubblicate in quarant’anni nell’Etruria di Enzo Lucente – coltivava anche una vena poetica che distillò con parsimonia.
Leggendo e rileggendo le poesie di Baracchi – nella snella e curata pubblicazione dell’Editore Calosci – m’è tornata in mente una saggia considerazione d’un amico cultore di letteratura: “Ad ognuno, per riassumere il proprio senso della vita, si dovrebbero consentire al massimo 180 pagine!” In questo caso, in meno della metà è raccolto la sensibilità estetica e i mutevoli sentimenti d’un uomo in poche e piacevoli rime, accompagnate da una serie di disegni di nudi che rimandano agli affetti materni e alla inesauribile fonte di turbamenti e passioni suscitate dal corpo di una donna.
4 AGOSTO 1974 – ITALICUS – GLI ARETINI COINVOLTI – FU SOLO STRAGE O GUERRA CIVILE A BASSO IMPATTO?
A 41 anni di distanza, quale può essere il senso civico di ricordare quella tragica vicenda in cui persero la vita 12 persone e numerosi feriti? Per chi ha vissuto quei momenti come la mia generazione, ma anche per i figli e nipoti, ricordare intanto che protagonisti di una lunga sequela giudiziaria, processati per la strage sul treno Italicus, furono degli aretini. Insieme all’empolese Mario Tuti, furono aretini gli altri imputati: Luciano Franci, Piero Malentacchi e Margherita Luddi, mentre intervennero altri aretini coinvolti a vario titolo (gli avvocati Ghinelli e Graverini difensori degli accusati, e altri in qualità di sospettati, fiancheggiatori se non, addirittura, mandanti). Per giungere alla loro assoluzione trascorsero quasi due decenni. Una specie di otto volante giudiziario che vide gli imputati prima condannati (un paio addirittura all’ergastolo) e infine assolti. Sottoposti alla galera, al confino, a una interminabile gogna mediatica, alla distruzione di affetti famiglie e, in definitiva, alla negazione della loro vita. Purtroppo, però, sulla estraneità degli aretini nella strage persistono voci non concordi, come testimoniato dal libro dell’amico Luca Innocenti, contrariamente alla mia convenzione sull’equità della sentenza finale (raccontata nel “Nero dell’oblio, della violenza e della Ragione di Stato”). Tutto ciò perché accade?
Io e Luca non abbiamo scritto cose diverse per partigianeria politica, né tantomeno per simpatia o antipatia verso gli sventurati protagonisti giudiziari di quel tempo. Il motivo di tanta diversità va cercato nel groviglio di interessi nascosti da tanti segreti di Stato che ancor oggi impediscono di far luce piena sulla verità di quei fatti. Gli storici che scriveranno in futuro – tra quanti decenni? – saranno più fortunati di noi, potendo disporre di carte sparse in Italia e all’estero, oggi inaccessibili.
In breve, cosa ho scritto a proposito degli aretini al processo Italicus? Franci aveva rubato un grosso quantitativo di dinamite alle cave di Civitella. Tra i suoi obiettivi dichiarati, messi per iscritto in un volantino autografo, c’era un attentato dimostrativo nottetempo alla Camera di Commercio, mandandone in frantumi i vetri. In seguito a quel furto si verificarono “botti” dinamitardi – tra Natale e Capodanno – lungo la linea ferroviaria tra Arezzo e Terontola. Con danni solo a materiale ferroviario. Franci dopo poco fu arrestato mentre in compagnia di Malentacchi si recava a prelevare la dinamite in un nascondiglio, con in tasca il biglietto rivendicativo dell’attentato alla Camera di Commercio, ovviamente non realizzato. In carcere gli fu notificata l’imputazione per la “strage” di Terontola. Dove il “botto” aveva divelto alcuni centimetri di binario, senza morti né feriti, e i treni erano passati indenni. Pur avendo dimostrato che la notte dell’attentato era in servizio postale alla stazione di Firenze, fu condannato a 17 anni per strage – inesistente – “in concorso con ignoti”. Mai scoperti. Franci, in carcere ad Arezzo in attesa di giudizio, evase con altri due: Felice D’Alessandro e Aurelio Fianchini. Il D’Alessandro scomparve, mentre Fianchini nella redazione di Epoca si consegnò alla polizia dopo aver testimoniato de relato (per sentito dire) che Franci, Malentacchi, Luddi, e (facendo confusione sui nomi) aggiunse Gallastroni e Batani (quest’ultimo era persino in carcere il giorno dell’Italicus!). Gallastroni fu scagionato, ma gli altri furono imputati della strage in concorso con Tuti. A parte il dubbio che Franci abbia potuto autodenunciarsi di un orrendo delitto, la sequenza del racconto di Fianchini franò al processo, fino addirittura a scomparire da Bologna (sede del processo) all’inizio della sua testimonianza. Ma in treno cosa era esploso: la dinamite di Franci? No! Un potente esplosivo solo di recente in dotazione alla Nato. Che oltre ad esplodere sviluppò un tale calore da liquefare le strutture del treno. Se avrete la curiosità di rileggere la mia ricostruzione del processo tra le tante contraddizioni, invenzioni, ecc., colpisce la messe di depistaggi, per i quali furono inquisiti uomini dei servizi segreti, generali in pensione, ecc. insomma uomini di Stato; senza giungere al perché, ai motivi di tanti depistaggi, ma limitandosi alla semplice condanna. Quando ci furono condanne…
Tuttavia nel polverone ancora impenetrabile, che circonda quel periodo, ad alcuni punti fermi ci siamo arrivati. La stagione della “strategia della tensione” ha rappresentato una delle pagine più infami della Repubblica italiana. Basti ricordare quante persone innocenti ne furono vittime: dalla strage alla Banca dell’Agricoltura a Milano, fino alla stazione di Bologna. E quanti furono i depistaggi messi in atto dagli apparati dello Stato (si dice “deviati”, ma da chi? non certo da estranei agli ambiti politici ), non consentendo alla magistratura di stabilire verità certe su quella sequela di delitti. Sempre che tutti i magistrati si fossero dimostrati desiderosi di giungervi… E quandanche prendessimo per buone le poche sentenze di condanna dei responsabili, restano all’oscuro i mandanti. Ed è solo conoscendo i mandanti che si chiarisce il quadro delle responsabilità.
E’ inutile sottolineare che esiste più del sospetto, bensì la certezza di una convenienza dello Stato-Potere (di ieri e di oggi?) affinché non si faccia piena luce sulla stagione stragista. Che – non sono il solo a pensarlo – rappresentò una vera e propria guerra a basso impatto, con tante vittime civili, militari, giudici, poliziotti…il cui scopo fu destabilizzare il Paese e favorire una sorta di regime autoritario, come in Grecia. Con la differenza che in Grecia il golpe avvenne. Mentre in Italia permase a lungo uno strascico di sangue, di fatto raggiungendo lo stesso scopo che in Grecia: annullando la democrazia impedendo l’alternanza al governo di coalizioni politiche tra loro in competizione. E, in questo senso, la storia italiana mi pare ancor oggi infinita…
(Per un aggiornamento sullo stato attuale della ricerca storica sulla strage dell’Italicus invito ad ascoltare il saggista Massimiliano Griner su RAI tre, il 4 agosto alle 14.)