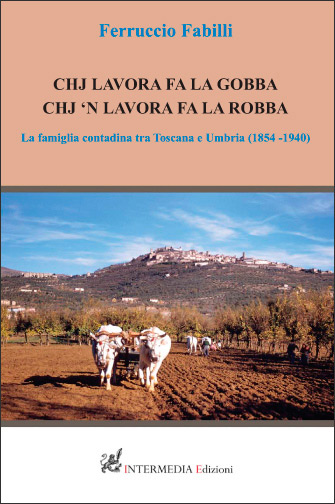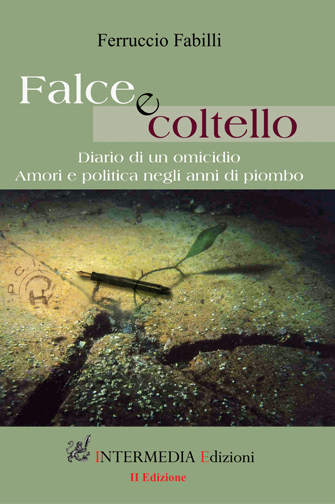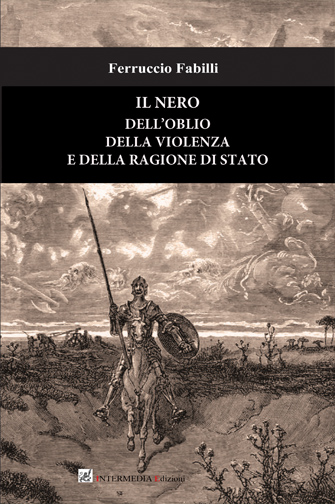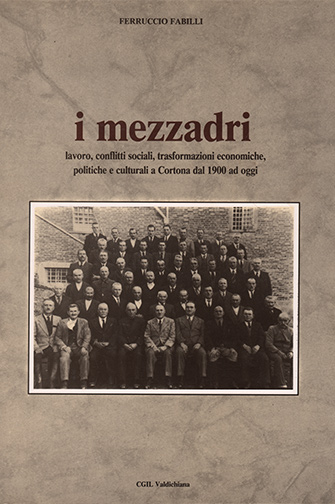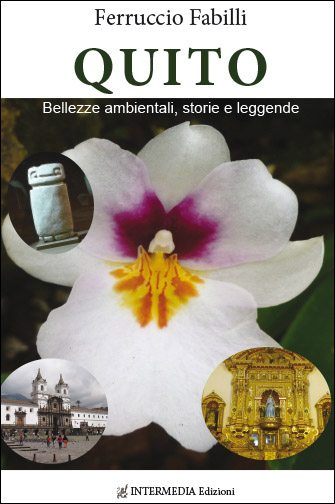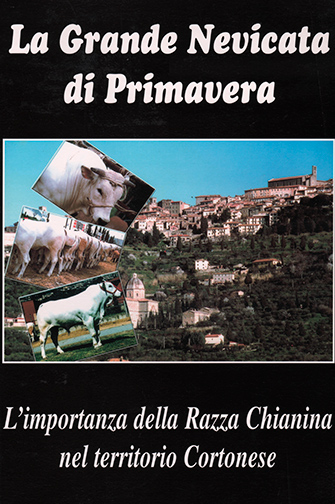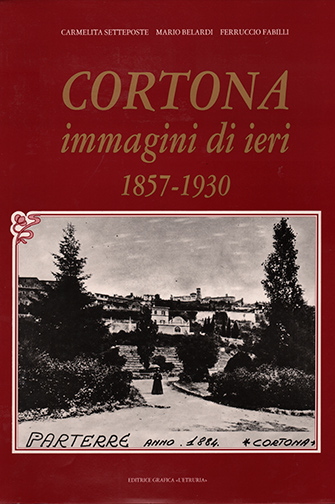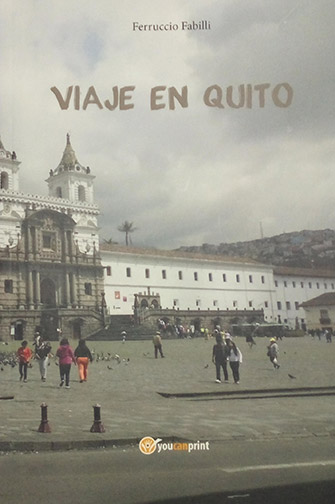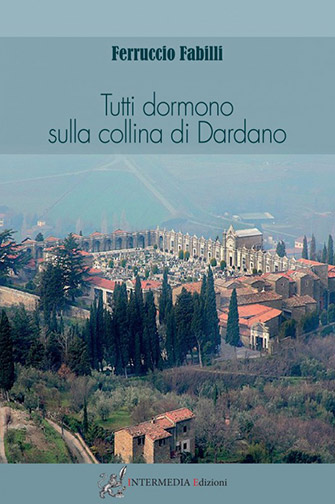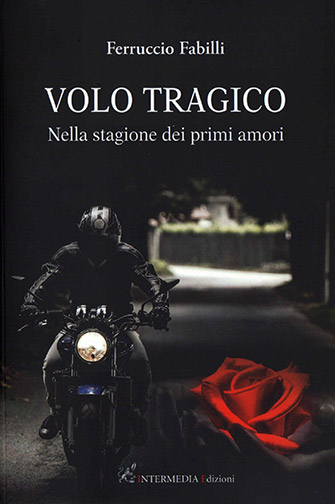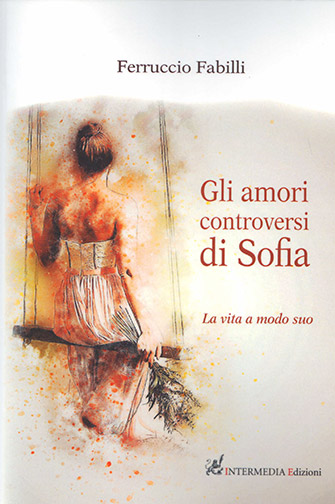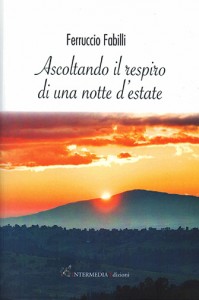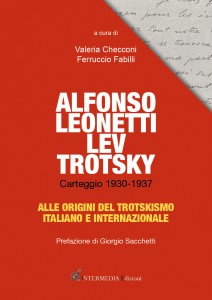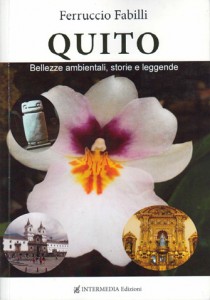Messaggio più recente
San Pietroburgo, notti bianche e ponti levatoi, culla europea d’arte politica e letteratura
 Ancora incerti i futuri scenari turistici, voleremo nei ricordi d’un viaggio adatto a questo periodo, che feci con mia figlia Brunella, a San Pietroburgo, a giugno. Mese delle notti bianche, protagoniste nell’eccelsa narrativa di Dostoevskij.
Ancora incerti i futuri scenari turistici, voleremo nei ricordi d’un viaggio adatto a questo periodo, che feci con mia figlia Brunella, a San Pietroburgo, a giugno. Mese delle notti bianche, protagoniste nell’eccelsa narrativa di Dostoevskij.
Pietro il Grande zar di Russia (dagli undici fusi orari) costruì dal nulla una capitale degna dell’impero sterminato, dirigendo i lavori dalla Casetta di Pietro il Grande, nel cuore della Città futura. Cambierà nome più volte. Pietroburgo, in origine. Leningrado, bolscevica. Post comunista, rinominata San Pietroburgo, in omaggio al fondatore e a uno dei Santi, Pietro e Paolo, titolari della Cattedrale nella Cittadella fortificata. Suggestiva enclave densa di memorie zariste, sorta in area paludosa, infatti un leprotto è simbolo della Città, essendovi stato cacciato in gran quantità.
Alloggiando nel centrale viale Bolshoi, avevamo più alternative tra itinerari a piedi e in Metro, col vantaggio di quasi ventiquattro ore di luce, nelle notti bianche. Giorni in cui l’immensa Piazza del Palazzo d’Inverno, sede del Museo Ermitage, stracolma di gente si trasforma in macchina per spettacoli notturni: come quello del Vascello dalle vele rosse spiegate attraversare il fiume Neva; omaggio agli studenti neo diplomati. Dopo cena, vedevamo il campionato di calcio europeo (2016). Finite le partite, scendevamo per una birra e far due passi, essendo ancora giorno, era meraviglioso!
La Neva, nel gettarsi in mare, forma un reticolo fluviale. Noi eravamo vicini alla Cittadella fortificata Pietro e Paolo, in una delle isole collegate da ponti, certi spettacolari levatoi, consentono traffici urbani e fluviali. Eleganza, dovizia monumentale e architettonica in grande scala, sono i caratteri della Città. Al cui disegno urbanistico e architettonico – della Venezia o Rotterdam del Nord – partecipò il talento italiano Bartolomeo Rastrelli, nell’incantevole stile tardo barocco dai tenui colori pastello, firmando la Cattedrale della Resurrezione, l’Hermitage Pavillon e il Palazzo di Caterina, il Palazzo d’Inverno, il Palazzo Stroganov, il Convento Smolny. Altro italiano naturalizzato russo, Carlo Rossi lasciò tracce notevoli su piazze palazzi teatri in stile neoclassico; egli è sepolto nel Cimitero Tichvin presso il Monastero di Aleksandr Nevskij, necropoli dei Maestri dell’arte e della cultura. Tra costoro: Dostoevskij, Cajkovskij, Borodin, Rubinstejn, Stravinskij,…Puskin, vissuto a Pietroburgo, giace fuori nella tomba di famiglia. Scrittore amato, perseguitato dallo zar, esiliato per filo populismo contrario alla servitù della gleba, pur di famiglia possidente. I populisti, precursori dei rivoluzionari, compirono attentati mortali contro gli zar, come quello su Alessandro II, ricordato dal sangue sul pavimento nella chiesa del Salvatore sul Sangue Versato; dalle cupole a cipolla multicolori (stile neo bizantino). Altrettanto grandiosa la cattedrale di Sant’Isacco, neoclassica, cupola alta oltre 100 metri (su gigantesche colonne di granito rosso) da cui si gode un panorama unico. La Città, in appena 300 anni di vita, ha una storia intensa e cruciale per la Russia e l’Europa. Le collezioni museali dell’Ermitage, tra le più vaste al mondo; da qui partì la Rivoluzione bolscevica, condizionando 70 anni di storia nazionale e mondiale; nella seconda guerra mondiale, la Città subì il più feroce assedio delle truppe tedesche a cui resistette 900 giorni, perdendo per fame e per armi oltre 600mila abitanti, su poco più di 2 milioni. Oggi, supera i 5milioni. Senza dubbio, il Centro Storico “zarista” è di gran lunga più affascinante, anche se non escluderei una capatina alla stazione Metro Moskovskaya, per l’architettura del regime comunista: la Casa dei Soviet; la gigantesca statua di Lenin; e il Monumento agli Eroici Difensori di Leningrado. Il quartiere offre poi una sorpresa: l’imperdibile Chiesa di Chesma (1780), dedicata da Caterina la Grande alla vittoria sulla Baia di Chesma (1770). Perché così periferica rispetto al Centro Storico? In quel luogo la Zarina ebbe la lieta notizia, durante una battuta di caccia!
Ampi volumi architettonici e distanze enormi, in scala col ruolo di capitale d’un impero sconfinato. Ciò non scoraggi passeggiate, aiutati dalla Metro. Purché non facciate come noi due, che, visitata la fortezza Pietro e Paolo, volendo vedere la corazzata Aurora (da cui fu sparata la cannonata dell’assalto del Palazzo d’Inverno), camminammo a vuoto una mattinata… Aurora era in restauro! Meglio informarsi sulle “aperture”. Memorabile l’escursione da Piazza dell’Ermitage alla Chiesa del Salvatore, a Palazzo Singer (il produttore delle macchine da cucire) stile liberty, sede d’una fornita libreria; infine, imboccammo l’immenso viale Prospettiva Nevskij, finendo al Monastero Nevskij e al Cimitero Tichvin. Area frequentata da turisti e fedeli; dove si affittano fazzoletti copricapo per signore per entrare nella chiesa ortodossa. La guida, Maria Lomaeva, risultò preziosa per non perdersi nell’immenso Museo Ermitage, portandoci diritti alle collezioni preferite. Perdemmo la pittura francese otto novecentesca per una manifestazione commerciale in atto – per campare i musei s’ingegnano. Mancammo pure la Camera d’Ambra, nel Palazzo di Caterina, non avendo prenotato a tempo, la meta è molto ambita. La stanza istoriata in ambra, depredata nella seconda guerra mondiale, è stata ricostruita integralmente.
Avevo visitato Mosca post comunista, bella e interessante per conoscere la millenaria storia Russa, che, nel Novecento, riprese il ruolo di Capitale, ma San Pietroburgo ti rimane dentro: i suoi colori e la luce incredibile non ti abbandoneranno mai più, e ti strega la sua storia che rivisiti a ogni passo. Gli elementi culturali ed estetici sono sintesi mirabili d’un’Europa dal grande passato: nelle arti, nelle lettere, nella musica, in politica,… promettendo un futuro altrettanto radioso, anche solo conservando il bello che ha già, permettendoci di goderlo. Sebbene chi ha nozioni profonde su San Pietroburgo stimi che la sua vitalità presente sia all’altezza del passato. Di certo, è un lato diverso e straordinario della Russia e dell’Europa.
fabilli1952@gmail.com
 Lungo i canali granitici della Venezia del Nord
Lungo i canali granitici della Venezia del Nord  Teatro
Teatro Palazzo della Marina
Palazzo della Marina Scorcio dell ERMITAGE , con Maria Lomaeva (guida) e Brunella Fabilli
Scorcio dell ERMITAGE , con Maria Lomaeva (guida) e Brunella Fabilli Arte rinascimentale italiana (Ermitage)
Arte rinascimentale italiana (Ermitage) Notti Bianche (alle tre di notte circa)
Notti Bianche (alle tre di notte circa) Tomba di Dostoviesky
Tomba di Dostoviesky  Palazzo Singer
Palazzo Singer Chiesa del Salvatore del Sangue Versato
Chiesa del Salvatore del Sangue Versato  Altro angolo visuale
Altro angolo visuale Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo nella Cittadella
Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo nella Cittadella
E’ urgente eleborare un progetto di riuso Dell’Antico Ospedale di Cortona
 Svenduto in fretta e furia dalla precedente Amministrazione Provinciale, quando denunciammo il fatto ci fu persino una reazione risentita del Presidente, oggi, per la grande inaspettata fortuna che gli acquirenti si sono fatti da parte, è urgente che i nuovi amministratori Comunali Provinciali e Regionali mettano mano a un nuovo progetto pubblico sull’Antico Ospedale di Cortona. Non c’è dubbio che si tratta d’un impegno con la “I” maiuscola per dimensioni e prestigio dell’immobile. Com’è altrettanto certo che il momento sia quello giusto per sviluppare un serio progetto di recupero e destinazione dell’immobile. Patrimonio storico, affettivo, di inestimabile valore per Cortona, dal passato centenario, tuttavia indispensabile per il futuro quale elemento di sviluppo centrale nel cuore della Città. Per quanto la mia opzione su di esso sia l’uso pubblico, e nella sua interezza, potrebbero essere valutate anche proposte di privati, purché siano di comprovata capacità economica e realizzativa, e il progetto soddisfi interessi pubblici. Assolutamente da evitare il ripetersi dell’esperienza passata. Per cui l’antica struttura rischia seriamente di aver subito danni strutturali elevati, a partire dalla mancata manutenzione dei tetti in non perfetto stato.
Svenduto in fretta e furia dalla precedente Amministrazione Provinciale, quando denunciammo il fatto ci fu persino una reazione risentita del Presidente, oggi, per la grande inaspettata fortuna che gli acquirenti si sono fatti da parte, è urgente che i nuovi amministratori Comunali Provinciali e Regionali mettano mano a un nuovo progetto pubblico sull’Antico Ospedale di Cortona. Non c’è dubbio che si tratta d’un impegno con la “I” maiuscola per dimensioni e prestigio dell’immobile. Com’è altrettanto certo che il momento sia quello giusto per sviluppare un serio progetto di recupero e destinazione dell’immobile. Patrimonio storico, affettivo, di inestimabile valore per Cortona, dal passato centenario, tuttavia indispensabile per il futuro quale elemento di sviluppo centrale nel cuore della Città. Per quanto la mia opzione su di esso sia l’uso pubblico, e nella sua interezza, potrebbero essere valutate anche proposte di privati, purché siano di comprovata capacità economica e realizzativa, e il progetto soddisfi interessi pubblici. Assolutamente da evitare il ripetersi dell’esperienza passata. Per cui l’antica struttura rischia seriamente di aver subito danni strutturali elevati, a partire dalla mancata manutenzione dei tetti in non perfetto stato.
Perché ritengo il momento giusto?
Come insegna la storia, da crisi drammatiche, come quella che stiamo vivendo causata dalla pandemia, se n’esce con massicci investimenti pubblici, non solo di tipo “assistenziale” a sostegno delle attività economiche e del reddito dei cittadini, bensì con opere strutturali che potenzino il sostrato economico accelerando audacemente la modernizzazione d’un paese in ginocchio. Infatti, per ora a parole, sentiamo sciorinare somme astronomiche, da parte del Governo Italiano e dalla Comunità Europea, ma se, fortuna volesse, dalle parole si passasse ai fatti, nessun dorma tra i politici, che nei fatti, volessero dimostrare capacità di risollevare l’economia! A partire dal più modesto Comune alle Province e alle Regioni. Ognuno nelle sue competenze, meglio se coordinate tra loro, deve sviluppare una progettualità coraggiosa. E questo è quanto è necessario, al nostro livello, al fine di trasformare una volta per tutte il “problema” Antico Ospedale in risorsa, quale esso effettivamente appare a qualsiasi occhio obiettivo. Non cieco, o politico di basso profilo, come quello di pochi anni fa. All’epoca, sulla infelice decisione della Provincia, ricordo l’imbarazzato silenzio della sinistra locale, non so quanto complice o quanto presa alla sprovvista, mentre l’atteggiamento della destra, anch’esso silente, pareva quello di chi godesse a veder cuocere gli altri nel loro brodo. Bene. Ora che i giochi si sono riaperti aspettiamo fiduciosi una progettualità degna di tal nome sul futuro di questo patrimonio pubblico, il più prezioso della Città, alla quale, fortunosamente, è tornato nella piena disponibilità. Basta ripetere errori e disattenzioni passate!
E qualsiasi decisione verrà presa sia frutto del pieno coinvolgimento dei cittadini, ai quali la politica dovrebbe rispetto, se non altro per ché l’Antico Ospedale sorse con il lavoro e i soldi dell’intera collettività. All’epoca non esistevano finanziarie immobiliari o Cassa Depositi e Prestiti.
fabilli1952@gmail.com
Paolo Civitelli architettò una scuola aerostatica
 Leggendo sul Corriere Innovazione l’anteprima del Padiglione Italia: “Barche sopra Dubai”, all’Esposizione Universale (rinviata a ottobre 2021), che prevedrà tre grandi barche rovesciate, sospese in aria, ciascuna d’un colore del tricolore, ho ripensato all’architetto cortonese Paolo Civitelli, la cui tesi di Laurea fu il Progetto di scuola aerea, tipo mongolfiera. L’avveniristico Padiglione Italia, sintesi delle più avanzate tecnologie costruttive con materiali biologici e di riciclo, energia prodotta in modo naturale da alghe che fungeranno da climatizzatore e cibo, connessioni elettroniche a distanza con università e centri di ricerca, e, invece delle fondamenta in cemento, sarà fissata su strutture colleganti a terra su sabbia pressata, raccolta in loco…tanto avveniristico e spettacolare che gli Emirati Arabi hanno chiesto il mantenimento in loco del Padiglione per sei anni. Perciò ho provato dispiacere a non aver chiesto dettagli, allora, a Paolo sul suo progetto approvato dai professori, elevato a Tesi di Laurea. Paolo non si dava tanta boria. Gravemente depresso, ai buschi cambi meteo, si presentava nell’ufficio di sindaco chiedendomi il permesso di sostare seduto, giusto il tempo di scorrere in silenzio i titoli del fascio di giornali che portava sottobraccio. Ovvio, glielo consentivo. Instaurando, tra noi, dialoghi spezzati dai ritmi forsennati imposti da telefonate, e impiegati che andavano e venivano per firme o porre questioni urgenti. Paolo si scherniva dei nostri incontri, a ritmi meteo: ciclicità di cui, presumo, non fosse consapevole. Consideravo l’ospitalità dovere solidale verso persone tormentate dalla depressione, e verso i loro familiari oppressi da pesi altrettanto scioccanti. Com’era il caso di Bruna. Anch’essa, assidua, si presentava gli stessi giorni delle brusche variazioni meteo a prospettare traversie d’un figlio, ex ricoverato in manicomio, che, a suo avviso, non fosse ben seguito dai servizi territoriali di Igiene mentale, sostitutivi del manicomio. Ella, insoddisfatta e angosciata. Quegli incontri vertevano su presunte inefficienze e ritardi nell’ applicazione della Legge 180/1978 – la Basaglia -, sulle chiusure dei manicomi. In effetti, scontavo inesperienze non tanto sulle malattie, essendo Infermiere, quanto sulle cure prestate presso i Servizi territoriali d’Igiene Mentale, sui cui presto mi aggiornai anche per reggere le prevedibili obiezioni di Bruna. D’altronde, i Servizi territoriali furono costretti ad adeguarsi a nuovi scenari in breve tempo, dal 1978 in poi, chiusi i manicomi si passò alla presa in carico degli ex ricoverati sui Territori. Processo complicato pure dall’ampio spettro di sindromi, per età sesso e condizioni sociali dei “malati” da assistere, presso famiglie o case famiglia. Ricordo, a proposito, il caso d’una psicoterapeuta colta durante il lavoro da grave choc, tanto da interrogarsi, lei stessa, sulla propria adeguatezza a sopportare il carico di stress alle prese coi pazienti. A rivoluzione in atto – i malati non più rinchiusi – in primo luogo i sanitari ma anche le istituzioni pubbliche dovettero prodigarsi per soccorrere “malati” e parenti. Parenti, a volte, “disturbati” quasi quanto i loro cari. Inutile nascondere complessità e durezze di quei drammi. Infatti, com’era accettabile che giovani come Paolo capaci di portare a termine studi fino alla Laurea, con Progetti che definiremmo avveniristici, fossero colpiti da incapacità di adattamento tanto gravi? Prima di lui, avevo conosciuta la vicenda di Tullio. Altro giovane culturalmente dotato, fino a giungere alla Laurea in Ingegneria elettronica, le cui nebbie mentali invece di regredire si aggravarono al punto da pregiudicargli l’insegnamento della sua materia, l’elettronica, della quale era brillante cultore.
Leggendo sul Corriere Innovazione l’anteprima del Padiglione Italia: “Barche sopra Dubai”, all’Esposizione Universale (rinviata a ottobre 2021), che prevedrà tre grandi barche rovesciate, sospese in aria, ciascuna d’un colore del tricolore, ho ripensato all’architetto cortonese Paolo Civitelli, la cui tesi di Laurea fu il Progetto di scuola aerea, tipo mongolfiera. L’avveniristico Padiglione Italia, sintesi delle più avanzate tecnologie costruttive con materiali biologici e di riciclo, energia prodotta in modo naturale da alghe che fungeranno da climatizzatore e cibo, connessioni elettroniche a distanza con università e centri di ricerca, e, invece delle fondamenta in cemento, sarà fissata su strutture colleganti a terra su sabbia pressata, raccolta in loco…tanto avveniristico e spettacolare che gli Emirati Arabi hanno chiesto il mantenimento in loco del Padiglione per sei anni. Perciò ho provato dispiacere a non aver chiesto dettagli, allora, a Paolo sul suo progetto approvato dai professori, elevato a Tesi di Laurea. Paolo non si dava tanta boria. Gravemente depresso, ai buschi cambi meteo, si presentava nell’ufficio di sindaco chiedendomi il permesso di sostare seduto, giusto il tempo di scorrere in silenzio i titoli del fascio di giornali che portava sottobraccio. Ovvio, glielo consentivo. Instaurando, tra noi, dialoghi spezzati dai ritmi forsennati imposti da telefonate, e impiegati che andavano e venivano per firme o porre questioni urgenti. Paolo si scherniva dei nostri incontri, a ritmi meteo: ciclicità di cui, presumo, non fosse consapevole. Consideravo l’ospitalità dovere solidale verso persone tormentate dalla depressione, e verso i loro familiari oppressi da pesi altrettanto scioccanti. Com’era il caso di Bruna. Anch’essa, assidua, si presentava gli stessi giorni delle brusche variazioni meteo a prospettare traversie d’un figlio, ex ricoverato in manicomio, che, a suo avviso, non fosse ben seguito dai servizi territoriali di Igiene mentale, sostitutivi del manicomio. Ella, insoddisfatta e angosciata. Quegli incontri vertevano su presunte inefficienze e ritardi nell’ applicazione della Legge 180/1978 – la Basaglia -, sulle chiusure dei manicomi. In effetti, scontavo inesperienze non tanto sulle malattie, essendo Infermiere, quanto sulle cure prestate presso i Servizi territoriali d’Igiene Mentale, sui cui presto mi aggiornai anche per reggere le prevedibili obiezioni di Bruna. D’altronde, i Servizi territoriali furono costretti ad adeguarsi a nuovi scenari in breve tempo, dal 1978 in poi, chiusi i manicomi si passò alla presa in carico degli ex ricoverati sui Territori. Processo complicato pure dall’ampio spettro di sindromi, per età sesso e condizioni sociali dei “malati” da assistere, presso famiglie o case famiglia. Ricordo, a proposito, il caso d’una psicoterapeuta colta durante il lavoro da grave choc, tanto da interrogarsi, lei stessa, sulla propria adeguatezza a sopportare il carico di stress alle prese coi pazienti. A rivoluzione in atto – i malati non più rinchiusi – in primo luogo i sanitari ma anche le istituzioni pubbliche dovettero prodigarsi per soccorrere “malati” e parenti. Parenti, a volte, “disturbati” quasi quanto i loro cari. Inutile nascondere complessità e durezze di quei drammi. Infatti, com’era accettabile che giovani come Paolo capaci di portare a termine studi fino alla Laurea, con Progetti che definiremmo avveniristici, fossero colpiti da incapacità di adattamento tanto gravi? Prima di lui, avevo conosciuta la vicenda di Tullio. Altro giovane culturalmente dotato, fino a giungere alla Laurea in Ingegneria elettronica, le cui nebbie mentali invece di regredire si aggravarono al punto da pregiudicargli l’insegnamento della sua materia, l’elettronica, della quale era brillante cultore.
Paolo, pur protetto da affetto materno, scomparve precocemente. Lo stesso accadde a Tullio. Forse anche a causa di terapie che se, da un lato, alleviavano certi sintomi, dall’altro, pareva la cura stessa esser causa di dipendenze da farmaci e disfunzioni metaboliche gravi. Spero, nel frattempo, che sui farmaci siano stati fatti progressi, tant’era l’alienazione che pareva inducessero. Così come confido in passi avanti sulle pratiche assistenziali, agli inizi, non di rado, approssimative se non paternalistiche.
La casistica sulle malattie mentali è in continua evoluzione: dalle “schizofrenie” agli abusi di sostanze psicotrope, a fattori genetici e ambientali, Parkinson, Alzheimer, demenze senili, autismi, e, addirittura, sempre più frequenti “raptus” omicidi,… insomma una gran massa di disturbi comportamentali, descritti anche nel libro: “Malaria Urbana” (patologie della civiltà urbana) di Giovanni Berlinguer.
Le famiglie non devono esser lasciate sole. Solo pensando alla vicenda di Paolo che la malattia portò a morte precoce. A breve, seguito dalla madre. Pur non mancando l’affetto reciproco tra madre e figlio. Forse, i due, affondarono lentamente sommersi nelle sabbie mobili dei disagi mentali. Ma società e istituzioni fecero abbastanza in loro soccorso? L’interrogativo è d’obbligo. Se penso alla condotta d’una parte della collettività locale: quella di sfottere Paolo, crudelmente! Destino analogo capitò Tullio: insegnante in Valdarno, gli studenti, senza tregua, lo coprirono di dispetti e scherno. Pur non essendo psichiatra, sono certo che per i sofferenti di deficit mentali siano importanti le coccole, quando non esclusivo farmaco di certe malattie.
La “cattiveria”, di cui si dice siano capaci i bambini, tra loro, col più debole, negli adulti è inaccettabile, senza mezzi termini da definire: vigliaccheria vergognosa!
Spero di non essere facile profeta, ma così come abbiamo assistito persino a suicidi per depressione post crisi economica, prepariamoci ad assistere a fenomeni simili post corona virus. In tal caso, saremmo pronti, come individui e istituzioni, a offrire ai bisognosi una mano? Più cure e attenzioni, al prossimo in difficoltà, di quanto è accaduto nel recente passato?
fabilli1952@gmail.com
Enzo Barneschi, impegnato nella cura del patrimonio comunale e dei legami sociali
 Se c’era da dare una palettata di cemento – al lavoro in Comune o per un amico in difficoltà o per attività ricreative – Enzo era sempre disponibile. Palettata di cemento, sinonimo della sua versatilità nell’affrontare i più svariati lavori manutentori di cui s’era impratichito beneficiandone il Comune, datore di lavoro viepiù a corto di operai specializzati. Così com’era depositario della mappa virtuale, dell’esteso patrimonio comunale, costruita nella sua mente in tanti anni. Efficienza e dedizione al lavoro che forse gli sono stati fatali. Pur non disponendo notizie precise sulle cause del suo male inesorabile, credo di non essere lontano dal vero ipotizzando che si sia infortunato un piede lavorando trascurandone il trauma, e che, sottovalutato, abbia avuto un decorso infausto. Da “combattente” che privilegia mantenere salda la postazione alla propria incolumità. Come tutti, dal carattere con spigolature ma affettuoso! Da ultimo, i nostri rapporti erano virtuali, lo vedevo seguire su Facebook le mie strampalate vacanze in giro pel mondo. Ancora, il 26 marzo, annotava sul mio articolo dedicato a Bruno Benigni, uomo politico impegnato fino alla fine dei suoi giorni a favore degli ultimi, i ricoverati nei manicomi e nei manicomi criminali, avendo contribuito alla loro chiusura. Enzo scriveva: “Bravo Ferruccio, anche io ho conosciuto Benigni, hai dato il giusto valore che meritava, senza aggiungere meriti di più del suo grande lavoro, e con tanta umiltà”. Sapevo il suo ingravescente stato di salute, ma Enzo era ancora quell’uomo sociale con cui avevo condiviso tanti anni di impegno politico nel PCI. Famiglia politica dispersa in molti rivoli, ma che, nei più sensibili, ha conservato l’dea prioritaria della cura del bene comune. Anche in questo impegno Enzo è stato infaticabile, dimostrando quanto la dedizione al lavoro di dipendente comunale fosse coerente con la sua passione sociale. Mi aveva mostrato, molto soddisfatto, la bella casa di famiglia costruita, in senso letterale, con le sue mani. Parlandomi affettuoso della sua giovane famiglia in crescita, senza trascurare l’ammirazione per il babbo, già anziano ma sempre operoso. Come il suocero Quinto, lavoratore infaticabile, rappresentante di quella limpida coscienza civica della generazione che, con sacrifici e sudore, trasse fuori l’Italia dalla miseria post bellica, fino al benessere e ai diritti di cui la nostra generazione ha goduto. Come ultimo saluto gli ho dedicato un articolo sulla fantastica colonna sonora che sale dalla Val di Loreto in questi giorni di silenzi irreali: canti di uccellini, latrati canini, muggiti bovini, ragli d’asini, rari scampanii, … che l’hanno accompagnato all’ultima dimora, uniti al pensiero mesto di tanti che l’hanno conosciuto e apprezzato lavoratore inappuntabile, generoso e, senza retorica, dedito come pochi alla tutela dei legami sociali e del patrimonio della collettività.
Se c’era da dare una palettata di cemento – al lavoro in Comune o per un amico in difficoltà o per attività ricreative – Enzo era sempre disponibile. Palettata di cemento, sinonimo della sua versatilità nell’affrontare i più svariati lavori manutentori di cui s’era impratichito beneficiandone il Comune, datore di lavoro viepiù a corto di operai specializzati. Così com’era depositario della mappa virtuale, dell’esteso patrimonio comunale, costruita nella sua mente in tanti anni. Efficienza e dedizione al lavoro che forse gli sono stati fatali. Pur non disponendo notizie precise sulle cause del suo male inesorabile, credo di non essere lontano dal vero ipotizzando che si sia infortunato un piede lavorando trascurandone il trauma, e che, sottovalutato, abbia avuto un decorso infausto. Da “combattente” che privilegia mantenere salda la postazione alla propria incolumità. Come tutti, dal carattere con spigolature ma affettuoso! Da ultimo, i nostri rapporti erano virtuali, lo vedevo seguire su Facebook le mie strampalate vacanze in giro pel mondo. Ancora, il 26 marzo, annotava sul mio articolo dedicato a Bruno Benigni, uomo politico impegnato fino alla fine dei suoi giorni a favore degli ultimi, i ricoverati nei manicomi e nei manicomi criminali, avendo contribuito alla loro chiusura. Enzo scriveva: “Bravo Ferruccio, anche io ho conosciuto Benigni, hai dato il giusto valore che meritava, senza aggiungere meriti di più del suo grande lavoro, e con tanta umiltà”. Sapevo il suo ingravescente stato di salute, ma Enzo era ancora quell’uomo sociale con cui avevo condiviso tanti anni di impegno politico nel PCI. Famiglia politica dispersa in molti rivoli, ma che, nei più sensibili, ha conservato l’dea prioritaria della cura del bene comune. Anche in questo impegno Enzo è stato infaticabile, dimostrando quanto la dedizione al lavoro di dipendente comunale fosse coerente con la sua passione sociale. Mi aveva mostrato, molto soddisfatto, la bella casa di famiglia costruita, in senso letterale, con le sue mani. Parlandomi affettuoso della sua giovane famiglia in crescita, senza trascurare l’ammirazione per il babbo, già anziano ma sempre operoso. Come il suocero Quinto, lavoratore infaticabile, rappresentante di quella limpida coscienza civica della generazione che, con sacrifici e sudore, trasse fuori l’Italia dalla miseria post bellica, fino al benessere e ai diritti di cui la nostra generazione ha goduto. Come ultimo saluto gli ho dedicato un articolo sulla fantastica colonna sonora che sale dalla Val di Loreto in questi giorni di silenzi irreali: canti di uccellini, latrati canini, muggiti bovini, ragli d’asini, rari scampanii, … che l’hanno accompagnato all’ultima dimora, uniti al pensiero mesto di tanti che l’hanno conosciuto e apprezzato lavoratore inappuntabile, generoso e, senza retorica, dedito come pochi alla tutela dei legami sociali e del patrimonio della collettività.
Ferruccio Fabilli
A Paternopoli e nell’Irpinia Felix a primavera esplodono i ciliegi
 Raccolgo l’invito a riprendere i viaggi, appena sarà consentito, dall’Italia. Grazie alle offerte infinite nel nostro paese, scegliere una meta è arduo. Ho usato due canoni: uno sentimentale, in ricordo del devastante terremoto del 1980 che mise in contatto Cortona e Paternopoli (4 morti, 18 feriti, 406 senzatetto); l’altro infantile, dell’età in cui nulla era più goloso dell’assalto ai ciliegi – propri e dei vicini – dei quali l’Irpinia è coronata. A quarant’anni dal terremoto. Per quei luoghi paragonabile al corona virus odierno, avendo subito disastri con morti e distruzioni. Di cui fummo testimoni diretti, grazie ai generosi cortonesi che, coi mezzi raccolti, vollero recar sollievo a persone nel panico. D’allora, poche amicizie sopravvivono. Vivida è con Pietro Palermo, primo paternese incontrato al centro raccolta di Grottaminarda, allora assessore comunale alla ricerca di soccorsi. Bontà la Misericordia di Cortona – di Silvio Santiccioli e Francesco Moré – che dopo il terremoto incoraggiò la nascita d’una consorella a Paternopoli, altri amici recenti si sono aggiunti, funzionando ancora quel gemellaggio, grazie ai Presidenti Luciano Bernardini e Giovanni Tecce. Mentre tra i due Comuni gemellati, dalla memoria corta, l’amicizia presto s’è spenta.
Raccolgo l’invito a riprendere i viaggi, appena sarà consentito, dall’Italia. Grazie alle offerte infinite nel nostro paese, scegliere una meta è arduo. Ho usato due canoni: uno sentimentale, in ricordo del devastante terremoto del 1980 che mise in contatto Cortona e Paternopoli (4 morti, 18 feriti, 406 senzatetto); l’altro infantile, dell’età in cui nulla era più goloso dell’assalto ai ciliegi – propri e dei vicini – dei quali l’Irpinia è coronata. A quarant’anni dal terremoto. Per quei luoghi paragonabile al corona virus odierno, avendo subito disastri con morti e distruzioni. Di cui fummo testimoni diretti, grazie ai generosi cortonesi che, coi mezzi raccolti, vollero recar sollievo a persone nel panico. D’allora, poche amicizie sopravvivono. Vivida è con Pietro Palermo, primo paternese incontrato al centro raccolta di Grottaminarda, allora assessore comunale alla ricerca di soccorsi. Bontà la Misericordia di Cortona – di Silvio Santiccioli e Francesco Moré – che dopo il terremoto incoraggiò la nascita d’una consorella a Paternopoli, altri amici recenti si sono aggiunti, funzionando ancora quel gemellaggio, grazie ai Presidenti Luciano Bernardini e Giovanni Tecce. Mentre tra i due Comuni gemellati, dalla memoria corta, l’amicizia presto s’è spenta.
Di recente, con Claudio Basco – che laggiù trovò moglie, Michelina, a una festa gemellare delle Misericordie – abbiamo organizzato un viaggio. Foriero di tante sorprese. L’Irpinia mantiene il problema dell’emigrazione giovanile, ma molti aspetti sono evoluti in meglio. La primavera ci avvolse colorata nel rosso verde dei ciliegi carichi di frutti turgidi, complice il satellitare indicandoci percorsi più brevi infilammo stradine, per valli e colline, nel paesaggio agrario florido per coltivazioni intensive tra vigne e oliveti, fino a Paternopoli.
Da un acrocoro nel comune di Castelfranci, sistemati in agriturismo, lo sguardo poté spaziare sul paesaggio Irpino, fantastico! Che mai prima avevo apprezzato nella sua vastità. Ondulato, coronato da vette montane, vi si nascondono tesori tra pliche verdeggianti: cittadine, chiese, musei e dimore storiche, riserve naturali, luoghi sacri, oliveti, cantine e vigne, prodotti agroalimentari naturali o abilmente trasformati.
Tra bevitori, chi non conosce i vini Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo? Vengono da lì. La cantina Mastroberardino di Atripalda, la migliore negli anni del terremoto, ne faceva le sue bandiere. A essa si sono accodati produttori altrettanto validi. Da quei vini sono nate grappe omonime. A proposito del bere, la prima sera accampati nella Paternopoli terremotata, i cortonesi allestirono la cena da campo, ma la damigiana di aglianico scolata fino all’ultima goccia fu offerta in loco. Scoprimmo così a garganella il grande aglianico (vitigno preromanico, da “hellenico” d’origini greche) che, seguendo un disciplinare, diventa DOCG Taurasi. Prodotto entro i comuni di Paternopoli, Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre Le Nocelle, Venticano, in provincia di Avellino. Alcuni di questi luoghi resi familiari dalla TV dopo il terremoto – porzioni minori dell’Irpinia estesa in tre provincie: Avellino, Benevento, Foggia – sarebbero sufficienti ad appagare molte curiosità nel nostro viaggio ideale. Anche scorrendo solo una lista sommaria dei loro prodotti, molti dei quali DOP: broccoli di Paternopoli, nocciole, cipolle ramate, capicolli e salami, torroni, pane, pecorino, castagne, aglio bianco, tartufo, caciocavallo, ciliegie, …, offerti anche nelle locali trattorie, pizzerie, e ristoranti.
Una guida dice: “Visitate i piccoli borghi avellinesi e potrete dire di avere visto alcuni dei luoghi più belli del mondo. L’Irpinia è costellata di piccoli borghi medioevali arroccati sui monti dove il tempo pare si sia fermato”, sciorinando siti rilevanti: il castello Normanno e la Cattedrale romanica di Ariano Irpino; a Mirabella Eclano gli scavi dell’antica città Aeclanum, tra i principali centri della tribù sannita degli irpini; Gesualdo coi suoi vicoli e il Castello che lo domina; l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi; Montella dal paesaggio bellissimo e il santuario di San Salvatore che domina un monte del tutto deserto; e, sempre tra i borghi più belli d’Italia, Rocca San Felice, e Monteverde, dal Castello dedicato al brigantaggio (dove il sottoscritto vinse un premio letterario, ed essendo circondato da pale eoliche, mi parve d’essere il modesto emulo di Don Chisciotte in cerca di ventura).
Per gli appassionati di trekking c’è l’imbarazzo della scelta. A partire dal sentiero E1 (unisce la Norvegia a Capo Passero, in Sicilia) che traversa il Parco Partenio. Il quale, a sua volta, offre una vasta scelta di sentieri circostanti. Di Mamma Schiavona: da Ospedaletto a Montevergine; tra le cime di Montevergine; via dei Cristiani: da Baiano a Summonte; la Bocca dell’Acqua; tra i due Campi: da Mercogliano a Montevergine; tra due vette: da Summonte a Montevergine; panoramico: da Monteforte Irpino a Campo san Giovanni; valle dell’Inferno; lungo la Trave del Fuoco, … alcuni esempi – tra i numerosi suggeriti al camminatore dal Parco Partenio – di angoli suggestivi, panoramici, naturalistici, storici, soddisfacendo tutti i gusti.
Senza tralasciare le feste folkloristiche disseminate in vari centri e periodi dell’anno. Iniziative recenti o consolidate tradizioni. Feste che legano gli addobbi barocchi delle classiche luminarie su strade ed edifici cittadini, ai fuochi d’artificio, spettacoli, balli, gastronomia. Sud tradizionalista ma non avaro, tutt’altro, dove per la gioia di vivere e ostentare benessere, in certe circostanze come nei matrimoni, si è disposti a spendere patrimoni per aggregare alla festa amici, parenti, e persino comunità intere.
Perciò, partendo da Paternopoli, troveremo amici desiderosi di suggerire il meglio per la nostra vacanza Irpina che può durare dal fine settimana a tutto il tempo disponibile.
fabilli1952@gmail.com
 Gemellaggio MISERICORDIE (Moré e Santiccioli, per Cortona)
Gemellaggio MISERICORDIE (Moré e Santiccioli, per Cortona)
 Amministratori comunali Paternopoli ai tempi del TERREMOTO (1980)
Amministratori comunali Paternopoli ai tempi del TERREMOTO (1980)
 CILIEGIE, corallo rosso dell’ IRPINIA
CILIEGIE, corallo rosso dell’ IRPINIA
La fantastica colonna sonora che sale dai cascinali della Val di Loreto
 Decenni fa, in Valdichiana, era naturale che risuonassero voci umane confuse con varie espressioni animali di uccelli, cani, galli, maiali, bovi, pecore, asini … segni d’una agricoltura tradizionale ancor viva, insieme alle invadenze olfattive tipo la puzza di porcili e pollerie. Sinfonie naso uditive lentamente spentesi, cancellando così la diversità tra il vivere in città o in campagna; sempre gli stessi rumori: traffico, treni, ambulanze, e motociclisti rombanti nella buona stagione. Da casa, in collina, tale metamorfosi è percettibile – par d’essere a teatro per quanto giungono chiari i suoni dal basso –, se non che, ai piedi dell’altura, dalla casa colonica degli eredi di Gino e Piero Conti partono ogni tanto scoppiettanti avvisi di presenze bovine, e degli asinelli di Corrado e dei Milani, prodi allevatori. (Per fortuna, è chiuso il vicino porcile che, soffiando vento senese, ammorbava l’aria). Gino ci ha lasciato anzitempo, ma gli eredi mantengono la fattoria canterina di animali a ricordo che un tempo loro, nelle stalle e nei cortili, erano più numerosi degli umani. Ragliando e muggendo avvertono d’aver fame, o, forse, di soffrire solitudine e clausura. Il loro controcanto naturale, opposto ai rumori tecnologici dilaganti, è godibile compagnia. Dalla fattoria, nei pomeriggi festivi, partiva Piero per l’aeroporto a guidare un piccolo aereo per volteggiare sulla Val di Loreto, e, per quanto tecnologico, quel sorvolo rimarcava la festa, il bel tempo (col brutto non volava), e l’amicizia per i concittadini. Motivi di salute hanno distolto Piero dal volo, e le giornate risultano meno spensierate senza quei volteggi. Come se un passero stagionale rinunciasse al suo ritorno.
Decenni fa, in Valdichiana, era naturale che risuonassero voci umane confuse con varie espressioni animali di uccelli, cani, galli, maiali, bovi, pecore, asini … segni d’una agricoltura tradizionale ancor viva, insieme alle invadenze olfattive tipo la puzza di porcili e pollerie. Sinfonie naso uditive lentamente spentesi, cancellando così la diversità tra il vivere in città o in campagna; sempre gli stessi rumori: traffico, treni, ambulanze, e motociclisti rombanti nella buona stagione. Da casa, in collina, tale metamorfosi è percettibile – par d’essere a teatro per quanto giungono chiari i suoni dal basso –, se non che, ai piedi dell’altura, dalla casa colonica degli eredi di Gino e Piero Conti partono ogni tanto scoppiettanti avvisi di presenze bovine, e degli asinelli di Corrado e dei Milani, prodi allevatori. (Per fortuna, è chiuso il vicino porcile che, soffiando vento senese, ammorbava l’aria). Gino ci ha lasciato anzitempo, ma gli eredi mantengono la fattoria canterina di animali a ricordo che un tempo loro, nelle stalle e nei cortili, erano più numerosi degli umani. Ragliando e muggendo avvertono d’aver fame, o, forse, di soffrire solitudine e clausura. Il loro controcanto naturale, opposto ai rumori tecnologici dilaganti, è godibile compagnia. Dalla fattoria, nei pomeriggi festivi, partiva Piero per l’aeroporto a guidare un piccolo aereo per volteggiare sulla Val di Loreto, e, per quanto tecnologico, quel sorvolo rimarcava la festa, il bel tempo (col brutto non volava), e l’amicizia per i concittadini. Motivi di salute hanno distolto Piero dal volo, e le giornate risultano meno spensierate senza quei volteggi. Come se un passero stagionale rinunciasse al suo ritorno.
Un lontano legame incrociò le nostre vicende familiari. Nel podere a Casa Bianca di Piazzano, lasciato dalla mia famiglia mezzadrile diretta al podere di Caldarino, vi subentrò la famiglia Conti, retta da mamma Rosa. Mezzadri nelle stesse proprietà Catani di Montalla. Con Gino, per un trentennio, siamo stati vicini di casa e amici. Con Piero ci fu l’incontro d’una sera alla Polisportiva di Tavarnelle, dove, generoso, appena conosciuti si offrì di portarmi con l’aereo in vacanza all’Elba. L’evento non si verificò per i mutevoli casi della vita, non per volontà di Piero. Gino era assai attivo nella vita sociale. Piacente, pare fosse uno sciupa femmine, passava elegantemente dalla cura del podere e degli animali a serate galanti, allegro e vitale.
Nell’irreale silenzio indotto dal coronavirus, rotto dalle sirene spiegate delle ambulanze, fortunatamente, è ancor vivo l’allegro coro animale che rompe il silenzio senza precise cadenze, mentre i rintocchi delle campane han cadenze più prevedibili. E le sere delle vigilie festive non echeggiano più all’altoparlante i richiami di don Ferruccio, i quali, anche se inosservati dal sottoscritto, erano benauguranti a riprova del dimani al dì di festa… sperando che tornino feste vere.
fabilli1952@gmail.com
Giuseppe Berni l’agricoltore che pregava gli ulivi
 Nella solitudine agreste, accentuata dal silenzio da coronavirus, potazzavo ulivi felice, in compagnia del mastro potatore scomparso, il saggio Beppe. Vicinanza speciale, di quelle che ci seguono in intime vibrazioni. Ondate di ricordi che il filosofo Emanuele Severino attribuiva agli “eterni”; avendo ciascuno i suoi “eterni”: persone care defunte. Da certi luoghi e situazioni riaffiorano. In questo angolo del Borgo, lo spirito di Beppe staziona ancora, avendovi trascorso una lunga vita a “pettinare” ulivi tanto bene da sottoporli al giudizio del prof. Lanari; fattore nella zona tra Montecchio e Manzano e docente di Agronomia alle Capezzine. Beppe non aveva fatto scuole tecniche, ma quella dei campi diretta dal babbo e da zio Romolo, avendo lui smesso gli studi alla quinta elementare. Per la regola contadina: “Se il giogo del lavoro dei campi non ti vien messo da piccolo, da grande non è più possibile”. L’assenza fisica di Beppe, però, è palpabile, deturpante quanto mancasse un dente anteriore al sorriso dei luoghi. Ne soffrono gli olivi, lentamente stingendo il verde turgido di salute e gioia trasmessa dalle sue cure maniacali. Ne soffrono le strade vicinali di Borro del Castelluccio e delle Scuole, dove, solo, stendeva il breccino riparando buche e riattando sciacqui; ora tutto va in rovina. Ne soffrono la perdita gli amici – come m’onoravo essergli -, avendo trasmesso a piene mani tanto buon umore e insegnamenti nella tenuta dei campi. Non indossando mai il cappello gallonato da maestro, pur essendolo. “Quando incontro una persona la saluto, anche se non la conosco! So quanto bene gli trasmetto”, gentilezze usate fin da ragazzo. Nelle conversazioni, sempre allegre, era capace, anche dopo i settant’anni, di capitombolare a terra per mimare le scene d’un racconto. E ci sarà di nuovo qui uno, come lui, capace di certe descrizioni della natura? “Avverto dei cambiamenti, come quello degli uccelli che non emigrano più! Quando ero ragazzo arrivavano tordi, quaglie; oggi non ci sono più! Sono comparsi gli storni, da almeno sette o otto anni, addirittura covano qui, non emigrano più. Dei pettirossi che in passato erano presenti, oggi non c’è quasi traccia… Le capinere erano fitte nelle lastre dei tetti, oggi quasi niente! Il mio tetto era pieno di rondoni – n’ero innamorato! – oggi chiudiamo le buche del muro, essendo quasi scomparsi. Spariti non perché la gente se li è mangiati, ma ne arrivano sempre meno. Avevo 17 buche sulla casa per i rondoni, molto utili per mangiare insetti, mosche e moscerini. Con il bestiame gli insetti erano tantissimi e i rondoni volteggiando, senza toccare terra, svolgevano un lavoro utilissimo nella pulizia dell’aria […]. Hanno una grande bocca come quella del cuculo, anch’egli insettivoro, come la spiatascia. Il rondone ha gambe piccole, le unghie, come per la civetta, sono la sua difesa. Non sta a terra anche perché non può difendersi con il becco, somigliando a un pulcino. Vivendo di moscerini, ha una vita aerea e depone le uova in alto sui tetti. Resta qui novanta giorni. Viene, fa l’amore, nascono i piccoli e poi, dal dieci al venti luglio riparte. Quelli che non partono muoiono, non facendo in tempo a salvarsi al caldo. […] Al posto dei rondoni sono arrivati gli storni, ai quali ho sparato, sono andato a distruggerne i nidi, cercando in tutte le manieri di ucciderli, ma loro restano. Siamo invasi da storni! Divorano tutto: grano, granoturco, ciliegie, uva. La loro carne è sgradevole. Arrivano animali nocivi e non tornano più quelli buoni, c’è uno sconvolgimento anche nel mondo degli uccelli. In cinquant’anni ho visto cambiamenti enormi!” Pensieri, vicende personali e familiari che raccolsi nel romanzo: Ascoltando il respiro di una notte d’estate, tra i miei preferiti. Dove l’ intrigante vita di Pio Colono (così l’avevo ribattezzato) rivela una visione positiva, fortemente legata agli affetti umani e persino agli adorati ulivi ai quali, emulo Francescano, dedicò la preghiera “Carissimo ulivo” “[…] Giovane sono maturato con la preghiera quotidiana: il Pater. Signore dacci oggi il nostro pane quotidiano… nonché – aggiungo – il grande alimento che mi sostiene nel corpo e nell’anima – piacendo al Creatore! – grazie all’olio! Quanto a te olivo, vengo a liberarti da quei rami che non fanno più frutto. Quei rami sono legna preziosa, che nell’inverno riscalda le mie membra e non patisco il freddo, quando sto al focolare, accanto a quel robusto fuoco, con la brace mi ci faccio una bella bruschetta, con il buon pane e il buonissimo olio, grazie olio!” Espressioni sincere d’una mente accorta nel denunciare la fine dell’arte contadina causata dalla Globalizzazione, annullatrice di tante culture tradizionali, come gli olivi secolari soppiantati da specie lavorate solo a macchina. Aveva capito tante cose, sul suo mondo in estinzione, prima che accadessero. Quella degli ulivi secolari è una causa pressoché persa. Basti guardare le nostre colline olivate per rendersi conto del progressivo abbandono a sé stesse delle piante argentee, tipiche di questo antico paesaggio, per motivi economici: non più redditizie; e motivi antropologici: gli anziani, che vi si dedicano senza calcoli di tornaconto, stanno scomparendo, e nuovi appassionati per gli ulivi sono sempre più rari. Dunque, non si tratta di nostalgie passatiste, di cui non sarebbe da vergognarsi, nati e cresciuti in mezzo alla natura come siamo stati… è un segno dei tempi. Se pure, sulle tradizioni alimentari contadine, sulla genuinità delle trasformazioni di materie prime (in salumi e conserve), sul modo di cucinare cibi, pare ci sia un’onda di riscoperte. Però è andata a perdersi l’affabulazione, la socievolezza, la cura delle cose proprie e dei beni comuni, come strade o sorgenti d’acqua fresca, di cui furono protagonisti quelli come Beppe. Che avevano quella dote sempre più rara – nell’epoca dei social e dei media -: di cui splendevano! La loro luce era visibile come aura speciale che li circondava, e capaci di trasmetterci quello splendore: amore assoluto per la vita e la natura.
Nella solitudine agreste, accentuata dal silenzio da coronavirus, potazzavo ulivi felice, in compagnia del mastro potatore scomparso, il saggio Beppe. Vicinanza speciale, di quelle che ci seguono in intime vibrazioni. Ondate di ricordi che il filosofo Emanuele Severino attribuiva agli “eterni”; avendo ciascuno i suoi “eterni”: persone care defunte. Da certi luoghi e situazioni riaffiorano. In questo angolo del Borgo, lo spirito di Beppe staziona ancora, avendovi trascorso una lunga vita a “pettinare” ulivi tanto bene da sottoporli al giudizio del prof. Lanari; fattore nella zona tra Montecchio e Manzano e docente di Agronomia alle Capezzine. Beppe non aveva fatto scuole tecniche, ma quella dei campi diretta dal babbo e da zio Romolo, avendo lui smesso gli studi alla quinta elementare. Per la regola contadina: “Se il giogo del lavoro dei campi non ti vien messo da piccolo, da grande non è più possibile”. L’assenza fisica di Beppe, però, è palpabile, deturpante quanto mancasse un dente anteriore al sorriso dei luoghi. Ne soffrono gli olivi, lentamente stingendo il verde turgido di salute e gioia trasmessa dalle sue cure maniacali. Ne soffrono le strade vicinali di Borro del Castelluccio e delle Scuole, dove, solo, stendeva il breccino riparando buche e riattando sciacqui; ora tutto va in rovina. Ne soffrono la perdita gli amici – come m’onoravo essergli -, avendo trasmesso a piene mani tanto buon umore e insegnamenti nella tenuta dei campi. Non indossando mai il cappello gallonato da maestro, pur essendolo. “Quando incontro una persona la saluto, anche se non la conosco! So quanto bene gli trasmetto”, gentilezze usate fin da ragazzo. Nelle conversazioni, sempre allegre, era capace, anche dopo i settant’anni, di capitombolare a terra per mimare le scene d’un racconto. E ci sarà di nuovo qui uno, come lui, capace di certe descrizioni della natura? “Avverto dei cambiamenti, come quello degli uccelli che non emigrano più! Quando ero ragazzo arrivavano tordi, quaglie; oggi non ci sono più! Sono comparsi gli storni, da almeno sette o otto anni, addirittura covano qui, non emigrano più. Dei pettirossi che in passato erano presenti, oggi non c’è quasi traccia… Le capinere erano fitte nelle lastre dei tetti, oggi quasi niente! Il mio tetto era pieno di rondoni – n’ero innamorato! – oggi chiudiamo le buche del muro, essendo quasi scomparsi. Spariti non perché la gente se li è mangiati, ma ne arrivano sempre meno. Avevo 17 buche sulla casa per i rondoni, molto utili per mangiare insetti, mosche e moscerini. Con il bestiame gli insetti erano tantissimi e i rondoni volteggiando, senza toccare terra, svolgevano un lavoro utilissimo nella pulizia dell’aria […]. Hanno una grande bocca come quella del cuculo, anch’egli insettivoro, come la spiatascia. Il rondone ha gambe piccole, le unghie, come per la civetta, sono la sua difesa. Non sta a terra anche perché non può difendersi con il becco, somigliando a un pulcino. Vivendo di moscerini, ha una vita aerea e depone le uova in alto sui tetti. Resta qui novanta giorni. Viene, fa l’amore, nascono i piccoli e poi, dal dieci al venti luglio riparte. Quelli che non partono muoiono, non facendo in tempo a salvarsi al caldo. […] Al posto dei rondoni sono arrivati gli storni, ai quali ho sparato, sono andato a distruggerne i nidi, cercando in tutte le manieri di ucciderli, ma loro restano. Siamo invasi da storni! Divorano tutto: grano, granoturco, ciliegie, uva. La loro carne è sgradevole. Arrivano animali nocivi e non tornano più quelli buoni, c’è uno sconvolgimento anche nel mondo degli uccelli. In cinquant’anni ho visto cambiamenti enormi!” Pensieri, vicende personali e familiari che raccolsi nel romanzo: Ascoltando il respiro di una notte d’estate, tra i miei preferiti. Dove l’ intrigante vita di Pio Colono (così l’avevo ribattezzato) rivela una visione positiva, fortemente legata agli affetti umani e persino agli adorati ulivi ai quali, emulo Francescano, dedicò la preghiera “Carissimo ulivo” “[…] Giovane sono maturato con la preghiera quotidiana: il Pater. Signore dacci oggi il nostro pane quotidiano… nonché – aggiungo – il grande alimento che mi sostiene nel corpo e nell’anima – piacendo al Creatore! – grazie all’olio! Quanto a te olivo, vengo a liberarti da quei rami che non fanno più frutto. Quei rami sono legna preziosa, che nell’inverno riscalda le mie membra e non patisco il freddo, quando sto al focolare, accanto a quel robusto fuoco, con la brace mi ci faccio una bella bruschetta, con il buon pane e il buonissimo olio, grazie olio!” Espressioni sincere d’una mente accorta nel denunciare la fine dell’arte contadina causata dalla Globalizzazione, annullatrice di tante culture tradizionali, come gli olivi secolari soppiantati da specie lavorate solo a macchina. Aveva capito tante cose, sul suo mondo in estinzione, prima che accadessero. Quella degli ulivi secolari è una causa pressoché persa. Basti guardare le nostre colline olivate per rendersi conto del progressivo abbandono a sé stesse delle piante argentee, tipiche di questo antico paesaggio, per motivi economici: non più redditizie; e motivi antropologici: gli anziani, che vi si dedicano senza calcoli di tornaconto, stanno scomparendo, e nuovi appassionati per gli ulivi sono sempre più rari. Dunque, non si tratta di nostalgie passatiste, di cui non sarebbe da vergognarsi, nati e cresciuti in mezzo alla natura come siamo stati… è un segno dei tempi. Se pure, sulle tradizioni alimentari contadine, sulla genuinità delle trasformazioni di materie prime (in salumi e conserve), sul modo di cucinare cibi, pare ci sia un’onda di riscoperte. Però è andata a perdersi l’affabulazione, la socievolezza, la cura delle cose proprie e dei beni comuni, come strade o sorgenti d’acqua fresca, di cui furono protagonisti quelli come Beppe. Che avevano quella dote sempre più rara – nell’epoca dei social e dei media -: di cui splendevano! La loro luce era visibile come aura speciale che li circondava, e capaci di trasmetterci quello splendore: amore assoluto per la vita e la natura.
fabilli1952@gmail.com
Alfonso Leonetti-Lev Trotsky, Carteggio 1930-1937, prefazione di Giorgio Sacchetti
Prefazione di Giorgio Sacchetti
Nell’epocale interrogativo di Alfonso Leonetti, reiterato in età senile, risiede forse la percezione dell’imminenza dell’ultimo atto di un travagliato percorso. Il muro di Berlino non era ancora caduto, ma quel socialismo da caserma, burocratico e oppressivo non poteva durare, certo meritando quell’epilogo rovinoso senza rigenerazione. Eppure quell’Idea che l’uguaglianza e la libertà non dovessero mai essere disgiunte sembrava riemergere dai gorghi della Storia, come un fiume carsico, leggibile in filigrana perfino nelle riflessioni di un vecchio comunista dissidente, di un trotskista dalle “venature libertarie”.
Quasi un secolo fa nella Russia sovietica si consumava l’estromissione di Trotsky, massimo protagonista della rivoluzione, dagli organi dirigenti del partito. In Italia l’inizio della vera fortuna editoriale del suo pensiero risale all’anno 1963 quando, per la prima volta senza demonizzare, usciva un importante studio dello storico Giuliano Procacci dedicato alla Rivoluzione permanente. Sempre in quegli anni veniva fondata la Samonà Savelli, editrice di orientamento affine che pubblicava un’importante antologia di scritti del rivoluzionario russo e un saggio di Silverio Corvisieri su Trotsky e il comunismo italiano; nel 1983 ci sarebbe poi stata la creazione del Centro studi “Pietro Tresso” con sede iniziale a Foligno in Umbria. Riguardo invece le fortune politiche e i primi passi di questa corrente del comunismo internazionale nel nostro paese l’indicazione per gli studiosi è stata, da sempre, quella di far riferimento alla fornitissima biblioteca di un illustre “trotskista pentito”, Leonetti appunto, con il suo archivio ubiquo e disseminato, suddiviso tra Fondazione Feltrinelli a Milano, Istituto Gramsci a Roma e Biblioteca comunale a Cortona.
Questo pregevole corposo Carteggio che i lettori hanno tra le mani, curato da Valeria Checconi e Ferruccio Fabilli, costituisce un’indubbia fonte primaria e un tassello fondamentale non solo per la ricostruzione delle intricate vicende novecentesche del trotskismo italiano e internazionale, ma anche per quelle più ampie e generali del movimento comunista. E merita un posto di rilievo nella nutrita storiografia specialistica sull’argomento. D’altronde le cesure estreme della corrispondenza, 1930-1937, racchiudono snodi cruciali sullo scenario geopolitico globale, con l’Europa in fiamme e sull’orlo del baratro.
Molteplici gli aspetti e le considerazioni che emergono dalla compulsa di queste pagine. La prima, abbastanza scontata, è che essendo i due corrispondenti protagonisti ed esponenti di primo piano di quella peculiare storia (quella del comunismo s’intende) che così tanto ha marcato il secolo XX, le informazioni inedite e le novità che qui emergono abbiano una valenza comunque ragguardevole. Esse cioè aggiungono ulteriori necessari elementi di conoscenza partendo proprio dall’analisi minuta e profonda di carte fino ad oggi misconosciute. La seconda considerazione riguarda proprio la natura di questi particolari documenti ed il loro trattamento per le finalità euristiche. È appena il caso di ricordare che, nella fattispecie, ci si trova di fronte alla pubblicazione integrale di fonti soggettive di primo grado, pregiatissime. Siamo cioè alla base della piramide, ad una profondità alla quale non sempre è consentito l’accesso agli storici. Nell’ambito di una strutturazione gerarchica documentale si comprende bene la differenza fra queste carte e, invece, gli atti ufficiali. I secondi sono, con tutta evidenza, il risultato di uno spirito mobilitante che sta a monte, elaborati su materiali di istruttoria che non sempre è dato di conoscere; e sono finalizzati alla comunicazione esterna efficace ed alla rappresentazione ottimale di sé dell’organizzazione, frutto in genere di sintesi e dibattiti, confezionati per durare in eterno o quasi. Considerate implicitamente memoria labile dagli stessi estensori – strumento della comunicazione intersoggettiva che s’immagina (a torto) “riservata” o, in ogni caso, inaccessibile agli estranei – le carte e la corrispondenza in genere, proprio per la loro funzione propedeutica ancillare rispetto alla stesura dei documenti ufficiali ci aprono invece, in quanto espressione estemporanea “sincera”, una inedita dimensione intima, libera e meno condizionata dal contesto. Quest’ultimo genere di fonti, spesso connotate da specifiche peculiarità, ci permette quindi di entrare nella psicologia degli attori e nelle dinamiche di gruppo utilizzando perfino dispositivi e approcci metodologici mutuati da discipline non prettamente storiche. L’euristica, quale scienza della ricerca, assume qui anche un significato più propriamente tecnico, ossia relativo all’atto concreto di esperire la materia prima. Così si mette a disposizione di chi voglia il risultato eccezionale di un “lavoro sotterraneo” nel quale si sono esercitate “le arti del minatore” indispensabili per la confezione del manufatto storiografico.
La presente pubblicazione costituisce la prova provata di come i fondi epistolari rappresentino uno strumento indispensabile di conoscenza. E ci permettano visuali inedite utilizzando ad esempio il metodo della cosiddetta network analysis, ossia attraverso l’esplicitazione di una “rete”, sistema / disegno strutturato di connessioni fra diversi punti, e magari di una rappresentazione sinottica sotto forma di diagramma. Ciò al fine di analizzare le attività svolte dai vari soggetti chiamati in causa, eventualmente finalizzate alla realizzazione di un progetto, oppure anche di tipo informale.
La terza considerazione concerne invece il rapporto di conoscenza amicale e di frequentazione intercorso tra il curatore dell’opera, Fabilli, ed il protagonista Leonetti, che non solo sta alla base della presente meritoria iniziativa editoriale, ma che ci fa intravedere un interessante “nesso comunicativo” intergenerazionale che ormai è quasi diventato una prassi nella storiografia sul movimento operaio in questi ultimi decenni. Insomma gli storici e gli studiosi formatisi culturalmente negli anni cruciali Sessanta-Settanta hanno spesso rivolto il loro sguardo d’indagine verso un’altra generazione-contro rassomigliante almeno nell’esprit alla loro, quella dei nati al volgere dell’Ottocento; forse alla ricerca inconscia di una possibile pedagogia rivoluzionaria, oppure di mere risposte alle inquietudini politiche e sociali poste dalla modernità. L’ultima considerazione attiene i contenuti insiti nello stesso soggetto narrativo che, anche nella disamina di quest’opera, ci rimandano alla categoria politica, culturale e soprattutto etica, del “tradimento”. Con una dinamica in parte analoga a quella già in atto per le masse cattoliche nei confronti dell’autorità millenaria dell’istituzione Chiesa, si instaura un vincolo di tipo ideologico fideistico, mutuato dall’attesa messianica del “Sol dell’avvenire”, nei confronti dello Stato sovietico. Ed era proprio nel nome di quella nuova fede che il movimento di simpatia verso la Russia rivoluzionaria si era istituzionalizzato nei partiti comunisti. Si creava in tal modo (e qui vale ancora l’analogia di cui sopra) quell’armonia artificiosa tra movimento e istituzione utile soltanto al perpetuarsi dei rapporti di potere, alla preservazione del nucleo originario da ogni istanza di contestazione. In tal senso ogni dissidenza doveva o essere riassorbita, oppure eliminata senza esitazioni; quindi ogni presa di posizione controcorrente rivestiva i connotati di “tradimento”.
Collocati in genere nell’arcipelago della dissidenza di sinistra, gli epigoni italiani di Lev Davidovich Bronstejn hanno una storia, un filo rosso che si dipana, senza soluzione di continuità, dal 1930 – quando “i tre” (Tresso, Leonetti e Ravazzoli) venivano espulsi dal partito comunista – fino ai giorni nostri, passando per la Nuova Opposizione Italiana e la Quarta internazionale. È un percorso costellato di persecuzioni, dibattiti estenuanti, scissioni in piccoli gruppi. I presupposti di questo movimento sono sempre stati quelli di un recupero puntiglioso delle fondamentali battaglie condotte da Trotsky, dal periodo prerivoluzionario alla NEP, fino all’affermarsi dello stalinismo, teorizzando la “Rivoluzione permanente”, denunciando la degenerazione dell’URSS e i crimini di Stalin, per un diverso rapporto partito-masse.
Il 17 febbraio 1962 “L’Unità” registrava una delle più cocenti sconfitte di questo movimento: Alfonso Leonetti, uno dei suoi massimi esponenti storici, rientrava nei ranghi del PCI, dopo avervi militato per nove anni dalla fondazione. Extra Ecclesiam nulla salus: “Fu un errore aver rotto con il Partito, poiché i fatti hanno sempre dimostrato che un comunista non ha ragione che nel Partito e con il Partito…”. Ma, non molti anni dopo, nel suo testamento politico – messo proprio come epigrafe all’incipit di questo volume – egli avrebbe riconfermato la sua identità di marxista rivoluzionario internazionalista nulla rinnegando delle lotte condotte “sotto la bandiera di Trotsky e della Quarta Internazionale”. Con una chiosa finale che piuttosto rimandava al valore etico e, aggiungiamo noi, anche esistenziale dell’Utopia.
Quito e l’Ecuador piacevoli porte di accesso al Sud America [Altri percorsi]
 È utile curare il respiro a 2800 metri s.l.m. Il Centro Historico di Quito è visitabile a piedi, magari a tappe. Per vedute panoramiche, suggerirei salire al Panecillo (Panino). Il mammellone, a lato del Centro Historico, partecipa a comporre la corona naturale di rilievi che nascondeva la vista ai nemici dell’abitato primitivo, alle pendici del vulcano Pichincha e d’una cascata. Punto d’osservazione sulla città vecchia e sulla sterminata città nuova, spartiacque ideale tra il Nord e il Sud della metropoli, sviluppata tra gole di vulcani per decine di kilometri. Oltre a bancarelle varie, un’imponente Madonna alata alta trenta metri domina l’altura. Scendendo in città, s’incontrano scene popolari: venditori d’ogni sorta fiancheggiano le strade, agitandosi e ciarlando come nei mercati rionali d’ogni latitudine.
È utile curare il respiro a 2800 metri s.l.m. Il Centro Historico di Quito è visitabile a piedi, magari a tappe. Per vedute panoramiche, suggerirei salire al Panecillo (Panino). Il mammellone, a lato del Centro Historico, partecipa a comporre la corona naturale di rilievi che nascondeva la vista ai nemici dell’abitato primitivo, alle pendici del vulcano Pichincha e d’una cascata. Punto d’osservazione sulla città vecchia e sulla sterminata città nuova, spartiacque ideale tra il Nord e il Sud della metropoli, sviluppata tra gole di vulcani per decine di kilometri. Oltre a bancarelle varie, un’imponente Madonna alata alta trenta metri domina l’altura. Scendendo in città, s’incontrano scene popolari: venditori d’ogni sorta fiancheggiano le strade, agitandosi e ciarlando come nei mercati rionali d’ogni latitudine.
In Quito, – per esteso: San Francisco De Quito – lo spirito francescano offre architetture simili alla Verna nella chiesa convento di San Diego degli Scalzi, con a fianco il Museo “Del Padre Almeida”. Convento un tempo ai margini urbani (ora inglobato) per allontanare i frati dalle tentazioni. L’arguzia francescana, facendo di necessità virtù, dedicò il Museo a un frate impenitente rubacuori e festaiolo, redento da un miracoloso crocifisso ligneo parlante, scocciato da Padre Almeida che l’usava come scala per scavalcare le mura del convento, nottetempo, durante le scappatelle.
Maestosa è la chiesa-monastero omonima dell’antistante Plaza San Francisco (San Diego dei frati Scalzi, simile alla Verna, è ben più contenuto). Il complesso sovrasta un gigantesco “atrio”: alto 4metri, lungo 80, largo 15. Sull’armoniosa architettura del gigantesco manufatto – di proporzioni Vitruviane e dai ricchi arredi artistici interni -, per giustificarne lo sfarzo e i molti soldi spesi, i frati inventarono una leggenda: Cantugna e il diavolo. Cantugna era il costruttore vincolato a ultimare il complesso entro una certa data, oltre cui non avrebbe ricevuto alcun compenso. La notte prima della consegna, i lavori in alto mare, era disperato. Gli si presentò in aiuto il diavolo che gli propose, in cambio dell’anima, di ultimare i lavori per l’indomani. Cantugna accettò, a condizione che ogni pietra fosse collocata al suo posto, nessuna esclusa. Il diavolo accettò e mosse l’inferno. Sul far del giorno era tutto fatto! E il diavolo si presentò a Cantugna per prendersi l’anima. Costui, però, negò quella pretesa: mancava una pietra! Che il birbante aveva divelta di nascosto. Così il diavolo fu sconfitto. Ma taluni, non troppo convinti dalla versione dei frati, ipotizzarono che gli stessi, scavando, avessero trovato tesori nascosti. In effetti, il monastero era sorto sopra l’antico abitato raso al suolo dagli Incas. Terza ipotesi, forse più vera: Cantugna avrebbe scoperto il mitico tesoro Incas, e donato ai frati in cambio d’una cappella ricca di arredi a lui dedicata, costruita lì a fianco.
Si contano poco meno di venti, tra chiese e complessi chiesa-monastero, a presidiare i quartieri cittadini. Opere agibili, destinate a funzioni religiose, benché, alcune, son divenute: musei scuole università uffici. Qualificando un tessuto cittadino ricco, a fianco di altri grandi edifici laici destinati: al Governo, alla Banca Nazionale, al Carcere. Alla visita a collezioni preincaiche, già suggerita, aggiungerei il Museo della Città, dove n’è repertata l’evoluzione. Dai primi insediamenti in capanne alle dimore coloniali dei ricchi latifondisti e pubblici ufficiali; ornamenti e armi primitive a confronto con le temibili armi spagnole; disegni e plastici sulle vessazioni verso i nativi commesse dai conquistadores e i loro eredi, metixos che considerarono senz’anima, inizialmente, i nativi; l’“educazione” data agli indios da religiosi dei vari ordini: imponendo il cristianesimo, la lingua spagnola, e nuove tecniche agricole e artigianali. Colonie Sudamericane sfruttate, per secoli, dalla Corona spagnola con tasse inique, depredando forza lavoro, ricchezze minerarie, e artigianali. Varietà di produzioni tessili, specie in lana alpaca, oggi concentrate nel mercato settimanale coloritissimo di Otavalo. A nord di Quito. Sulla strada, villaggi abitati ancora da sciamani, specchi d’acqua pescosi, varietà di flora e uccelli ambite da frotte di turisti. Fenomeni naturalistici concentrati presso le foreste pluviali a Mindo. Seguendo poi la strada panoramica Panamericana, a destra e manca, splendide gole tra alti vulcani, coltivate e abitate, offrono itinerari alternativi. Verso foreste, fiumi, cascate, remoti villaggi andini e amazzonici, città storiche come Cuenca, buen retiro di pensionati da tutto il mondo, per bellezze architettoniche e clima perenne primaverile. D’interesse, la scesa da Quito al mare di Montagnita e Guayaquil. S’incontrano aree specializzate agricole (famosi i bananeti, e non solo), zone desertiche, e abitati quale Montecristi, dov’è prodotto il famoso cappello Panama superfino. Città natale del liberale modernizzatore Presidente della repubblica (1895-1901), José Eloy Alfaro Delgado, contrastato e trucidato, perché deciso sostenitore dei diritti umani. A lui è dedicato un memoriale. I nativi amazzonici, tutt’oggi, sono mobilitati a difesa del loro habitat, violato da barbari prelievi petroliferi che stanno distruggendo, a ritmi forsennati, siti incontaminati nel polmone del mondo: l’Amazzonia. Prima di arrivare al bel Malecon (Molo lungofiume) nella torrida Guayaquil, seconda città ecuadoriana, si può deviare. Verso la piccola Isla de Plata, impropriamente detta Galapagos dei poveri, dinanzi Puerto Lopez. Tartarughe marine, sule piedi azzurri e altre rare specie aviarie sostano nell’ostile habitat della foresta secca, assistendo paciose a incessanti via vai turistici. Nel mare circostante si pescava coi cormorani, ai quali, stretti i gozzi con anelli, si faceva rigurgitare il pesce a bastonate! Oggi è proibito. Oltre, ci si rilassa nella rivierasca Montagnita – clima festaiolo e onde ambite dai surfisti -, assaltata da giovani freak da tutta l’America, del Nord e del Sud. E, ancora, spiagge sabbiose e scavi arcaici (Las Vegas) nel circondario di Santa Elena. Il volo per casa attende a Guayaquil, che per prima si rese indipendente dagli spagnoli, nel 1820.[Fine]
fabilli1952@gmail.com
Bruno Benigni, prima della carriera curò ideali, impegno, e opere importanti
 Schivo e riservato, di Bruno Benigni ebbi la prima impressione, più che favorevole direi entusiastica, dal dottor Emilio Farina. A Cortona, negli anni Ottanta, eravamo alle prese con seri problemi sanitari, tra cui: l’incontrollato inquinamento da deiezioni suine; la mancanza del depuratore anche per i liquami urbani; e le diatribe sul futuro ospedaliero in Valdichiana, conteso tra Cortona e Castiglion Fiorentino, in previsione della riorganizzazione, per cui sarebbe sopravvissuto un solo ospedale. (In Consiglio Provinciale, il parere sul progetto del nuovo ospedale a Fratta passò con due voti favorevoli, il mio e di Bruno Borgogni, e uno contrario della Consigliera di Foiano, tutti gli altri, dei trenta Consiglieri, astenuti!… per dire il clima pilatesco prevalente).
Schivo e riservato, di Bruno Benigni ebbi la prima impressione, più che favorevole direi entusiastica, dal dottor Emilio Farina. A Cortona, negli anni Ottanta, eravamo alle prese con seri problemi sanitari, tra cui: l’incontrollato inquinamento da deiezioni suine; la mancanza del depuratore anche per i liquami urbani; e le diatribe sul futuro ospedaliero in Valdichiana, conteso tra Cortona e Castiglion Fiorentino, in previsione della riorganizzazione, per cui sarebbe sopravvissuto un solo ospedale. (In Consiglio Provinciale, il parere sul progetto del nuovo ospedale a Fratta passò con due voti favorevoli, il mio e di Bruno Borgogni, e uno contrario della Consigliera di Foiano, tutti gli altri, dei trenta Consiglieri, astenuti!… per dire il clima pilatesco prevalente).
Presidente della Banca popolare di Cortona, Direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, Farina, liberale, mi colpì col giudizio su Benigni, comunista, (che egli ebbe assessore provinciale dal 1970 all’80), elogiandone la coerenza sulla tutela della salute a tutto tondo. Partendo dalla prevenzione, in cui Farina era impegnato, e Benigni gli aveva fornito linee guida e strumenti utili ai suoi compiti. Tra Benigni, di Castiglion Fiorentino, e me, sindaco di Cortona, entrambi comunisti, le occasioni d’incontro prima d’allora erano state poche, tali da non consentirmi un’opinione compiuta sulle capacità del navigato amministratore, salvo la sua fama nazionale acquisita nell’impegno al superamento dei manicomi. Argomento su cui, in Internet, è documentato il valore di Benigni in tema di salute mentale, a cui si dedicò, smesse le vesti d’amministratore pubblico, nel “Centro F. Basaglia” da lui promosso e presieduto. Fino alla campagna a sostegno della legge 81/2014, che fissa la chiusura definitiva degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari), a un anno dalla sua scomparsa, il 21 agosto 2015.
Divenuto assessore regionale alla Sanità, nel 1983, pesai subito il valore di Benigni, conoscitore dei nostri principali assilli territoriali. A distanza di poco tempo, da un progetto all’altro, si presentò con progettisti e finanziamenti già definiti: sia per il depuratore di Monsigliolo, sia per il nuovo distretto socio-sanitario di Camucia. Fin’allora, servizi e uffici, oggi raccolti nella cosiddetta Casa della Salute, erano sparsi in varie sedi, molte non possedute dalla USL. Si trattava d’investimenti, in lire, d’una decina di miliardi. Ciò accadde per semplici convergenze programmatiche. Senza particolari pressioni locali. Benigni – che, primo, adottò un Piano Sanitario regionale toscano – aveva fatto proprie le previsioni del Bilancio di Cortona, valutate in linea con gli indirizzi regionali. In un caso e nell’altro, si trattò di scelte epocali. Soprattutto, sopperire alla mancanza del depuratore rappresentò una novità assoluta, prevedendone l’“uso plurimo”: sia per reflui urbani che animali. Dal medioevo, dello spargimento dei liquami sui fossi, si passava alla modernità del risanamento territoriale. Grazie a Bruno Benigni. Il quale addossò alla Regione i costi principali, altrimenti spettanti al Comune, utilizzando la formula dell’“uso plurimo”. Il Comune era sommerso nella cacca dei suini per una popolazione equivalente a centinaia di migliaia di persone, neanche fosse stata una metropoli!
Dopo l’85, terminato il mandato di sindaco, ed entrato nella sfera d’azione politica provinciale, incontrai più volte Benigni, del quale m’ero fatto piena nozione sui trascorsi alla Provincia di Arezzo e, sul presente, da Assessore regionale toscano e stimato esperto, a livello nazionale, nel settore di sua competenza: la sanità. Competenza non fine a sé stessa, bensì improntata all’attuazione dei principi costituzionali d’una sanità universale, non discriminante le condizioni sociali ed economiche del cittadino-utente. Per l’infrastrutture sanitarie, inoltre, fu determinante sia nel procedimento del nuovo ospedale di Fratta, superando i precedenti nosocomi, sia nel privato, autorizzando il Centro diagnostico “Andrea Cesalpino”, a Terontola.
Delle ultime occasioni d’incontro con Benigni, ricordo la partecipazione da delegati al XIX ultimo Congresso del PCI a Bologna, nel 1990, nel quale, tra mille contrasti, se ne sancì la fine. Benigni cercava, anche da noi più giovani, argomenti per convincersi sulla necessità d’un passaggio su cui era poco convinto. Come l’eravamo in tanti. Convinti della necessaria evoluzione d’una forza politica, ma non della sua liquidazione, che di fatto avvenne. Persa la forma, venne meno anche la sostanza politica: avendo scaricato i ceti sociali di riferimento tradizionali, il mondo del lavoro, e rinunciato alla critica e contrasto alle molte storture del capitalismo. Vidi, nelle reazioni di Benigni, una sofferenza persino fisica a capacitarsi, più di noi giovani, incautamente guasconi, che pensavamo la soluzione adottata la meno peggio, nelle circostanze storiche del crollo del sistema comunista sovietico. Benigni, come la gran massa di attivisti, s’accodò alle direttive del nuovo partito, il PDS. Da cui non ricevette più altri incarichi istituzionali, finita la decennale esperienza regionale. Avrebbe meritato un seggio in Parlamento, che non gli fu offerto. L’evoluzione politica, tra le altre cose, avvenne per far fuori i vecchi dirigenti, senza andare per il sottile, meritevoli o meno non importava. Al Congresso di Bologna, per poco non venne rieletto lo stesso segretario Occhetto! Segnale inquietante, anche se avrebbe meritato d’esser fatto fuori, ma coloro che attendevano di sostituirlo, non so quanto, per Benigni, rispondessero ai suoi criteri di comunista e cattolico severo e rigoroso nell’impegno quotidiano, per sé stesso innanzi tutto, mai dimentico dei ceti sociali più disagiati da difendere. In tal senso, ligio ai suoi principi, rimase un compagno coscienzioso, anteponendo alla carriera un infaticabile impegno.
www.ferrucciofabilli.it