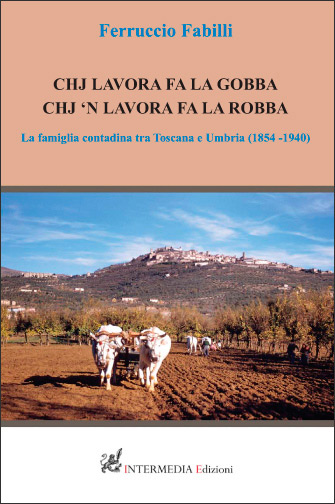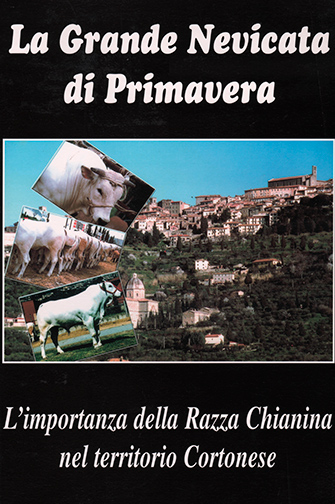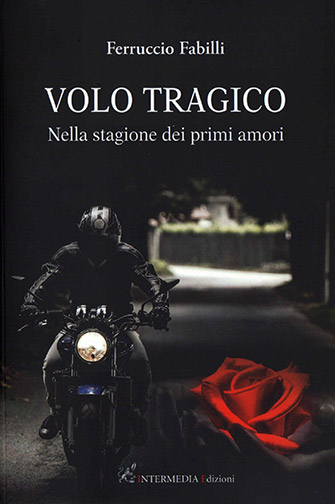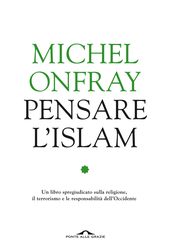Messaggio più recente
“PENSARE L’ISLAM”, NON E’ PIÙ HAREM E ODALISCHE
Dall’Oriente islamico, prima delle minacce terroristiche attuali, arrivava un carico prezioso di curiosità stimolanti. Le figure fantastiche di Mille e una Notte sono nel nostro immaginario al pari dei personaggi dei Fratelli Grimm. A me piace ricordare la poesia persiana di Omar Khayyam, il sufismo della danza e della meditazione, le architetture e gli arabeschi colorati delle splendide costruzioni di Samarcanda, le civiltà Sumera e Babilonese, gli scienziati e filosofi arabi che hanno dato stimoli culturali eccezionali all’Europa medievale, in campo medico, scientifico, filosofico, letterario, risvegliando l’interesse per la cultura classica Greca, i monumenti lasciati nel Sud Italia… insomma l’elenco di suggestioni provenienti dal Medio Oriente sarebbero infinite, insieme, purtroppo, alle Crociate e alle battaglie che per lunghi secoli hanno caratterizzato i rapporti dell’Europa coi suoi vicini arabi, turchi, ecc..
Dall’esotismo dei “profumi d’Oriente alla dura realtà odierna. Siria e Libia son vicine, dove si combattono guerre infinite e crudeli sul cui senso può perdersi anche l’osservatore più attento. Daesh, Isis,Stato Islamico, sono la stessa cosa, curdi, sunniti, sciiti, siriani oppositori e lealisti, russi, iraniani, coalizione occidentale, arabi del Golfo…potrebbe seguitare la lista infinita e inestricabile di contendenti senza venirne a capo. Capire come evolveranno gli scenari, anche solo com’esercizio intellettuale, è impossibile. Alla tragedia dei teatri di guerra aggiungiamo le stragi in Europa, soprattutto in Francia, da Charlie Hebdo al Bataclan, che anche il più distratto osservatore non può non collegare alla questione aperta: il rapporto tra Occidente e l’Islam.
Sto dalla parte chi è sempre contro ogni guerra, in ossequio al più importante comandamento “non uccidere” dall’Afganistan all’Iraq alla Libia, come disapprovo quella contro lo Stato Islamico. Secondo fonti militari americane l’esito a oggi di questi conflitti sarebbe già di quattro milioni di morti, in prevalenza civili (vecchi, donne e bambini), senza contare l’altra tragedia collaterale dei sopravvissuti: l’esodo apocalittico verso l’Europa, costringendola a misurarsi con miserie sue e importate
Sulle cause di tutto ciò convergono analisti di vari schieramenti politici dotati di onestà intellettuale: l’Occidente minaccia i regimi islamici perché “controllano sottosuoli e territori di vitale importanza per il consumismo mondiale e di rilevanza strategica per gli equilibri planetari” e non c’è da meravigliarsi che essi “manifestano la volontà di essere sovrani in casa propria, intendendo vendere il proprio petrolio e i prodotti del sottosuolo al proprio prezzo e autorizzare l’uso delle proprie basi soltanto agli amici, cosa perfettamente legittima, dal momento che il principio della sovranità nazionale non prevede eccezioni”. “Se i diritti dell’uomo fossero la vera ragione degli attacchi […]al fianco degli Stati Uniti, perché non dovremmo attaccare anche altri Paesi che violano i diritti dell’uomo e il diritto internazionale? Perché non bombardare la Cina? E Cuba? L’Arabia Saudita? L’Iran? Il Pakistan? Il Quatar? O anche gli stessi Stati Uniti, in cui si continua ad applicare implacabilmente la pena capitale? O addirittura Israele, che da tempo immemore le risoluzioni dell’ONU condannano per la sua politica di colonizzazione dei territori palestinesi? Basta leggere i rapporti di Amnesty International per scegliere i propri obiettivi: c’è l’imbarazzo della scelta…” Pensieri simili al virgolettato, sulle cause delle guerre in atto, l’ho sentite anche in una trasmissione televisiva da Buttiglione (filoamericano, esponente del Centrodestra italiano), ma, in questo caso, sono di Michel Onfray nel libro Pensare l’Islam, allegato al Corriere della Sera. Di cui consiglierei la lettura.
In questo libro, si da un semplice suggerimento: invece di guardare il manubrio della bicicletta è necessario guardare la strada, che è la storia del perché e percome nascono i conflitti. Di come sia stato “inventato” il terrorismo di Bin Laden, contro l’avventura Sovietica in Afganistan, di come Bush abbia dichiarato guerra all’Iraq, con la sciagurata messinscena all’ONU del generale Pawell ostentando una provetta con false tracce di armi chimiche, non possedute da Saddam Hussein. Tutto ciò in funzione di interessi economici, non certo umanitari, per svuotare arsenali di guerra, provocando quella che il Papa ha definito la “terza guerra mondiale”. Per i soldi!
Già i soldi, gli stessi che con il trattato di Maastricht han fatto virare l’Europa verso un liberismo economico catastrofico, col pretesto del mercato mondiale, aumentando precarietà nel lavoro, disoccupazione, inizio del crollo del Welfare di cui l’Europa, invece, avrebbe dovuto esportare il modello nel mondo. La politica ha abdicato al suo ruolo in favore della finanza, con gli esiti sotto gli occhi di tutti. Il ritorno alle leggi della giungla, degli inizi della industrializzazione. E così l’Europa è entrata in una guerra civile al cui termine non c’è altro che il collasso. Guerra civile e collasso, descritti da Onfray: “i soldi che dominano sovrani, la scomparsa di punti di riferimento etici e morali, l’impunità dei potenti, l’impotenza dei politici, la perdita di senso del sesso, il mercato che detta legge dappertutto, l’analfabetismo di massa, l’ignoranza di chi governa, la scomparsa delle comunità familiari e nazionali in favore delle tribù egoiste locali, la superficialità assunta a regola generale, la passione per i giochi del circo, la perdita del senso di realtà e di trionfo della negazione, il trionfo del sarcasmo, dell’ognuno per sé…” “Una coalizione non è possibile né pensabile. Quando una civiltà collassa e un’altra sembra in piena ascensione planetaria, si crea una relazione tra il più debole e il più forte. E non si è mai visto che un ex forte diventato debole, l’Occidente nel nostro caso, venga considerato con magnanimità, generosità e clemenza dall’ex debole diventato forte..”
Sono queste alcune considerazioni realistiche, osservando i problemi dei due blocchi continentali tra loro contigui, l’Europa e il Medio Oriente, contenute nel libro di Onfray, che affronta pure la questione: è guerra di religione tra Islam e Occidente?
Pur non essendo la causa, ma uno dei corollari usati per giustificare nefandezze compiute su persone e cose. Ogni religione monoteista, cristiana, ebraica, musulmana, nei testi sacri prevede misericordia o morte all’infedele. Soluzioni estreme e contraddittorie, nel corso dei secoli tradotte in drammi. Basti ricordare le Crociate, la decimazione dei nativi americani, l’Inquisizione,…le guerre di espansione islamiche… o violenze descritte nella Torah fin alla questione palestinese.
Michel Onfray, filosofo francese che non disdegna osservare l’attualità , nel libro non trascura le responsabilità delle lobby (industriali del petrolio e degli armamenti in primis) e le debolezze della politica, ma risulta interessante anche nel trattare a fondo i connotati del mondo islamico. Sui quali i media (giornali e televisioni) non si soffermano che su dettagli utili solo a suscitare emotività, far audience e vendere pubblicità (che è l’unico padrone a cui rispondono) non interessati al “pensiero” distaccato, analitico, lucido, indispensabile a farsi una idea su quanto sta accadendo. Come fu irriso il romanzo Sottomissione di Michel Houllebeq, che si svolge in una Francia oramai islamizzata dopo un secondo mandato di Holland, i politicamente corretti gli rimproveravano di annunciare una guerra civile, e, i più spiritosi, gli rinfacciarono che se guerra civile ci fosse stata tra quindici anni la causa sarebbe stata il suo libro! Sfortuna ha voluto che dopo poco l’uscita di quel libro, il 7 gennaio 2015, c’è stata in pieno centro a Parigi la strage dei vignettisti di Charlie Hebdo. Un’operazione terroristica curata in ogni dettaglio militare e politico!
Come semplice invito alla lettura, non intendo riassumere Pensare l’Islam, bensì accennarne elementi d’un contesto molto più denso e vasto che han fatto riflettere prima di me, condividendolo in toto, la redazione del Corriere della Sera che ha dato al libro un sottotitolo significativo: Un libro spregiudicato sulla religione, il terrorismo e le responsabilità dell’Occidente. Compresi suggerimenti come non soccombere alla deriva irrazionale, superficiale, piegata a interessi di parte che caratterizza prese di posizioni politiche pubbliche di “destra” e di “sinistra” trasmesse ed enfatizzate nei media.
Onfray sul futuro è pessimista, partendo dal pensiero sbagliato sull’Islam imperante in Francia (in Italia, lo scenario è quasi identico). Perciò il suo libro è uscito solo all’estero, per non metterlo nel tritacarne mediatico, evocando la scena dei commensali di Voltaire che giocavano con il cretino, finendo gli stessi per concludere la disputa a ruoli invertiti, da furbi a cretini. E i tempi sono tali che Pensare l’Islam non è più solo questione riservata alla elite culturale o ai media, ma è di tutti.
DONATORI DEL SANGUE, IL POPOLO CHE S’AIUTA SENZA RETORICA
Dopo la sera al “Veglione del donatore” dell’AVIS di Tuoro sul Trasimeno, spendo due parole di elogio per tanti volontari che fanno un gran bene donando sangue. Giunti all’età in cui rifuggiamo adunate organizzate da preti o ras politici in cerca di vender storie mirabolanti, riassaporiamo il piacere di condividere l’allegria e la risoluzione d’un popolo di cui sei fiero partecipe: spontaneo non venale, organizzato nel soccorrere in modo anonimo chi è nel bisogno. (A donar sangue, spesso, siamo indotti dal bisogno di amici o parenti, è un percorso molto duro ma efficace).
Il veglione alla Cima, nel bel mezzo del carnevale, in passato era ritrovo mondano di donne e uomini giunti fin da Perugia e dai comuni vicini a cenare e danzare in eleganti abiti da sera. Segno dei tempi, quello sfoggio s’è trasformato in miscela di casual e raffinatezza nel vestire, però quel che resta immutato, anzi pare rafforzato, è lo spirito d’una comunità adunata in festa, una volta l’anno. Presente quasi un abitante su sei del piccolo Comune rivierasco del meraviglioso lago Trasimeno.
Pur trascorsi cinque anni da quando smisi di lavorare in quel Comune e tornato a donar sangue in Valdichiana, ho avuto il piacere di rivedere i tanti che, ieri e oggi, pensano al bene della loro paese, dedicandovi tempo ed energie.
Farò arrabbiare i proibizionisti della caccia, ma come non riconoscere ai cacciatori il merito di aver fornito la cacciagione ed essere stati la colonna portante della complessa organizzazione d’una cena per circa quattrocento commensali. A partire dal cuoco, un cantoniere in pensione, che da venticinque anni presidia la cucina da cui sono usciti cibi generosi per quantità e qualità.
Spezzo una lancia a favore di questa categoria antropologica, i cacciatori, tra cui albergano pure fanatici dello sterminio di specie animali, ma, per gran parte di loro, quest’hobby rappresenta scampagnate, rosticciane, chiacchiere… residui ancestrali del libero star insieme dell’uomo proto cacciatore che aveva l’unico segno nella volontà di sopravvivere…un bisogno umano che, pure assumendo nuove fogge “lo star insieme per sopravvivere”, niente sarà in grado di cancellare.
Gli stessi spiriti liberi di Tuoro, li ritrovi in altri momenti di solidarietà come nella Protezione Civile, l’Antincendio, la Pro Loco… scevri da toni retorici o utilitaristi, perché l’associazionismo è sacrificio. E, ogni tanto, voglia di star insieme per onorare in allegria Bacco e Venere, senza preti o politici autorizzati a mettere il cappello su iniziative laiche che il popolo sente proprie al di là del credo o dell’appartenenza sociale. Momenti felici in cui può capitare, come quest’anno, di dedicare il ricordo a chi faceva parte del gruppo e non c’è più. Ma il cui testimone non s’è perso, bensì raccolto dai superstiti, con affetto e malinconia. Da facce straordinarie, che avrebbero arricchito il campionario di espressioni immortalate nel cinema del grande Fellini. Anche questo è il Veglione del donatore di Tuoro: un Amarcord ruspante.
COLONNE SONORE DELLA NOSTRA VITA PERDONO I LORO INVENTORI
Paul Kantener, dei Jefferson Airplain, è l’ultimo d’una serie di rocker dopo Lou Reed, David Bowie, un componente degli Eagles, … (si sa giunti a una certa età i motori si spengono) che, direi quasi a ritmo battente, ci vanno lasciando, dopo averci regalato suggestioni musicali straordinarie ad alta intensità emotiva, fino da adolescenti (parlo della mia generazione post bellica). I più arditi sperimentatori tra loro, vuoi pure sotto effetti allucinogeni, farmaci, alcol o spericolati frequentatori del sesso… hanno introdotto nuovi linguaggi musicali diventati ben presto collanti emozionali trasversali per l’umanità intera. Sotto forma di musica rock, blues, country, psichedelica, …e, a proposito degli Jefferson Airplain, loro ne hanno spaziato più generi in lungo e in largo con gran maestria.
Non a caso il fenomeno artistico è stato definito genericamente Pop, popolare, avendo compiuto il prodigio di combinare, sparigliare, citare, esasperare musica colta e musica da balera, fino a conquistare la pari dignità del Pop con altre creazioni musicali. Di pari passo noi ascoltatori ne abbiamo seguito i ritmi senza distinzioni di genere, razza, ideologia,… accettando pure argomenti provocatori (a dire il vero, in pochi capivano il senso di tante canzoni cantate soprattutto in inglese), sperimentazioni strumentali e vocalizzi di artisti singoli, più spesso riuniti in complessi, che ci han fatto compagnia nel comune viaggio della vita. Nell’epoca del superamento di molti conformismi e su strade non illuminate più da tante certezze. Diversamente dagli establishment politici, propensi ad assecondare processi condiscendenti a un mondialismo capitalistico cannibale, il rock ha testimoniato che è possibile un altro mondialismo, di tipo umanitario. Dalla parte dell’uomo angosciato, solo, afflitto da ingiustizie o dalla mala sorte, pronto a perdersi in momenti di astrazione da contingenti tensioni esistenziali, vagando su seducenti onde sonore.
In effetti, la musica indicata – diciamo genericamente – come rock, ha comunicato un senso di libertà espressiva prima meno immediatamente tangibile nella musica, mentre nel rock è pure plasticamente visibile nelle danze sfrenate ad essa associate, che rimandano a riti primitivi. Così come la musica rock ha reso consapevolmente partecipi di sentimenti e sensazioni affini mondi e persone lontanissimi…, e così, pur inserita nel business commerciale come qualsiasi altro prodotto consumistico, la musica è stata la colonna sonora della vita di milioni di persone come non era mai accaduto nella dimensione planetaria. Irresistibilmente pervasiva. Liberatrice di aspirazioni, desideri, sogni, sentimenti… contro tabu, inibizioni, proibizioni, conformismi.
Questa musica ha dato la stura a nuovi impulsi che non sono stati solo il piangere nostalgie o il fantasticare sentieri amorosi o il bearsi nell’estatica bellezza delle armonie… Non a caso, in certi momenti e certi regimi politici, la musica rock pop è stata proibita, perché, liberando la mente, è un potenziale dissolutore di vincoli autoritari d’ogni genere. Come c’è il sospetto che anche in regimi democratici alcuni artisti siano stati fatti fuori precocemente quando divenuti scomodi… magari simulando banali incidenti o eccessi di bigottismo da parte di qualcuno…basti ricordare la morte accidentale di John Lennon (perché venuto in contatto con i Black Panthers?)
Certo, resta sempre l’enorme divario tra aspirazioni individuali e quanto offre la vita, ma almeno la musica è capace di far trascendere – anche solo per pochi attimi – dalla dura realtà. Perciò grazie alla straripante forza creativa della prima fantastica generazione di rockettari!…peace and love!
GIUSEPPE FAVILLI gran cerimoniere della Città
Maestro elementare severo, forse meno del collega Alfiero Scarpini – almeno così dicevano gli scolari. A quei tempi a scuola erano in uso scappellotti non censurati dai genitori, caso mai duplicati a casa! Giuseppe, amante dell’ordine e della disciplina, durante le parate non sdegnava indossare la divisa e partecipare alle obbligatorie – quanto ridicole – coreografie fasciste, mentre i ragazzi dovevano far attenzione agli occhi inflessibili dei loro maestri. Alle parate venivano aggregate le scolaresche in funzione estetica – erano scenografici i ragazzi e le ragazze in grembiule o in divisa da Figli della Lupa, Balilla, Giovani Fasciste…– e in funzione pedagogica: “libro e moschetto fascista perfetto”, ai piccoli è bene mettere subito il giogo, da grandi è più difficile.
Crollato il Regime, il maestro seguitò a inquadrare i ragazzi nelle manifestazioni pubbliche e poté prendersi la libertà di seguire gli insegnamenti politici del suo avo: Esaù. Tra i primi dirigenti socialisti cortonesi. Puntiglioso nel districarsi tra le fazioni che lacerarono il socialismo italiano fin dalle origini, in un momento cruciale dello scontro a livello comunale fece addirittura stampare in tipografia le sue posizioni riformiste (il conflitto – ricordiamo – era tra riformisti e massimalisti). Così come, nel secondo dopoguerra, si ripresentò ai socialisti un nuovo dilemma a dividerli: tra “filo-comunisti” e “filo-occidentali”; Giuseppe da azionista, prima, socialista poi, finì socialdemocratico. Tuttavia, nel contesto cittadino, pur prevalendo i comunisti e gli alleati socialisti, a rappresentare Cortona nell’Azienda di Soggiorno fu designato Giuseppe. Bonario, sagace, sornione, sorridente, dalla parlantina facile, divertiva gli ospiti venuti da fuori con discorsi infervorati su storia e bellezze di Cortona.
Come declamavano slogan politici allora in auge: “Marciare divisi per colpire insieme”, Favilli nell’Azienda di Soggiorno – che diresse per anni – e l’Amministrazione comunale, s’incamminarono con successo sulla nuova via dello sviluppo cortonese: il turismo. I mezzi economici erano modesti, ma il contesto si prestava egregiamente allo scopo, tanto da far balzare in pochi anni all’attenzione nazionale e internazionale Cortona come meta turistica e sede per studenti stagionali, provenienti dal nord Europa (inglesi e svizzeri) e dagli Stati Uniti (Georgia University). Il turismo culturale, meno spendaccione nel giorno per giorno – ad esempio, del turismo termale – più stabile e duraturo, alla lunga risultava redditizio.
Un obiettivo sfuggì a Cortona: quel che divenne celebre come “Festival dei due Mondi”, realizzato a Spoleto. Le due città, sostanzialmente, si equivalevano: per qualità e conservazione architettonica e paesistica, e per dotazioni infrastrutturali (teatro, piazze, chiese), ma determinante fu il fattore umano: legami e conoscenze portarono il maestro Menotti a scegliere la città Umbra, anziché Cortona. Di quello smacco, Favilli, se ne doleva spesso, e a buon diritto, però ne trasse insegnamento: nella cura maniacale, ossessiva, delle relazioni personali. Decisive nel trasmettere fiducia all’ospite intenzionato ad avviare a Cortona attività culturali, di studio, o d’altro. Gli amici di Giuseppe sorridevamo dei pistolotti che propinava a gruppi o personaggi ospiti. Farciti di riferimenti culturali e di simpatiche facezie locali, spesso ripetute nel solito ordito. (Anche se in privato sciorinava quantità di storie con cui avrebbe riempito un volume, tutte perse con la sua dipartita). Altra specialità di Giuseppe, pure preso alla sprovvista: se c’era da improvvisare un discorso di circostanza non si sottraeva. Attore consumato, pacatamente in avvio e poi in un crescendo sempre più accalorato – col sorriso stampato nel volto ovale come gli occhiali a goccia, e ai lati della bocca due grumelli scuri di caffè e nicotina delle Stop senza filtro sempre accese – ad ampi gesti, assecondati dalla mimica facciale, illustrava Cortona e adulava gli ospiti occasionali. S’era il caso, dal sorriso virava alla commozione con la stessa efficacia, riuscendo pure a inumidirsi gli occhi. Senza dubbio, era un passionale convinto.
A quel tempo amministrare il Comune o l’Azienda di Soggiorno non erano incarichi remunerativi, ripagati però dalla soddisfazione di piccoli e grandi successi. La modestia nel vivere di Giuseppe era svelata anche dalla trascurata dentizione, distrutta precocemente dalla nicotina e mai del tutto ripristinata. Tuttavia, il fisico florido rivelava ganasce efficienti. Mentre covava un’annosa e grave sofferenza per la cronica malferma salute dell’unica figlia, Laura. Che gli sopravvisse poco tempo.
Per Giuseppe, il compito di cerimoniere e promotore della Città era una missione che svolgeva quotidianamente con religiosa dedizione: ascoltando le critiche degli ospiti e impegnandosi da protagonista su questioni che riteneva potessero compromettere o migliorare l’immagine di Cortona. Esponendosi pure a qualche disavventura.
Come quando incollerito coi giardinieri comunali ch’avevano potato gli alberi della rotonda del Parterre – a suo avviso in modo incongruo -, preso sottobraccio Caldarone Presidente di Circoscrizione lo trascinò sul luogo del misfatto. Sfortuna volle che, nella foga, inciampando, rovinasse a terra, mettendo in imbarazzo l’accompagnatore, scosso dalle risa, mentre lo stava soccorrendo. Altrettanto gustosa fu la polemica tra Giuseppe e il nuovo direttore dell’Etruria, Enzo Lucente. La controversia finì sulle pagine del periodico, che ribattezzò il povero Giuseppe Favilli in Beppe Fava! Non si sa se per svista tipografica o per vendetta editoriale. Esempio di scazzi locali, sale di una comunità, tra protagonisti che non si sottraggono al dovere civico di sostenere a spada tratta i propri punti di vista. Diatribe che, senza venir meno amicizia e rispetto, ogni tanto debordano in dispetto. Oltre al ricordo della simpatia emanata e di qualche impuntatura caratteriale, resta di Favilli il contributo importante a quel ch’è l’odierna fortuna turistica di Cortona, a cui dedicò generosamente tempo ed energie.
QUINTO SANTUCCI, politico appassionato e conservatore di memorie contadine
A fine anni Settanta, condividendo con Quinto Santucci la passione per la conservazione di “documenti” sulla vita contadina, trascorsi con lui molte giornate. Mentre raccoglievo vecchie fotografie familiari da riprodurre e conservare, lui collezionava attrezzi agricoli in disuso. Scoprii così la sua estesa rete di conoscenze di vecchi contadini e la stima che riscuoteva ancora. Rovistando qua e là, aveva riempito un fondo con un’infinità di vecchi strumenti di lavoro, molti prodotti anche direttamente dal contadino che l’usava. Per quanto in apparenza stipati nel caos, Quinto ricordava esattamente di ogni pezzo raccolto non solo l’uso, ma persino da chi l’aveva preso. Dai più semplici attrezzi d’uso (zappe, setacci, rastrelli, falce fienaie, …) alle gigantesche macchine a vapore, perfettamente efficienti, grazie al suo lavoro di restauro e alla consulenza di esperti. La sua passione demo antropologica relativa alla cultura materiale contadina era affiancata e sorretta da una profonda passione politica verso i problemi contadini, che gli era nata da ragazzo. Quando, dagli adulti, fu ammesso alle riunioni segrete in casa di Settimio Mencacci ad ascoltare Radio Londra, e a organizzare le rinascenti leghe contadine. Giovane sveglio, pur con poca scolarità (elementare), apprendeva rapidamente – leggendo e ascoltando i più anziani, come l’esperto in vertenze mezzadrili Federico Liberatori –, perciò fu nominato primo segretario della Camera del Lavoro a Cortona. Composta unitariamente da comunisti, socialisti e democristiani. Salvo pochi dipendenti stipendiati, i dirigenti come Quinto offrivano il loro impegno gratuitamente. Lui ricoprì anche il ruolo di segretario della Federterra, il ramo sindacale specifico dedicato ai mezzadri, ch’ebbe un ruolo straordinario nell’immediato secondo dopoguerra: allorché le vertenze tra padroni e contadini si moltiplicarono esponenzialmente e un rappresentante sindacale interveniva nelle trattative individuali in difesa degli interessi familiari mezzadrili. Di lì a poco, a metà anni Sessanta, la mezzadria fu soppressa, ma fino a quel momento le campagne furono luogo di infinite vertenze.
Quinto era un buon organizzatore, ma anche comiziante, dalla voce sonora e dalla parlantina facile. Dividendosi, in queste attitudini, tra impegno sindacale e di partito. Come carattere, apparteneva ai più intransigenti seguaci politici e sindacali di quegli aspri e concitati momenti, ma non abbandonò mai la sua caratteristica ironia e il buon umore, prendendosi gioco di sé stesso e degli altri. Sorridendo ricordava, ad esempio, un comizio in montagna a Tornia, prima delle elezioni del 1948. Condizionati dal prete, in quella frazione votavano tutti DC. Lui, per farsi ascoltare, si piazzò davanti alla chiesa aspettando la fine della Messa. Dopo aver argomentato le ragioni a favore del voto comunista, concluse con una minaccia: “Badate bene, che se non votate comunista, tornerò quassù e vi prenderò tutti quanti a cazzotti!” I Torgnesi non votarono comunista e Quinto non salì a vendicarsi. La battuta gli era scappata nell’impeto oratorio, essendo lontana la violenza dalla sua cultura, mentre amava paradossi e bizzarrie a scopo retorico e di divertimento.
Quinto e Gabriello Mammoli – dirigenti della Camera del Lavoro – viaggiavano in motocicletta da soli o appaiati (Quinto non guidò mai una vettura, gli ultimi anni viaggiava in Ape) e, robusti com’erano, vederli doveva essere uno spettacolo divertente. Così come spassose erano le loro colazioni nella sede della Camera del Lavoro: fiaschi di vino, pagnotte di pane con alte fette di prosciutto, spalla o salame. Mammoli era così vorace che, una volta che gli donarono una paniera di fichi, se li mangiò tutti a colazione! Colto da forti dolori addominali, fu chiesto l’intervento al primo medico di passaggio: un veterinario. Con mezza purga da vitellino gli passò la colica!
L’attenzione di Quinto alle vicende politiche durò tutta la vita, anche quando, acquistato un podere col fratello Mingo, si dedicò completamente a quel lavoro.
Ogni anno nella sua aia, ripristinando la tradizionale battitura (mangiata finale compresa!), invitava questo o quel dirigente politico o sindacale. Riuscendo ad avere tra gli ospiti i due maggiori leader del momento: Luciano Lama (segretario della CGIL) ed Enrico Berlinguer (segretario del PCI). A Berlinguer rimase così simpatico che gli concesse la parola durante una manifestazione nazionale del PCI, al Teatro Adriano (se ben ricordo) stipato di attivisti. Quell’occasione doveva sancire la fine della “solidarietà nazionale”, per dissensi insanabili tra DC e PCI. E Quinto, attento politico e ancora buon oratore, non demeritò il pulpito. L’indomani, infatti, uno tra i maggiori quotidiani nazionali (mi pare La Repubblica) titolò: “La svolta del Santucci”. Quinto sostenne: “Come i pesci nuotano nell’acqua, così i comunisti stanno nelle lotte politiche” quel colorito rituffarsi nella lotta, sganciandosi dalla maggioranza dell’“astensione comunista”, fece presa. Di lì a poco, morto Berlinguer, Quinto rallentò l’attivismo. Al ritorno dalla manifestazione romana, al suo fianco in corriera, usciti dalla città e visto il dirigibile della Goodyear, mi domandò. “E quello, che è?” Non avevo finito di spiegargli ch’era uno strumento pubblicitario di pneumatici, allorché m’interruppe: “Quello, è utile quant’il Vaticano!” la sua solita ironia corrosiva di sempre, che credeva solo ai “miracoli” scaturiti dal lavoro sudato.
Quinto dimostrò possibile far politica senza trasformarla in mestiere e che la cultura (indispensabile per coprire incarichi politici o sindacali) si può acquisire anche sul campo. E, indipendentemente dalla scolarità ottenuta, si possono raggiungere livelli conoscitivi simili a ricercatori demo-antropologici sfornati dall’università. Non so che fine abbia fatto la sua collezione di attrezzi contadini, ma, non sarebbe male, fosse entrata nel patrimonio d’un Comune che affonda le radici nella cultura contadina.
(Questa è una delle storie contenute nel libro qua sotto)
DON BIETELA, ovvero la debolezza carnale dei parroci
Ivo Camerini ha raccontato come la repentina estinzione di vocazioni sacerdotali risalga a oltre cinquanta anni fa, dopo aver visto Cortona sfornare chierici per secoli. Con il conseguente desolante abbandono e chiusura di chiese in mancanza di preti. Carenza mal risolta dall’immissione di sostituti provenienti da luoghi di “missione” (così definiti da Ivo). Il tracollo vocazionale, d’un botto, fu negli anni Sessanta. Chiuse il seminario e i pochi superstiti volenterosi ebbero asilo ad Arezzo. Senza approfondire le cause (per me, materia ostica), vedo alcuni fattori di quella crisi: la fine della società agro-pastorale, in cui il sacerdote aveva uno status privilegiato; la televisione, insinuatasi in ogni casa come sostituta del prete nel raccontare e interpretare la vita e i fatti nel mondo; e, non ultimo per importanza, il vincolo di castità imposto ai religiosi. Il tabù del sesso. A preti e suore era ed è vietato coniugarsi e far l’amore. Ma, in realtà, come si son comportati, nel tempo, i religiosi col sesso? In Diritto Canonico è previsto che gli attributi dei religiosi maschi, prima della consacrazione, devono essere bene pendentes (lo stesso vale per il papa, controllato a vista dal Camerlengo, prima dell’investitura). Qualcuno, insomma, controlla che le palle religiose risultino ben ciondolanti. Com’è naturale, l’efficienza sessuale provoca quotidiane “tentazioni”… Forse certi eroici prelati saranno riusciti a mortificare la carne, ma circolano un sacco di storie boccaccesche sulle incontinenze sessuali dei parroci passati e presenti, come non son da meno, del resto, le scappatelle delle monache. Se ai bene pendentes aggiungiamo dimensioni dell’attrezzo correlato tali da far appellare il portatore: Don Biétela (da bietola: fittone brozzoloso), la miscela è sessualmente esplosiva. Don Biétela era un bell’uomo, robusto, sportivo, appassionato di motociclette veloci tanto da esserci caduto, sbattendo il cranio su un colonnino di pietra. Rimasto in pericolo di vita, si salvò – si disse – grazie alla zucca d’acciaio. Il suo “sventra papere” era così famoso e ricercato tra le donne da indurre in tentazione persino una zitellona in odor di castità, la quale, non avvezza a certe dimensioni del pene, ne rimase ferita in uno spicciativo intervento emorroidario praticatole da don Biétela. (Il fatto scandaloso destò le ire dello zio prete della vittima, decano del Capitolo diocesano). Quando l’infortunata giunse al pronto soccorso a riparare lo sbrego, i maligni misero in giro lo sberleffo: “Don Biétela s’è messo a fa’ concorrenza al professor Baldelli!” pure lui rettificava sfinteri anali, ma col bisturi e in anestesia. L’incidente ampliò la fama di don Biétela, mentre l’infortunata perpetua seguitò a servirlo… in perpetuo.
Nell’immediato dopoguerra, più tragica fu la sventura capitata alla povera amante d’un prete, Amilcare Caloni, trovata morta sul greto del torrente Esse a causa d’una maldestra pratica abortiva. Montò tale indignazione popolare che un cantautore d’origine cortonesi le dedicò una triste ballata: “Chi gettò la Luna sul Rio?…” canticchiata dai popolani per molto tempo.
Nell’archivio pretorile – alla ricerca di processi politici e sindacali del secondo dopoguerra – m’imbattei in un paio di vicende singolari nelle quali erano implicati parroci, se non colpevoli, comunque in giudizio per questioni di sesso. In un caso, un prete campagnolo svegliandosi la mattina notò una scia di lupini che partendo dalla canonica giungeva a casa d’un’avvenente signora. Era stato oggetto della classica Lupinata. Scie di lupini con le quali buontemponi, nascosti nell’ombra della notte, collegavano abitazioni d’amanti, o presunti tali. (Anche se spesso, in materia di corna, Vox populi c’indovina). La Lupinata era democratica, non risparmiando nessuno: preti, scapoli, sposati, zitelle, vedove… Più che espressione di giudizi morali, erano burle pesanti e invidia a generare quegli sputtanamenti plateali.
Nell’altro caso, sempre in campagna, un prete fu minacciato di morte (o colpito in chissà qual’altra maniera), perché trovato da un baldo e sanguigno giovane a molestargli la sorella dodicenne. Qui non fu tanto Vox populi a muoversi, ma un giovane incazzato che avrebbe colto sul fatto il pedofilo in abito talare.
Nella cronaca minuta di anni fa, si raccontava d’un prete rubizzo che, affiancato a una giovane suora, salendo verso S. Egidio finì fuori strada. Era noto che quella scalata montana non conduceva a un santuario, caso mai a ricettacoli di coppiette in cerca di pace. Ci si domandò: com’è possibile uscir di strada scalando la montagna con una vetturetta – soffocata da due ciccioni – senza pensare a una distrazione?!…
Nell’Archivio diocesano si trova una lettera indirizzata al Vescovo, nella quale lo stesso prete rubizzo dalle pappagorge goderecce invocava un richiamo autorevole ai doveri cristiani verso un giovane macellaio che gli scopava la nipote, in extra coniugio. (Immaginiamo l’imbarazzo del Vescovo a quella richiesta irrituale). Non so se il Vescovo fosse intervenuto in qualche modo. La ragazza carina era attratta dal coetaneo – in seguito mio collega di lavoro – il quale mi confidò che, infischiandosi di tutti, seguitò a curare quel fiore.
Ultima storia. (Per limiti di spazio). Da giovane infermiere – in pausa lavoro – una collega piacente, anche se attempata, mi confidò l’amarezza della vita: fidanzata da anni con Don …, con cui, dato il suo status, non avrebbe potuto convolare alle nozze agognate. Avvicinandosi la pensione e avendo più tempo per l’amore, si sentiva persa!… La Chiesa modifica deliberazioni in tempi così lunghi che né la mia amica infermiera (morta) né io assisteremo alla decisione di togliere l’obbligo del celibato ai religiosi. Facendolo, la Chiesa dimostrerebbe d’aver capita la lezione da tante storie umanissime, uscendo da situazioni a dir poco ridicole, se non già da fenomeni gravi di pedofilia, che stanno investendo il suo sistema dalle fondamenta.
RICORDI SULLA MORTE (ALTRUI)
Nella mente di ognuno, la differenza tra la vita e la morte, riferita ad altre persone conosciute, è saperne l’esistenza e la possibilità o il desiderio di nuovi incontri se vive, mentre, se morte, ci si ingegna a ritualizzarne il distacco fino all’oblio, nella gran parte dei casi. Nel passato non lontano la scomparsa di un individuo era accompagnata dalla partecipazione della famiglia e da una comunità intesa come villaggio o come aggregazione sociale: partito, sindacato, associazione, … Consuetudine quasi scomparsa nell’epoca dell’atomizzazione familiare e sociale; nella stagione caratterizzata dalla solitudine, se non dall’indifferenza (apparente o reale) verso il prossimo. Infatti, non è raro vedere camere ardenti solitarie e funerali altrettanto deserti. Stentando a sopravvivere il senso di appartenenza di ciascun individuo ad una qualunque aggregazione come, in casi estremi, persino alla famiglia.
Quel che non cambierà mai è la singolarità del trapasso, nelle sue infinite espressioni: silenti, dolorose, angosciose, serene,…ogni morte è una storia a sé.
Avevo incontrato la morte, la prima volta in maniera sconvolgente, davanti al cadavere di mio fratello diciassettenne Leonardo che non si era risvegliato da un intervento chirurgico. Il sentimento prevalente, insieme al vuoto affettivo per la perdita del più intimo compagno di vita, fu lo stordimento nell’assurdo. Epilogo tragico nemmeno prospettato come vaga ipotesi dai medici curanti, che pure ebbero le loro responsabilità nel tenere un giovane decine di giorni in trazione col femore rotto e scomposto a causa di una muscolatura atletica, sottovalutandone dolosamente i rischi di una lunga attesa in piena estate in un ospedaletto d’infima qualità.
Passarono alcuni anni da quella frustata emotiva capace di sconvolgere la mente a mia madre e a me stesso, che fui incapace di proseguire gli studi intrapresi di medicina, costretto a ripiegare nella meno ardua formazione infermieristica. (A causa di una decaduta capacità di concentrazione e memorizzazione, indispensabili a governare la vastità nozionistica degli studi medico-chirurgici).
Così ebbi il primo impatto, da tirocinante infermiere, col dolore inteso come sofferenza fisica e psichica in una corsia di ospedale. Mentre accompagnavo un anziano e docile paziente al prelievo bioptico d’un frustolo di fegato, fu lo stesso malato a dire: “Questo ragazzo si sente male!” al medico e all’infermiere che avevano predisposto un siringone dall’enorme ago. L’associazione tra l’odore acre dei disinfettanti e l’impressionante siringa, che entrava nel costato per uscirne con un frustolo sanguinante di fegato, ebbero su me l’effetto d’un principio di svenimento: sudore freddo e pallore, notati dal paziente che avrebbe avuto ben altro a cui interessarsi!… Per fortuna non stramazzai a terra. Circondato da sguardi apprensivi e amorevoli, lentamente mi ripresi e fui in grado di riportare al letto di degenza quel paziente che lesse nel mio caos momentaneo un senso di partecipazione alle sue afflizioni, vere.
Quell’occasione si trasformò in vaccino: d’allora in poi riuscii ad assistere alle quotidiane manipolazioni mediche, anche intervenendo attivamente in situazioni molto crude ordinariamente presenti nella vita ospedaliera, senza più perdere il controllo di me stesso. Non solo, da allora considerai l’empatia con i sofferenti un tramite necessario tra chi assiste professionalmente e i malati che subiscono cure e manipolazioni nelle quotidiane battaglie per riconquistare la salute o per raggiungere tregue più o meno momentanee dalle malattie e dal dolore.
Dolore sparso in ogni angolo dell’ospedale, ma che in alcuni reparti è maggiormente concentrato e acuto, fino ad essere prodromo di morte, più o meno prevedibile. Curando le malattie si ha il vantaggio di prevederne pure il momento dell’evento irreparabile, previsione che, oggi, in molti casi è condivisa con l’interessato.
Un conto è immaginarselo, un conto è vivere in una corsia d’ospedale quale luogo di trapassi. Certo, medici ed infermieri devono costruirsi una solida corazza nell’affrontare quotidianamente lo spengersi di vite umane. Nella gran parte delle situazioni, oltre al malato e ai congiunti che l’assistono, l’infermiere, essendo il traghettatore più presente e conscio dell’imminente trapasso, nel diminuire i patimenti della carne cerca di dispensare parole di sollievo e illusione, finché la realtà non si fa stringente e irreversibile.
Condivido il sentimento comune che la morte migliore è di colui che non se n’avvede, come in un improvviso arresto cardiaco. Anche se, in ospedale, si tenta sempre il tutto per tutto pur di trattenere una vita, spostando sempre più in là il momento finale grazie a nuove tecniche e nuovi farmaci. Però, oltre certi limiti non si potrà mai andare e il trapasso è inevitabile, assumendo quei momenti, per ogni individuo, caratteri diversi, pur tra molte similitudini.
Il decesso intra-operatorio, di cui ho dato conto raccontando la prima esperienza personale, non è molto frequente per la scelta di non intervenire medicalmente senza un minimo di speranza, ed è assimilabile a chi scompare nel sonno. Tra i più “fortunati”. Negli infiniti altri casi avviene una sorta di battaglia, salvo i casi rari di chi attende “serenamente” di andarsene. Una battaglia segnata spesso dal terrore.
Ricordo il caso d’un motociclista deceduto andando a sbattere contro un albero. Trasportato in ospedale, già morto, notammo che nell’impatto fatale gli si erano incanutiti i capelli dallo spavento. Al contrario, l’operaio ucciso, perforando una galleria, da una massa di sabbia pareva addormentato; così come quel giovane motociclista, che, avendo arditamente impennato la motocicletta, s’era ribaltato rompendosi l’osso del collo all’istante. O come l’automobilista che, immettendosi nella strada principale senza avvedersi del sopraggiungere di un altro veicolo a tutta velocità, avendo anch’egli troncato l’osso del collo, pareva immerso in un sonno improvviso.
Dinanzi a quei cadaveri non era raro assistere al maggiore degli strazi nei congiunti; sofferenze improvvise che, mal ritualizzate, provocano effetti devastanti nei sopravvissuti, specie nelle madri di giovani ragazzi e ragazze.
Alla morte in molti casi si oppone resistenza, anche se in situazioni di incoscienza è l’organismo stesso a tentare la sopravvivenza, com’è nel caso di persone in stato comatoso che possono resistere ore, giorni, finanche mesi o anni in quello stato.
Su questi casi, in particolare, è centrato il dibattito sulla necessità d’un chiaro intervento normativo quanto più rispettoso della volontà del paziente (se espressa), o dei congiunti, se non espressa. In certi casi assistiamo ad accanimenti terapeutici, e ritengo non debba essere una “morale” pubblica a stabilirne i limiti, per quanto la gran parte dei medici interviene in soccorso silenzioso e coscienzioso a risolvere la questione: in modo umano e non ipocritamente moralistico.
Ben diversa è la resistenza alla morte in tanti altri casi, come nelle malattie degenerative, durante le quali è forte la volontà di vivere (o di farla finita) dell’interessato. In tali casi intervengono numerosi fattori a determinare i modi nell’affrontare malattie mortali, cercando, il paziente, ogni possibile appiglio più o meno razionale, più o meno confortato da letteratura scientifica. Ricordo i casi di pazienti che si sono appellati a ogni risorsa “terapeutica”, perfino alla stregoneria, a rimedi esoterici o a trattamenti medici non riconosciuti dalla medicina ufficiale. Non è il caso di giudicare, in questi casi, se l’atteggiamento sia più o meno razionale, per me vale il concetto di provarle tutte, senza escludere nulla, possibilmente consigliati da persone amorevoli, senza preconcetti e dotate di un sapere medico che, conoscendo i limiti della scienza, sa quanto possa valere la volontà di un individuo…anche di compiere prodigi, come nelle cosiddette guarigioni inspiegabili, rare, ma che ogni tanto accadono.
Un tale Luigi, di origini cortonesi dai simpatici baffetti, con cui feci amicizia in corsia, aveva contratto una leucemia inesorabile a seguito dell’uso di sostanze chimiche durante trattamenti fitosanitari. Aveva una gran voglia di vivere, ma, oltre le trasfusioni di sangue che lo tennero in vita per una ventina di giorni, non ebbe scampo. Mentre un altro operaio agricolo, vittima anch’egli di intossicazione per prolungati periodi di trattamenti fitosanitari senza adeguate protezioni, resisté solo una notte. Ricoverato la sera per insufficienza renale acuta, interpellato il centro milanese antiveleni di Niguarda, una volta saputo il prodotto manipolato dall’operaio, ce ne fu diagnosticata semplicemente la fine, non aveva e non ebbe scampo.
Più tribolata sembrava la fine degli alcolisti. Molti dei quali erano più volte caduti in episodi di allucinazioni, se non di coma epatico, ma che una volta smaltita la sbornia, riprendendo a bere, finivano per compromettersi gli organi irrimediabilmente. Come nel caso di un giovane barista di Foiano, a cui un edema generalizzato fece scoppiare e macerare la pelle fino alla cachessia finale, o, in molti casi, la causa della morte era lo scoppio incontenibile delle varici esofagee. L’agonia di costoro non durava a lungo, al massimo una intera notte di versamenti sanguigni sotto forma di vomito e feci. Osservando le facce delle assistenti, più spesso le mogli, ne capivi la rassegnazione, avendo vissuto accanto a quegli infelici congiunti da lungo tempo incamminati sulla strada di un lento suicidio. Spesso si trattava di persone giovani, che costringevano a toccare con mano gli effetti della temibile dipendenza alcolica: fisica e psichica, in persone dai caratteri, evidentemente, deboli, e dalle aspettative esistenziali insufficienti a intraprendere la strada della sobrietà. Devo dire, però, che non pochi forti bevitori conosciuti sono giunti fino a tarda età, essendo stati capaci di non superare certi limiti nei consumi alcolici (soprattutto vino) e di non ingurgitare mescolanze pazzesche di liquori (amari, vermout, vinsanti, …), quanto, invece, non erano in grado di fare quegli altri che si bruciavano la vita come un fulminante e non già come una candela…
Anche se molti l’avranno pensato: “non voglio morire!”, ho sentito uscire da poche bocche quell’espressione. Sebbene ci sono stati, magari esprimendosi solo in sguardi; senza distinzione di età o di credo.
Per quanto evento naturale, la morte, nella cultura generalizzata, è un evento temibile e terribile Anche per chi crede questa vita prodromica alla “vera” vita nell’aldilà. Se pure, a tale scopo, avevano orientato la loro etica e il loro spirito di rinuncia a tanti piaceri per raggiungere quell’agognato paradisiaco “aldilà” … ma, nella sua prossimità, la morte raramente è considerata quel sonno eterno e luce perpetua, predicato dalla religione, in attesa della resurrezione, bensì il sentimento prevalente è la fine di tutto, immersi nei tormenti del dolore.
Tanto vale godersi la vita…che già di suo può essere inferno o paradiso.
A me non piace fare facili moralismi affrontando l’argomento della morte. Ho solo un ricordo vivido delle ultime parole del beccaio Renzo rivolto ai congiunti: “Non piangete per me, ché mi sono divertito tanto!”.
Vissuto senza risparmio nella pratica edonistica consentita nel suo ambiente e nel suo momento storico: libertino ruspante e insistito (amava ricambiato le donne), praticando amicizia e convivialità, cercò di non farsi nemici, e trattò il prossimo onestamente, tal che, in punto di morte, fu lui stesso a confortare i propri familiari!
Il ROSSO de’ PINCO, appassionato di macchine agricole e della pastasciutta
In tuta blu e cappellone di paglia, alto e robusto, alle battiture, da “macchinista” era il padrone dell’aia. Mario Lorenzoni, detto il Rosso de’ Pinco (soprannome dei Lorenzoni) dal colore inconfondibile del pelo, per anni, gli era pure garbato il rosso comunista. Passione politica da cui s’allontanò incazzato per lo sgarbo inflittogli dai compagni quando gli tolsero la soddisfazione d’un incarico da bidello part time presso la palestra comunale, procurato dall’amico democristiano Beppe del Frappa (il Tiezzi). Freddamente, sostituito dal compagno Robin Hood, più simpatico ai vertici di partito.
Quel lavoro, era tra i tanti con cui s’ingegnò per mantenere la famiglia. Di suo aveva un trattore – Landini a testa calda – e alcune macchine agricole, con cui lavorava in terreni presi in affitto o per conto terzi, e una piccola sgranatrice del granturco. Un giorno ce lo sfotterono pure: “Tu ce l’hai piccolo!” alludendo alle dimensioni ridotte del suo battitore, ma lui, pronto, rispose: “E’ per mettertelo meglio in culo!…” con persone volgari, non andava per il sottile. Andava in giro con la sgranatrice fino a Seano, in montagna, impiegando un giorno per andare e un giorno per tornare.
Che si trattasse di battere il grano o sgranare mais, nell’aia, il macchinista non era deus ex machina bensì il deus in machina: teneva i ragazzi discosti dai pericoli (pulegge, cignoni, sbattitori, imboccatore,… rischiosi anche allo stazionamento degli adulti) e, con pari autorevolezza, ordinava a ciascuno le mansioni da svolgere. Quel regno provvisorio d’un giorno era consacrato a tavola, dove il macchinista riceveva un trattamento di riguardo: pastasciutta e arrosto a volontà! Lui era pastaio. Pane e pastasciutta, i cibi preferiti. Per una specie di contrappasso, in vecchiaia, s’ammalò di diabete dovendo ridurre al massimo cibi farinacei. In tarda età scoprì pure il gusto per le banane, divenendone fruitore compulsivo. A tavola, insomma, fu un conservatore dai gusti semplici.
Viveva nella passione per i trattori e la campagna. Ogni anno s’aggregava a una comitiva paesana (tra cui i Milani, proprietari e amanti di attrezzi agricoli, e uno noto come “Milanino” ricercato fisarmonicista in feste ruspanti) assidua frequentatrice di fiere. In testa, la preferita era quella di Verona. Per il Rosso, equivalente all’esposizione universale dei balocchi: la più vasta rassegna di meccanica agricola di sua conoscenza. Amico pure dell’altro appassionato Quinto Santucci, coltivatore benestante, dedito a una spettacolare raccolta museale di attrezzi vecchi, tra cui troneggiavano un paio di macchine a vapore rimesse in funzione – ancora in grado di smuovere vecchie battitrici.
Senza pregiudizi, amico di tutti, il Rosso de’ Pinco frequentò pure un Menci, che si diceva discendente d’Angelo Menci (alias “Giuggiolone” o “Vento”) un castiglionese alle cui vicende familiari risaliva il detto popolare: “Faccio come il Menci!” o “Faccio come Giuggiolone!” – come minaccia usata contro un rompicoglioni – che ammazzò tutti i familiari (7), tre vicini, oltre le bestie nella stalla (qualcuno aggiunse pure il gatto!). Chi con oggetti da taglio, chi col fucile. L’origine della tragedia, secondo alcuni, fu la vedovanza di Angelo, allorché la moglie morente l’avrebbe diffidato a risposarsi. Ma lui, disobbedendo, ricostruì una famiglia, con moglie e figli. Un giorno un cane nero gli avrebbe traversato la strada, quel fatto gli fece ribaltare il cervello. Tornato a casa, compì quello sterminio di persone e animali. Il cane nero sarebbe stato la prima moglie riapparsa in quelle sembianze. Altri sostennero che il cane fosse il diavolo… Il diavolo, poveretto, è una presenza costante nelle disgrazie tramandate dal popolo. Un’altra versione addebitò la tragedia agli affari che gli andavano male: non avrebbe retto al pensiero di vedere i figli costretti a mendicare.
Il Rosso amico di tutti, gigante all’apparenza burbero ma di buon cuore, era capace di conservare segreti, non raccontando confidenze ricevute neppure in casa. Riservato, paziente nell’ascolto e nel dispensar buoni consigli o parole consolatrici, insieme ad altre doti nascoste, gli valsero l’intimità di molte donne del circondario, trovandolo complice affidabile dei loro bisogni più o meno confessabili. Segreti che sarebbero finiti sepolti con lui, salvo spifferi usciti dalle concupite, per sputtanarsi a vicenda. Nelle attenzioni femminili non trascurava l’aiuto a preparare dolci, scaldando il forno o rendendosi disponibile per ogni altra evenienza. Piccole disponibilità, come carta moschicida, per ingraziarsi i favori dell’altro sesso.
Sotto i pini di Pinco, vicino casa sua, nella bella stagione si radunava gran parte del vicinato: dai bimbi agli anziani, tutti a raccontar le proprie storie e ascoltarne di altri. Nel gruppo senza leader, si distinguevano: lo spiritoso Migljo dell’Iseleno, giocatore a carte e boccette, Benito detto il Bocca, Bruno Baldi il falegname – che costruiva gratuitamente giochi di legno ai bimbi del caseggiato -, lo Zi’ Nanni, zio di Migljo, vecchio scapolo zio di tutti; e, all’imbrunire, in lontananza un rosario di bestemmie segnalava l’arrivo di Beppe de’ Pinco, che tornava da “spennato” a carte.
Comunisti, fascisti, democristiani,… persone d’ogni età, estrazione, o idea politica, per ore, s’intrattenevano in allegra combriccola all’ombra di via Murata, nel luogo noto come: i pini del Rosso de’ Pinco.
A BUDAPEST ho trovato semplicità e garbo
Viaggiando, ovunque, ci facciamo delle idee abbastanza conclusive su un luogo: piacevole, interessante, niente di nuovo, insignificante, eccezionale,… insomma, da pochi o tanti particolari, diamo un giudizio che fissiamo nella mente con le cose da ricordare, o da sconsigliare nel caso un amico ci chiedesse dove andare o che vedere. Su Budapest, dopo un soggiorno di una settimana, al ritorno ho atteso un po’ di tempo prima di esprimere un’idea.
Pur nella vaghezza del giudizio, direi che ho visitato una città ben organizzata, con gente semplice e garbata. Partendo dalle persone incontrate per strada, nei ristoranti, in albergo, in metropolitana, nei negozi, nei musei,…incontri facce pulite, tranquille, non accigliate, vestite con fantasia, ma senza ostentazione né tanti “trucchi” nelle facce femminili (maschi gender non m’è sembrato di averli incontrati, ma anche fosse stato, anche loro sarebbero stati senza trucco); con una marcata civetteria femminile persino tra donne di una certa età: usano molte minigonne, camuffate pure con pantacollant, o in gambe coperte da calze scure. In effetti, nessuna che abbia visto stonasse in miniabiti, pure in quel clima sempre nuvoloso, di un autunno, per me, rigido e piovigginoso. Lo stesso carattere personale non aggressivo, accogliente, o di tollerante indifferenza s’incontra nello shopping, nella reception dell’albergo, o al ristorante. Molte facce giovani parlano un buon inglese, cortesi, ma senza smancerie.
Quando viaggio non cerco la sorpresa, anche se non mi dispiace imbatterci, ma nella mia giovane accompagnatrice, mia figlia, i primi giorni ha pesato quell’assenza di straordinarietà, al punto di sentirsi quasi pentita d’essere stata lei a scegliere quella meta. Anche se alla fine del viaggio non era più pentita, conscia che l’esperienze di viaggio sono imprevedibili, pur avendo lei stessa studiato in dettaglio i luoghi da vedere.
In alcune guide si fa l’errore di definire Budapest come un ibrido tra Praga e Vienna. Sarebbe più corretto dire che hanno molta storia in comune, ma le similitudini son sempre un azzardo e l’errore della guida condiziona assurde aspettative di banali comparazioni. Sono città fluviali, sono state condizionate dall’impero austro-ungarico, hanno storie di battaglie contro le invasioni turche, consumano molta più birra degli italiani (di quella Ceca si dice sia tra le migliori al mondo), geograficamente sono il cuore d’Europa (Mitteleuropa),…però non c’è dubbio che i “popoli” siano diversi, com’è diversa la loro storia politica e culturale dal secondo dopoguerra. Periodo in cui l’Austria ha rappresentato il di qua dalla “cortina di ferro”, mentre ungheresi e cecoslovacchi sono stati al di là, con quei tentativi di ribellione che ci ricordiamo: nel 1956 quella ungherese, e quella cecoslovacca nel 1968. Anche se il compagno Nando direbbe che in fondo il comunismo non sarebbe stato del tutto inutile per quelle genti, affrancate da smaccate differenze di classe, e instradate a una visione laica della vita, che fa di questi paesi una supposta Mecca dei libertini del sesso. In realtà, sia a Praga che a Budapest, l’eventuale libertinismo sessuale non è spudoratamente ostentato come in molti quartieri tedeschi, olandesi, belgi, ecc.
Un paio di fatti storici pesanti hanno condizionato la diversità ungherese dalle altre due capitali Praga e Vienna. L’Ungheria come l’Austria, dopo la prima guerra mondiale, hanno perso larga parte dei loro territori, ma tale scorporo territoriale, credo, abbia mortificato più di tutti gli ungheresi, o meglio il popolo ungherese sparso qua e là, fino all’attuale Romania. E mentre a Praga c’era una sorta di bilinguismo, per lo meno tra le classi medio – alte, ceco-tedesco (ricordiamo Kafka, scrittore praghese che letterariamente s’espresse in tedesco), e a Vienna – capitale politica e culturale dell’impero – nella prevalenza del tedesco s’incrociavano ceppi linguistici slavi e l’italiano, invece, gli ungheresi erano e sono fieri del loro difficile linguaggio ungaro-finnico, tra le più complicate lingue da imparare. Perciò, non è secondaria la loro forte identità linguistica che si è tradotta in tradizioni identitarie secolari tali da essere stati i primi a volersi liberare dal “giogo” sovietico, così come oggi i loro governanti rifiutano la richiesta di accoglienza proveniente da paesi di cultura islamica, temendo, forse, insieme all’aggravio economico una intrusione che potrebbe rivelarsi dannosa per la conservazione di equilibri nel loro modus vivendi.
L’altra grande differenza, tra Praga e Vienna da un lato e Budapest dall’altro, è che, durante la seconda guerra mondiale, mentre le prime due rimasero sostanzialmente in piedi, Budapest fu quasi rasa al suolo: circa trentatremila edifici furono bombardati, tra cui il Parlamento e l’antico Castello che domina Pest dalla collina di Buda. Fu un danno immenso per una economia non certamente ricchissima. Se si pensa che, a Patto di Varsavia imperante, per acquistare auto Volkswagen ogni anno si dava in cambio ai tedeschi una sterminata coltivazione di cipolle nella Puszta.
Non c’è dubbio che, da sempre, gli ungheresi siano molto laboriosi, come sorridendo mi ha confidato un commessi di negozio: “I miei turni di lavoro, dalle 10 alle 18, sono di 365 giorni all’anno”, in ottimo italiano. Così come una trentina di anni addietro, ad Eger, una delle maggiori città ungheresi, Leonardo, un maturo insegnate di lingue, mi raccontò che per vivere dignitosamente avrebbe svolto ben tre lavori nell’arco delle ventiquattro ore. E che questa consuetudine non era la sua eccezione ma la regola per molti, tantoché un sacco di gente sarebbe morta d’infarto per star dietro a quei ritmi infernali di lavoro!
Budapest ha di nuovo ricostruito il suo Castello, sede della galleria nazionale, dove è raccolta arte antica e moderna, con qualche quadro eccellente anche di pittori italiani, tra cui un Raffaello Sanzio. Come pure è stato ricostruito il Parlamento, sul modello di quello londinese, e, cancellando il tragico sfregio edilizio bellico, sono di nuovo in piedi molti degli edifici in stile Art Nouveau di cui era ricca la città. E, da città colta, non mancano Musei tematici, come quello musicale dedicato a Franz Liszt tra i massimi compositori e maestri ungheresi; o quello ispirato alla memoria della Shoa, in una città dove la presenza ebraica era consistente, si dice che i nazisti usassero i più facoltosi come una specie di Bancomat: cioè invece di procedere a massicce retate, riservate ai più poveri, prendessero di mira di volta in volta i più facoltosi facendosi sborsare soldi in cambio della vita; o l’altro museo dedicato alle due esperienze tragiche: del nazismo e del comunismo, riadattando a museo l’edificio (colorato esternamente di grigio) dove venivano imprigionati e torturati i dissidenti politici. Ancor più suggestivo, perché costruito in una enorme grotta naturale sotto la vecchia Buda, è stato trasformato in museo delle cere l’ospedale sotterraneo in funzione durante la seconda guerra mondiale, restaurando ambienti e creando personaggi di cera che danno la precisa assonanza tra le funzioni del luogo e quanti vi soggiornarono: militari, medici, infermiere, soldati feriti, ecc. a fianco delle attrezzature usate e agli impianti erogatori dell’acqua della elettricità e del condizionamento dell’aria. Esperienza non consigliabile a chi soffra di claustrofobia, ma certamente più intrigante di civettuoli musei delle cere presenti in altre città europee. Agli amici dei social network avevo già segnalato il mio stupore di fronte alla cura puntigliosa con cui sono sparsi in città monumenti, lapidi rievocative, mezzi busti, cippi, ecc. evocanti personaggi illustri della storia locale e nazionale: soldati, artisti, musicisti, letterati, sportivi, giornalisti, uomini politici, ecc. una mappa dettagliata e diffusa di presenze del passato a cui il passante può dedicare qualche attimo di attenzione. (In tale occasione, un amico internauta, mi segnalò il suo ricordo di un capodanno a Budapest in cui assisté in un grande ristorante a un commovente canto – per celebrare il nuovo anno – dell’inno nazionale, tutti visibilmente commossi e partecipi, come prova del forte vincolo popolare al proprio paese).
Per quanto si stiano facendo largo marchi internazionali della ristorazione e della moda, esistono ancora molti negozi di produzioni gastronomiche, enologiche e artigianali tipiche. Così come, a fianco di una ristorazione adattata ai gusti internazionali, si possono trovare locali in cui si gustano cibi tradizionali, mescolati a ungheresi nel momento della loro pausa pranzo.
I servizi di trasporto pubblici sono ben organizzati, estesi a tutta la città, e molto funzionale è la metropolitana, che, mi pare di avere letto, sia stata la prima in Europa ad entrare in funzione. Luogo di incontro e di scambio di giochi di sguardi con facce ordinarie d’una città pulsante, ma non frenetica, così come accade nei pochi grandi centri commerciali visitati (non tanto per la mia, quanto per la curiosità della figlia, dove non c’è nulla che non si trovi in ogni altra città al mondo)
GUIDO CALOSCI una vita immersa nell’odore dell’inchiostro
Operaio tipografo negli anni ’30 del Novecento, deciso a mettersi in proprio, beneficiò indirettamente della Lotteria di Tripoli: allorché l’amico Alfredo Cariaggi – il cortonese vincitore sommerso da una montagna di quattrini – firmò a Guido le cambiali necessarie all’acquisto della locale “Tipografia Commerciale” messa in vendita dal Francini. Si trattava di una pioggia di soldi, ma a metà. Infatti, un altro cortonese riuscì a bloccare in tribunale la metà della vincita, pretendendone la divisione. Alla fine, Cariaggi la spuntò ricevendo anche l’altra metà del malloppo, ma quando il valore della lira era molto svalutato.
I locali della tipografia del nuovo proprietario Guido Calosci – classe 1892 – in via Passerini 4, al primo piano, si rivelarono inadeguati, anzi, pericolosi: incapaci a sostenere il peso delle attrezzature: una mattina, il pesante tagliacarte era precipitato nel piano sottostante! (Più o meno a quell’epoca, per la stessa causa – solai fatiscenti – durante una veglia funebre alcune persone precipitarono col morto al pian terreno).
Essendo costoso far impresa, Guido risparmiò anche sull’acquisto dei caratteri: scelse gli eleganti Elzeviro in quantità appena sufficiente a stampare, al massimo, ottanta pagine (cinque sedicesimi) d’un normale libro. Ricordiamo la pazienza certosina e la precisione richiesta, allora, per stampare una pagina: dovendo assemblare uno ad uno i singoli caratteri di piombo dentro una cornice di legno, detta “vantaggio”, nel formato dell’oggetto da realizzare: locandina, manifesto, rivista, o pagina di libro. Nel caso dei libri, una volta compilate e stampate le prime ottanta pagine, Guido doveva scomporle per riadoperare gli stessi caratteri nell’assemblaggio delle pagine successive; un cuci e scuci insistito fino all’ultima pagina. Non a caso, l’ho definita: “pazienza certosina”. Fino all’avvento delle linotype, paragonare il tipografo al monaco amanuense non è azzardato. E solo metodici alla Guido potevano dedicarsi a quel mestiere. Il quale si fece clienti sparsi in tutta Italia.
A partire da Cortona: il Comune, l’Ospedale, l’Accademia Etrusca, la Banca locale, poi vennero le Università di Palermo, Torino, Roma, Firenze, ecc. specializzandosi in testi di Diritto Romano e di Economia Politica. Volumi da comporre in greco ed anche con complicate formule algebriche. L’apertura del filone produttivo scientifico scaturì dalla pubblicazione d’una tesi di Laurea, premio universitario a uno studente laureato con Lode. Così presero contatti con la tipografia noti docenti: Bonfante, Scialoja, Riccobono, La Pira, Segré, Sensini, Chiazzesi, ecc., che poi incaricavano importanti case editrici per la distribuzione e la vendita.
Problemi a Guido non mancarono. Come quando, ultimata la stampa d’un volume ordinato e pagato dall’“ebreo” torinese prof. Gino Segré, a mezzanotte si presentò il maresciallo dei carabinieri per il sequestro di tutti i volumi – già predisposti nelle casse per la spedizione -, in forza delle leggi razziali che proibivano pubblicazioni d’autori ebrei. Delle casse pronte, il maresciallo suggerì a Guido di nasconderne una per spedirla all’autore-committente una volta passata la “nottata”. E così fu. Caduto il Regime, la cassa dei libri raggiunse Gino Segré.
Non erano segrete le idee “sovversive” di Guido il quale, di famiglia socialista, durante un soggiorno di lavoro a Roma, abbracciò idee comuniste conservandole sempre, convinto dalla scandalosa disparità sociale tra i signoroni che viaggiavano in carrozze trainate da quattro/sei/otto cavalli e i morti di fame che languivano nelle strade della capitale. La categoria dei tipografi rappresentò antifascisti risoluti, fino allo sciopero. Anche a Cortona, gli artigiani – a fianco di operai e contadini – divennero antifascisti strenui e organizzati. Come raccontò Pietro Pancrazi, nella “Piccola Patria”, a proposito delle tipografie cortonesi che, nello stampare volantini o manifesti clandestini, si scambiarono i caratteri per confondere la censura. Pietro Pancrazi fu cliente assiduo di Guido, come il fratello Luigi, di cui si ricorda la battuta scambiata col commediografo Corrado Pavolini, incontrandosi in tipografia: “Anche tu hai questo vizio?!” Accomunati dallo stesso piacere di pubblicare scritti, simboli di vitalità culturale e di libertà.
Pubblicamente Guido dovette adeguarsi, indossando la camicia nera. Minacciato dal Podestà di cancellarlo dai fornitori degli Enti Pubblici, come padre ritenne prioritario far crescere i quattro figli: Enzo, laureato in Fisica alla Normale di Pisa, Adele, Giuseppe – continuatore dell’azienda, cambiandone la ragione sociale, da “Tipografia Commerciale” a “Grafiche Calosci”- e Sonia, che il prete non avrebbe voluto battezzare per quel nome esotico sospetto di filo-bolscevismo. Sebbene fosse il segreto di Pulcinella: Guido seguitava a condividere idee comuniste. Tantoché un dì, in una strada di Cortona, Ceppodomo (produttore di pastasciutta), vedendo Guido in camicia nera, commentò: “Tu sei come i fichi di Sant’Antonio: nero di fuori e rosso dentro!” Anche per i camerati era un rosso di cui, però, non disdegnavano la compagnia. Come quel giorno, nel ristorante al Torreone, riuniti a bisboccia, nel finale del convivio un fascista, fintosi ubriaco, tirò fuori la pistola urlando: “Dobbiamo farla finita con questi sovversivi!” e, premuto il grilletto, sparò a Guido. Il quale, sbiancando, cominciò a tastarsi e, con un filo di voce, pappagellò: “Dove so’ morto?!…” ma lo sparo fu a salve. Oltretutto Guido aveva trascorsi patriottici importanti: combattente nella prima guerra mondiale, e ben tre dei suoi fratelli v’erano rimasti uccisi. Mentre lui era tornato dal fronte sotto un’altra minaccia per la sua vita: la febbre spagnola. Quando nel vagone s’avvidero di lui febbricitante, in men che non si dica, scapparono tutti! Nel locale ospedale-lazzeretto, la malattia decorse benigna, non senza postumi: transitoriamente, Guido era svampito. Il medico, vedendo che ce l’avrebbe fatta, lo prese a cuore e una sera lo portò al Teatro Signorelli, dov’era in scena: “Il cardinale Lambertini”. Nella quale, il cardinale, in confessione, conobbe il vero assassino d’una persona della cui morte, invece, era stato incolpato suo fratello. Al fine di scagionare il congiunto, il cardinale si finse pazzo. A quel punto della commedia, si verificò un siparietto divertente: Guido, pensando che l’attore/cardinale pazzo stesse parlando con lui, iniziò a rispondere, finché l’amico medico fu costretto a portarlo fuori dal teatro.